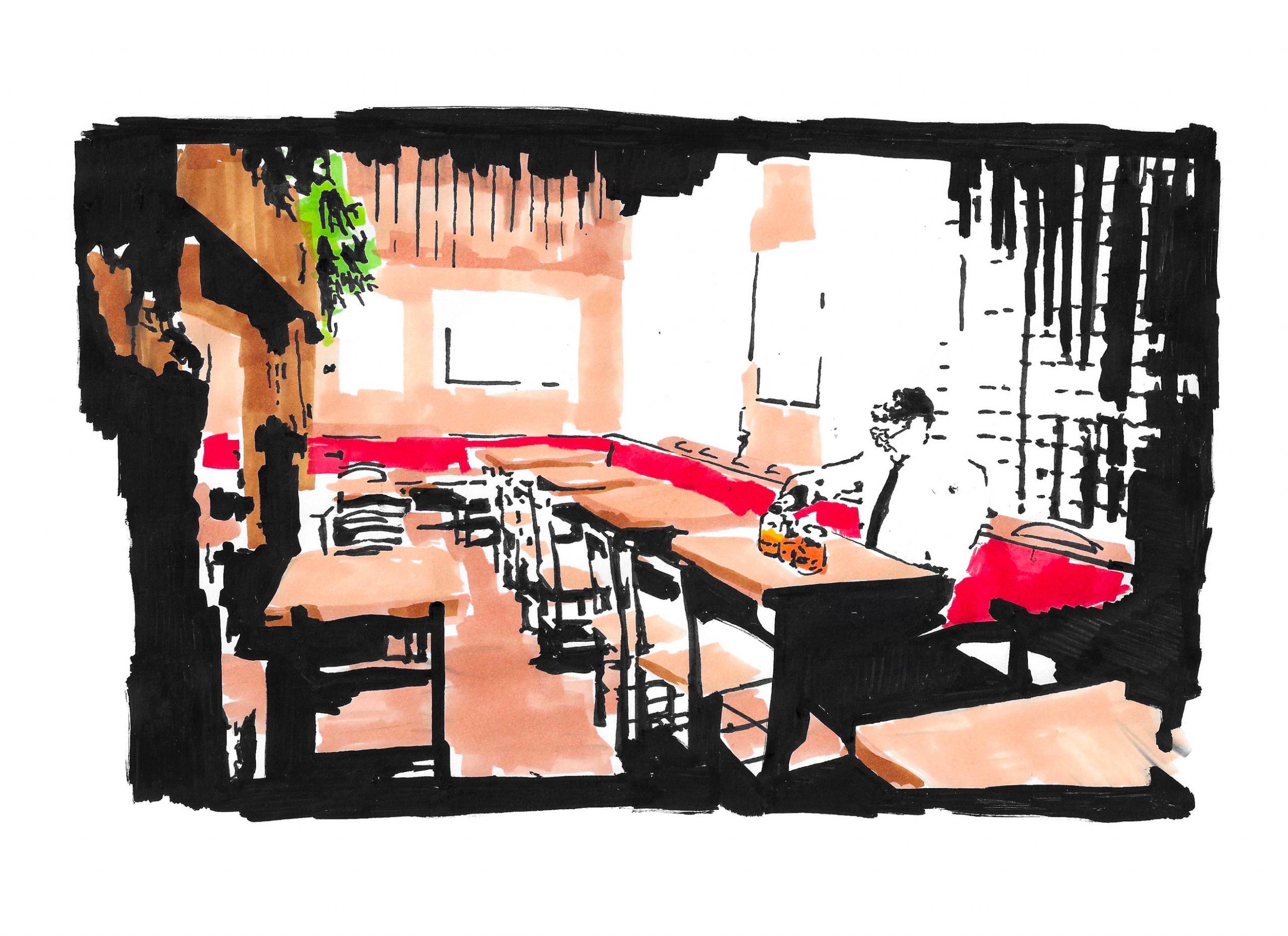Pochi sanno che il Bar Basso, prima di essere il bar più milanese che ci sia, è un pezzo di Dolomiti calato in città. O meglio: la sua natura nasce a Cortina, negli anni in cui Mirko Stocchetto — padre di Maurizio — si faceva le ossa tra shaker e bottiglie nel pieno del fermento mondano. Quando arrivò a Milano nel ’67, si portò dietro quell’esperienza ampezzana fatta di ritmo lento e precisione, di gesti studiati e improvvisazione misurata.
Si era formato all’Harry’s Bar di Venezia durante la guerra, dove conobbe Giuseppe Cipriani che lo avviò alla professione. Poi il trasferimento a Cortina, per guadagnare qualcosa durante la stagione estiva. Da lì, assieme all’amico Renato Hausammann, la gestione dell’Hotel Posta e l’apertura del bar interno, che presto diventò il salotto della valle. Le Olimpiadi del 1956 trasformarono Cortina in un centro del jet set internazionale: un laboratorio di stili di vita e di drink che Mirko avrebbe poi portato a Milano.
«A Cortina mio papà aveva clienti importanti,» racconta Maurizio. «C’era Hemingway, per esempio, che si scolava da solo una bottiglia di champagne ogni sera. C’erano conti, attrici, politici, e colonnelli reduci dalla campagna di Russia. Uno, il colonnello Dalla Noce, si faceva un Martini con vodka e sherry al posto del vermouth: un cocktail che presto prese il suo nome, “il Colonnello”.»
Ecco la montagna nel bicchiere: un sapere che scende a valle e cambia città, ma non carattere.
Se hai 500 ricette, in realtà queste sono tutte varianti di varianti. Come un albero genealogico.

Era avanti di quindici anni rispetto ai bar milanesi. Pulito, preciso, con la calma di chi sa che il ghiaccio ha i suoi tempi. Mirko Stocchetto ha traghettato a Milano una cultura del bere che ha reso la città quella che è oggi.
A Cortina si era formato all’Hotel Posta, tra nobili, attori, imprenditori, politici. Serviva una clientela internazionale, abituata a bere cocktail veri. Milano invece era una città operaia, non turistica. «Qui si beveva Bitter Campari, Punt e Mes, Aperol. I cocktail veri li trovavi solo al Principe di Savoia o al Savini — ma erano luoghi da borghesia alta, da Scala.»
La città però stava cambiando pelle. Era una Milano sospesa tra il boom e la rivoluzione: studenti, architetti, collettivi, donne con la minigonna. Mirko arrivò nel momento giusto: Cortina gli aveva insegnato la misura, Milano gli avrebbe insegnato l’improvvisazione.
La Cortina popolare beveva cose più calde: ponce, Skiwasser, liquori al lampone, grappe alle erbe. Il prosecco non esisteva ancora – o meglio esisteva, ma aveva piccole produzioni locali. Il Bellini si faceva con lo champagne. E fu proprio qui che Mirko iniziò a sperimentare: prese una centrifuga, sostituì la pesca con la fragola e nacque il Rossini. «C’era un concerto di Rossini alla Scala — e così arrivò il nome.» Il Puccini, invece, veniva da Cortina: mandarino fresco, cocktail d’inverno, leggero ma deciso.
Tutti quei cocktail che Mirko faceva all’Hotel Posta — Bellini, Rossini, Puccini — nascevano con lo champagne. Ma a Milano, lo champagne costava come una Lambretta. Mirko allora inventò versioni più “democratiche”. Stessa frutta, spumante al posto dello champagne e una spruzzata di vodka per dare carattere. «Non erano copie economiche,» dice Maurizio. «Erano reinterpretazioni popolari.» E ai nuovi drink servivano nomi nuovi: Perseghetto (dal “persegh”, pesca in milanese), Fragolino, Clementino.
Se hai 500 ricette, dice Maurizio, in realtà queste sono tutte varianti di varianti. «Come un albero genealogico: in basso gin, vodka e rum, e poi tutte le ramificazioni.» Mentre lo dice, apre le mani grandi e mima i rami di questo albero immaginario. «Nessuno impara i cocktail a memoria. Impari le basi, poi capisci come ricostruire le combinazioni. È come conoscere la grammatica di un linguaggio.»
Papà ragionava allo stesso modo: il Negroni Sbagliato è nato così. Un errore trasformato in slogan.
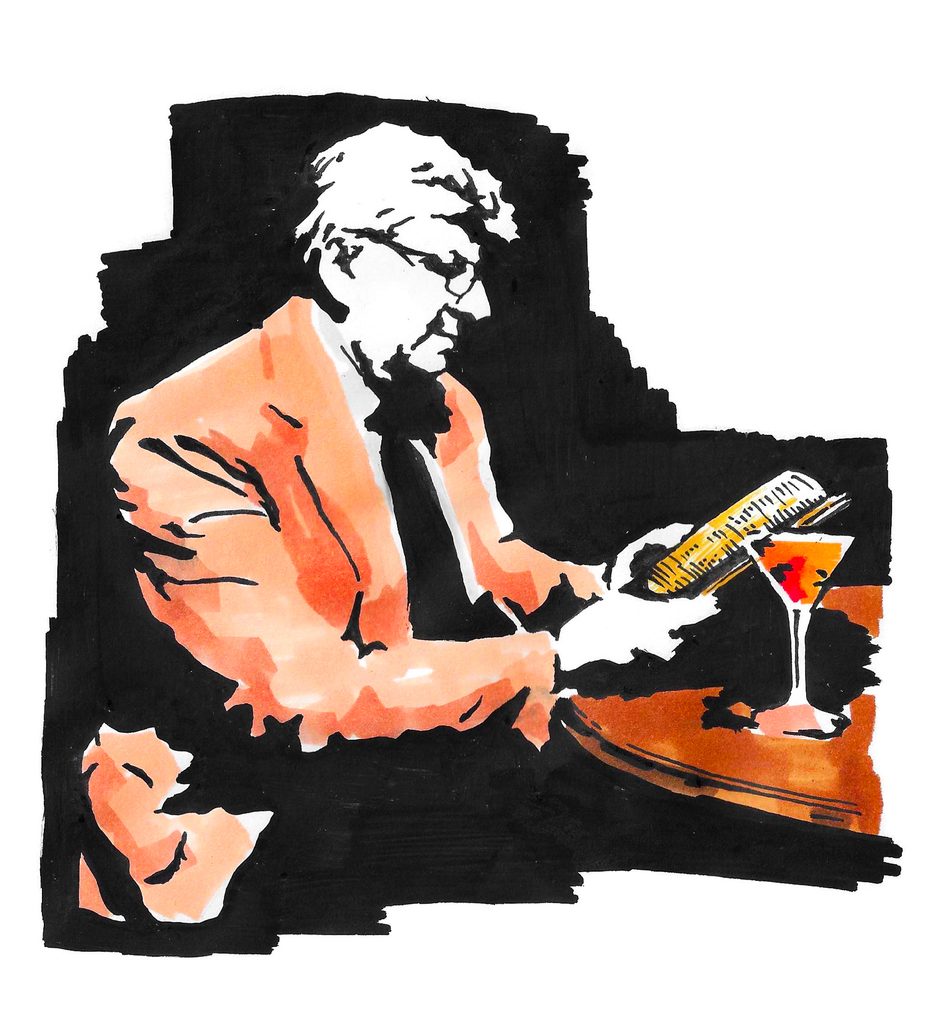
Mirko aveva anche il talento del naming. Capiva che un nome buono resta più di una ricetta. «Tipo Armando Testa: “Bambina, sei già mia. Chiudi il gas e vieni via.”», dice Maurizio. La frase è di una storica pubblicità anni ’60 del caffè Paulista. Andava in onda su Carosello e vedeva il Caballero misterioso corteggiare Carmencita in uno stile ironico e romantico, diventando un tormentone dell’epoca.
«Papà ragionava allo stesso modo: il Negroni Sbagliato è nato così. Un errore trasformato in slogan.» Lo Sbagliato, infatti, nacque per caso, con lo spumante al posto del gin. Così almeno vuole la leggenda. Quel che è sicuro è che Milano lo adottò subito. Città distratta, efficiente, sempre pronta a trasformare un errore in un marchio.
Sul tavolo, Maurizio appoggia il bicchiere e lo guarda come se dentro ci fosse la geografia della sua vita. Negli anni Sessanta, il bar era un territorio maschile. Le donne non sedevano al banco. Si mettevano ai tavolini, con la borsetta sulle ginocchia e lo sguardo basso. «L’immagine della femme fatale che entra e ordina un Manhattan era roba da film. Qui, la realtà era un’altra.»
Poi arrivò il ’68, e con lui le minigonne, le studentesse e le prime copywriter della pubblicità.
Le donne iniziarono a entrare nei bar e a chiedere drink più light, più gentili. Mirko li inventava come risposte. Le signore all’epoca bevevano leggero, non erano come gli uomini che si sparavano whisky e bourbon. Bevevano il Mimosa, ad esempio: succo d’arancia e bollicine. Da lì il successo dei cocktail più dolci, come il Fragolino, che conquistò il pubblico femminile e quindi una buona fetta del mercato nascente. I cocktail, allora, non erano formule. Erano conversazioni.
«Ognuno chiedeva la sua variazione: più rosso, meno dolce, shakerato o no. Poi c’erano anche cocktail che andavano di moda ma che oggi sono decisamente démodé, come l’Alexander, fatto con panna liquida, crema di cacao bianca e brandy. O il Grasshopper, long drink cremoso con crème de menthe, crema di cacao bianca, panna fresca e ghiaccio. Poi è arrivata Jane Fonda e l’aerobica, e tutto è finito lì.»
La pigrizia del bere è aumentata, ma il mestiere del barman resta lo stesso: capire le persone prima di servirle.

Il bere aveva le sue fasce orarie. Negroni solo all’aperitivo, mai dopo le otto. Whisky dopo cena, Fernet per digerire. «Oggi invece puoi bere uno Spritz a mezzanotte e nessuno si scandalizza. La pigrizia del bere è aumentata, ma il mestiere del barman resta lo stesso: capire le persone prima di servirle.»
Il Bar Basso, oggi, conserva un riverbero lontano della montagna. Fuori sfrecciano scooter e macchine nervose, dentro il tempo si prende una pausa. Qui nessuno guarda il telefono: si parla, si ascolta, si blatera, si schiamazza. Mentre finisco di parlare con Maurizio, mi accorgo che le facce attorno a noi sono cambiate. Maurizio si muove nel locale come uno che sa tenere il ritmo e difende quel pezzo di mondo come si difende un confine.
Guardo il ghiaccio nel mio bicchiere sciogliersi e sento ancora l’eco di Cortina rimbalzare nel tintinnio dietro il bancone. Ogni cocktail è una salita, una discesa e, ogni tanto, uno sbaglio — ma qui lo sbaglio, per fortuna, è sempre quello giusto.