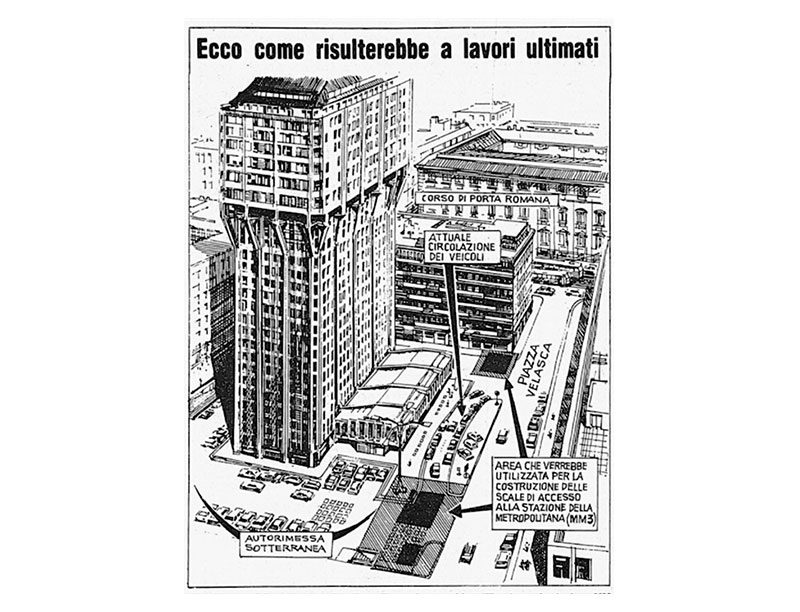C’è stato un tempo in cui la Torre Velasca faceva paura. Letteralmente. Negli anni Sessanta, mentre Milano si dava un tono da capitale industriale europea, quel fungo rosa di cemento armato spuntato accanto al Duomo, sembrava un incubo modernista scappato da un brutto sogno post-bellico. Troppo alta, troppo brutta, troppo medievale per i fan del razionalismo puro. Eppure oggi, dopo il restauro firmato Hines e Asti Architetti, rieccola lì: lucidata, impacchettata in un’identità da landmark. Un’icona da cartolina. O da vetrina.
Costruita tra il 1956 e il 1958 dallo studio BBPR – Banfi, Belgiojoso, Peressutti e Rogers – la torre è stata un colpo di teatro architettonico. I suoi autori avevano visto l’orrore dei campi di concentramento, avevano attraversato le rovine di una guerra che aveva sbriciolato mezza Milano. Avevano bisogno di rompere con tutto, ma senza dimenticare. Il loro modernismo, a quel punto, non poteva più essere un dogma. E così eccola, la citazione storica: il basamento snello, per uffici; la testa larga, con i suoi contrafforti da rocca viscontea, per ospitare gli appartamenti. Una torre razionale che però guarda ai merli delle case-torri medievali. Un ibrido. Un pugno in un occhio per il Movimento Moderno. Talmente eretica, la torre, che fu il motivo per cui il gruppo BBPR venne ostracizzato da Le Corbusier e dai suoi discepoli. Avevano osato troppo. Avevano osato mettere la storia in mezzo alla modernità.
Ma la Velasca è anche un trauma formalizzato. Una sagoma che sapeva di minaccia: la testa gonfia, larga, instabile come un’esplosione congelata.
Ma la Velasca è anche un trauma formalizzato. Una sagoma che sapeva di minaccia: la testa gonfia, larga, instabile, come un’esplosione congelata — forse un richiamo inconscio ai funghi atomici sganciati sul Giappone dieci anni prima. Per chi, come me, ha frequentato il Politecnico di Milano e ha studiato storia del design, sa bene che la forma del fungo è stata un chiodo fisso nel panorama progettuale italiano degli anni Sessanta. Personalmente, infatti, non ho mai pensato fosse un caso che questa ossessione ricorresse proprio negli oggetti domestici che brillano per definizione: le lampade.
La lampada Nesso di Giancarlo Mattioli (1965), con la sua luce arancio satura e inquieta. La Pipistrello di Gae Aulenti (1967), una creatura telescopica, imponente. La Lesbo di Angelo Mangiarotti (1967), che sembra uscita da un capitolo de Il gran sole di Hiroshima (K. Bruckner, Feltrinelli, 1964). E poi Carlo Nason, e l’intera stirpe delle lampade fungiformi che spopolano negli interni italiani del dopoguerra. Una forma archetipica, perturbante, che rimanda al potere distruttivo della modernità. Anche la Velasca, in fondo, è una lampada spenta. O meglio, una minaccia luminosa che ha perso energia.
Dopo la sua consacrazione simbolica, la Torre Velasca ha vissuto un lungo tempo di oblio. Un’assenza silenziosa nel pieno centro cittadino. Le luci degli uffici si sono spente. Gli appartamenti svuotati. I piani alti chiusi. L’accesso negato. Per anni è stata solo una sagoma da cartolina, intrappolata dietro reti di protezione, una rovina urbana in attesa di riqualificazione. E nel frattempo la città correva, cambiava pelle, si verticalizzava altrove. La Torre, invece, era lì: troppo identitaria per essere demolita, troppo scomoda per essere abitata. Una reliquia del Moderno impossibile da rimuovere. Il suo restauro arriva dopo anni di inaccessibilità totale. E questo passato di isolamento pesa quanto l’immaginario che si porta dietro.
Il nuovo progetto la trasforma in un corpo privato. Retail di lusso in basso, uffici nei piani centrali, residenze deluxe nella parte alta. La distribuzione funzionale è la stessa di sempre, ma aggiornata in chiave immobiliare. Vista panoramica per pochi, ingressi filtrati, spazi disegnati per utenti ad alta capacità di spesa. Riapre, sì, ma non per noi. Non per Milano. Riapre come icona monolitica, come trofeo urbano. È ancora un simbolo della città, ma un simbolo che oggi racconta più di tutto l’esclusione.
Cosa ci dice oggi la Torre Velasca? Forse che anche le icone sono spazi contesi. Che l’architettura non è mai neutra.
Eppure la Velasca è anche molto di più. Non solo una minaccia sublimata in estetica o un promemoria dell’ansia nucleare, ma anche un punto di svolta nella grammatica del Moderno a Milano. Dopo di lei, il Moderno smette di essere uno stile e diventa un linguaggio aperto, incoerente, stratificato. Milano non è né Roma né Torino. Non ha l’antichità né l’ordine industriale. Ha la contraddizione.
Allora cosa ci dice oggi la Torre Velasca? Forse che anche le icone sono spazi contesi. Che l’architettura non è mai neutra. Che il problema non sono i mostri sacri, ma il culto che ne facciamo, quando li trasformiamo in totem di lusso, svuotati di ogni accessibilità. E che Milano, se vuole ancora ricordarsi chi è, dovrebbe tornare a costruire luoghi imperfetti, discussi, vivi. Luoghi dove l’errore non si rimuove, ma si abita.