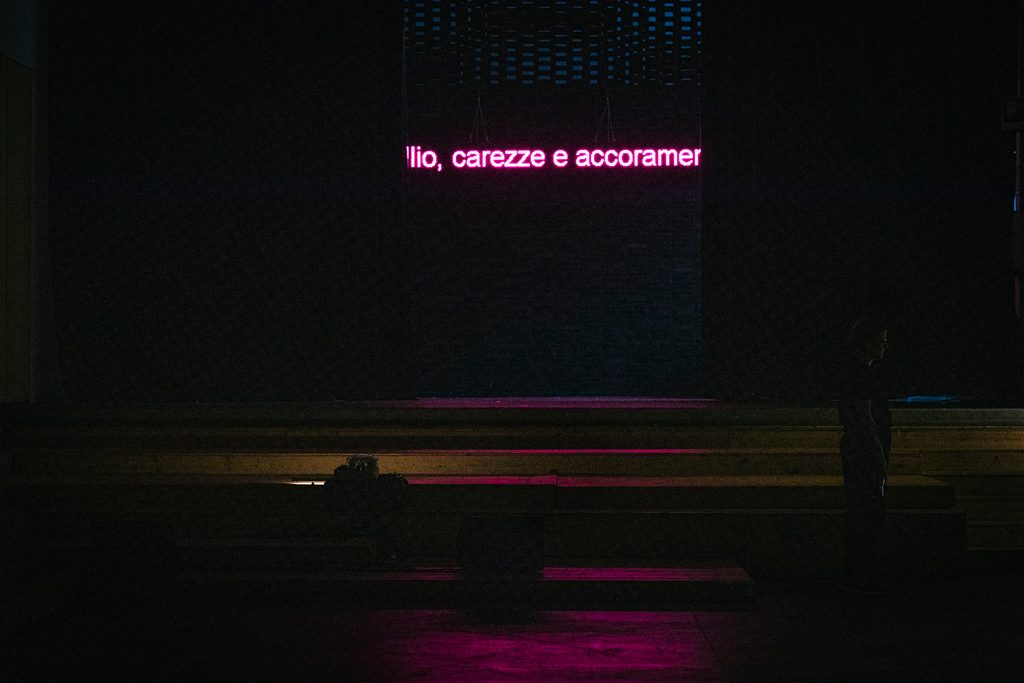Da Indisciplinarte, co-fondata nel 2007 per gestire CAOS negli spazi dell’ex-SIRI di Terni, alla Manifattura Tabacchi di Cagliari, arrivando a BASE Milano nel 2020, Linda Di Pietro ha esplorato e modellato la professione del manager culturale. Oggi ci racconta le linee guida e i valori che sostengono il suo lavoro quotidiano e quella collaborazione con Volvo Studio Milano che regala uno spazio altro alla sperimentazione.
Provo oggi a pensare in grande e lavorare su una scala piccola, andare dietro e sotto alle cose, dentro le crepe, dove fermenta tutto.
Mi sembra che tu abbia avuto un percorso ricco di sfide e scelte inattese: sei stata tra le prime manager per la cultura in Italia, quando ancora unire economia e cultura non era così diffuso.
Un po’ è vero, soprattutto ho unito la dimensione manageriale-gestionale all’interesse per la rigenerazione urbana con base culturale. Ho lavorato sempre su spazi abbandonati, dismessi, che potessero essere riconsegnati alla città attraverso l’arte e l’intervento di artisti, architetti e designer. Sono stati progetti complessi che, oltre la dimensione artistica, si basavano su visioni sistemiche di sviluppo territoriale, dove l’artista diventa uno degli attori coinvolti nel processo. Chiaramente devono essere artisti e artiste disponibili a fare un ragionamento a lungo termine e condiviso, dove la dimensione ideativa del singolo (anche molto individualistica, l’artista nell’accezione novecentesca), piano piano si diluisce in un processo curatoriale collettivo, una costellazione. Infatti non sono mai stata sola. Siamo tante e tanti che negli ultimi quindici anni abbiamo provato a intercettare queste diverse professioni e a metterle insieme. All’inizio non sapevamo bene cosa stavamo facendo e tantomeno dargli un nome, un’etichetta. Poi a un certo punto si è iniziato a chiamarlo management culturale, e ho capito che era nata una professione nuova, che cercava di tenere il passo ai cambiamenti del mondo. La prima volta che l’ho letto in un bando pubblico, uscito a Cagliari nel 2018 per la gestione della Manifattura Tabacchi, mi sono detta: “ma io queste cose le so fare!” e loro gli hanno dato un nome. E dare un nome alle cose significa farle esistere.
Facendo un passo indietro, come ti sei avvicinata all’arte?
È una passione familiare, frequentata e praticata. Mi sono inizialmente dedicata alla danza contemporanea, poi ho studiato scienze della comunicazione e progettazione culturale. Questi tre elementi si sono così spontaneamente intrecciati. Ho studiato anche arts management in un anno di studi all’estero in Inghilterra. All’epoca non sapevo nemmeno perché avevo deciso di passare un anno in una business school, semplicemente volevo vedere una realtà che in Italia non c’era. Mi si è aperto un mondo! Quando sono tornata, e continuavo a danzare ma anche ad occuparmi della gestione di enti legati alla danza, ho provato a pensarmi come progettista culturale.
Ti faccio due domande a partire da un video pubblicato dalla Farnesina. Ci sono due punti che mi hanno colpita: in primo luogo vieni presentata come persona che “costruisce case sugli alberi”. Cosa intendono?
[Ride, ndr] Eh sì, era Foresta uno dei progetti più iconici del periodo di Terni, un lavoro biennale realizzato in collaborazione con Leonardo Delogu, artista che lavora sull’itineranza e sulle camminate come strumento drammaturgico. Un giorno ci siamo accorti di alcuni tigli potati male che avevano delle forme particolari, come mani aperte. Ci guardiamo e lui mi dice “potremmo metterci delle case”, e ne ridiamo. Eppure dopo tre mesi stavamo lanciando una call internazionale per architetti autocostruttori, per la creazione di cinque case sugli alberi che avrebbero ospitato altrettanti artisti e artiste, i quali, come Cosimo de Il Barone Rampante [libro di Italo Calvino del 1957, ndr], avrebbero osservato la città dall’alto per dieci giorni. Nel 2016 abbiamo costruito le case, nel 2017 invece abbiamo riportato le loro pratiche “a terra”, nel territorio. La casa sull’albero si è rivelata elemento potentissimo perché si sprigionasse una dimensione desiderativa atavica, infantile ma non dimenticata.
Mi è rimasta impresso anche il monito con cui ricordi l’importanza di stare sempre dalla parte degli artisti.
Si, questo imperativo si è consolidato e raffinato, arrivando a quello che facciamo oggi qui a BASE. Con le artiste e gli artisti, che portano una pratica e un pensiero, stiamo costruendo diverse linee progettuali. Milano è una città centrifuga, spinge fuori, slabbra le comunità, rende complesso trovarsi. La reazione ci porta a stabilire connessioni che mostrino BASE come un luogo aperto, accessibile, dove stare senza necessariamente produrre, anche per gli artisti. Spostiamo l’accento da prodotto a processo, ospitando continuamente residenze, grazie all’ampiezza dei nostri spazi. Per esempio all’interno del festival Farout gli artisti e le artiste hanno curato una giornata intera, dedicata al tempo e alla storia orale. Io da sola non l’avrei mai immaginata, e insieme abbiamo capito che era possibile.
Mi spieghi in pratica cosa comporta il tuo ruolo a BASE?
Concorro a definire le strategie culturali di BASE, immaginando cornici tematiche e
costruendo linee di progettazione che poi si traducono in attività concrete, un lavoro di prefigurazione, progettazione e azione. Abbiamo un tavolo di sviluppo che si riunisce tutte le settimane, intorno al quale ragioniamo sulle tematiche e le linee di evoluzione semestrali e triennali, lungo un doppio binario. BASE è come un organismo vivente che si modifica costantemente, per questo la programmazione culturale si costruisce su archi di lavoro semestrali dentro linee di sviluppo triennali. Costruiamo cornici di senso dentro le quali poi lavoriamo a coppie, a trii, per esempio sul Design insieme a Giulia Cugnasca e la co-curatrice in residenza Erica Petrillo o sull’Estate con Lorenzo Carni, con l’idea di sganciare la figura del direttore artistico dall’individualità di un singolo.
Quando e come nasce la relazione tra BASE e Volvo Studio Milano?
Ormai ci parliamo da un annetto, ed è una collaborazione molto interessante per BASE, secondo me, perché rispecchia il nostro carattere multidisciplinare e ibrido, tanto che le proposte che facciamo a Volvo sono sempre diverse. Siamo partiti dalla musica ma abbiamo agganciato subito i talk con gli artisti e le artiste, iniziando con Claire Fontaine, per l’art week scorsa. E poi ci sono stati i Mombao, che aggiungono alla musica elettronica e folklorica una dimensione coreografica forte.
Arriviamo poi a quest’ultimo progetto a quattro mani con Volvo e dedicato all’errore [la prima serata di Ho sbagliato tante volte si è tenuta il 24 novembre, ndr] che è frutto di un’altra costellazione, perché BASE da tanti anni dialoga con Monserrat F. Blanco, esperta di fallimento con le sue celebri Fuckup Nights. Ora abbiamo traghettato questo format da Volvo Studio, che si configura per noi come una piattaforma sperimentale, dove portiamo i nostri eventi in una scala diversa, in un contesto diverso, con la sua meravigliosa finestra sul mondo.
Da questa collaborazione con Volvo che opportunità reciproche nascono secondo te?
Noi aggiungiamo un po’ di follia, di imprevisto, che però, devo dire, loro sono molto coraggiosi ad accogliere. Alla base c’è una bella fiducia reciproca che permette di scommettere sulle proposte più audaci. Consideriamo anche che BASE è un progetto relativamente giovane e in costante evoluzione, mentre Volvo Car Italia è un’azienda solidissima, dalla quale si può imparare molto attraverso questo confronto, a proposito di valori come il rigore, la stabilità e l’affidabilità.
Immagino tu viva a Milano da circa tre anni. Che rapporto hai con la città?
Si, sono a BASE da tre anni, ma non vivo a Milano, o forse, sì, vivo a Milano. Però una settimana sì e una no, e quella no torno a Terni. Sono una mamma e mio figlio, di dodici anni, vive a Terni. È impegnativo far accettare universalmente che anche una donna, madre, possa fare una scelta del genere. Talvolta penso che sarebbe utile essere fissa qui, ma allo stesso tempo questa mobilità mi aiuta a guardare la città da fuori, non stare troppo tempo al centro del vortice. Già lo dicevamo, la città rischia di essere espulsiva rispetto a realtà sociali meravigliose o fasce di popolazione più fragili, e ciò appare involontario ma sistematico. Troppe cose interessanti ormai succedono fuori, e con BASE cerchiamo di lavorare a costruire collaborazioni con i presidi culturali dei quartieri limitrofi, con il Barrio’s, con Milano Mediterranea, creando ponti che superano la linea della 90. Io, dalla provincia, so che lavorare in scala è tutto, dall’urbanistica alle relazioni umane, e provo oggi a pensare in grande e lavorare su una scala piccola, andare dietro e sotto alle cose, dentro le crepe, dove fermenta tutto.