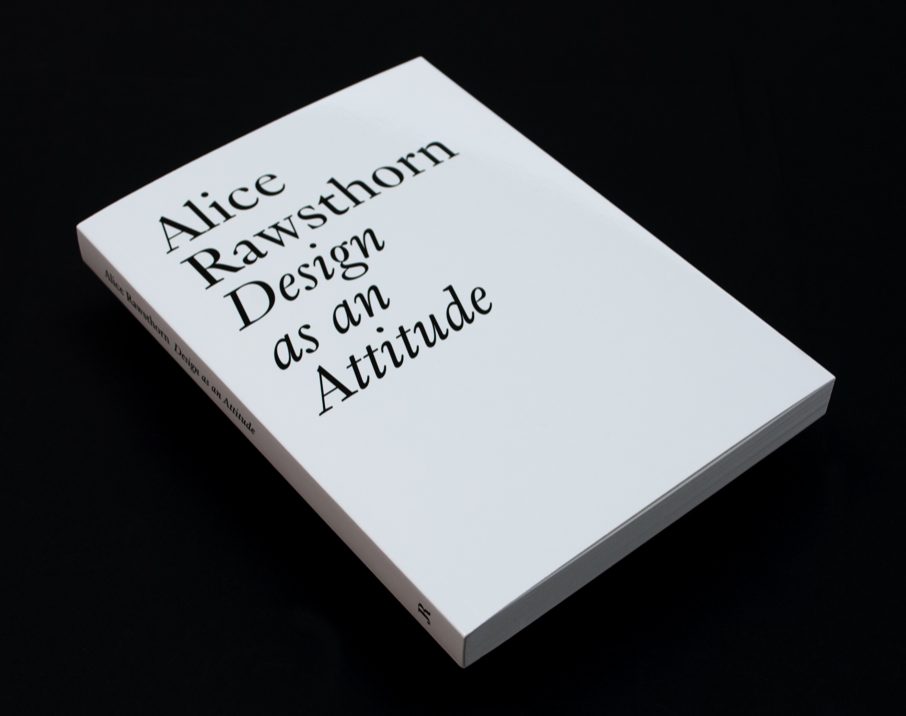Alice Rawsthorn è una delle più influenti critiche contemporanee di design. Autrice acclamata di numerose pubblicazioni premiate dalla critica – come Hello World e Design as an Attitude –, Alice vede il design come una lente per filtrare e osservare la realtà, come una forza creativa “onnipresente” e sempre pronta a emergere.
La sua pubblicazione più recente è il libro Design Emergency: Building a Better Future: un progetto – diventato anche un podcast – sviluppato insieme a Paola Antonelli, senior curator del MoMA di New York nel Dipartimento di Architettura e Design, nonché direttore della ricerca e dello sviluppo. Nato in seguito all’emergenza Covid come una rubrica online intitolata Design in a Pandemic, Design Emergency ha allargato i propri confini nel domandarsi come il design sia capace di affrontare le sfide globali, nella convinzione che la risposta progettuale alle emergenze sia tanto stimolante e generativa da sfidare i più comuni stereotipi e le più comuni superficialità.
«Il design è una disciplina intrinsecamente ottimista. Altrimenti perché mai qualcuno dovrebbe progettare qualcosa?»
Una forma di design capace di affrontare i problemi di una crisi nel momento stesso in cui questa accade. Come si pensa quindi il design rispetto alla cultura contemporanea? Rispetto alle crisi multiple del mondo globale e alla sempre maggiore centralità della natura nei discorsi odierni?
Il tuo ultimo libro Design Emergency si apre con un saggio introduttivo che racconta dei ponti progettati dai Khasi nel nord-est dell’India, costruiti con piante vive e realizzate coinvolgendo numerose persone, insomma: un’immagine ideale di buon progetto. Ma questo è soltanto uno dei tanti esempi che porti nell’ottica di offrire un archivio di soluzioni possibili e pratiche a problemi urgenti. Cosa accomuna approcci progettuali così distanti e cosa possiamo imparare da esempi così diversi?
I ponti di radici viventi dei Khasis sono esempi meravigliosi di un design ingegnoso e straordinariamente efficiente, pianificato ed eseguito nel corso di molti anni – tipicamente per diversi decenni – e quindi con la consapevolezza che saranno figli e nipoti a poter usare il ponte, e non chi l’ha progettato, coltivato e mantenuto. Questi ponti sfidano così le percezioni più convenzionali del rapporto tra design e tempo, tra design, autorialità e paternità del progetto, dando anche un’idea di cosa possa essere un modello di design preventivo.
Ma credo anche che questi progetti siano utili modelli rispetto alle urgenze progettuali e le crisi di cui parliamo in Design Emergency. I Khasis vivono da secoli in agglomerati di villaggi sulla cima dei monti Jaintia nel Meghalaya, una delle aree più umide del pianeta. Lì i monsoni sono così frequenti e brutali che le gole tra i monti si allagano d’acqua piovana, impedendo ai Khasis il viaggio tra i diversi villaggi. Così, poiché i ponti di legno convenzionali crollerebbero sotto al peso dell’acqua, l’alternativa che i Khasis hanno inventato coinvolge le radici aeree delle degli alberi della foresta pluviale, che vengono disposte per formare lentamente dei ponti tra i monti.
In questo senso, i ponti di radici viventi sono archetipi di un design pensato nel suo ruolo tradizionale: come risolutore di problemi, ma anche esempi di un nuovo genere di progetti epici che affrontano l’emergenza climatica, la crisi dei rifugiati e altre sfide complesse e intersecate l’una con l’altra. Si tratta di progettualità che si sviluppano nell’arco di lunghi periodi di tempo e non necessariamente in modo lineare – come la Grande Muraglia Verde in Africa: lo sforzo ambizioso Sudafricano per revitalizzare il suolo lungo il bordo meridionale del Sahara, 8.000 km che percorrono il tratto sulla costa occidentale tra il Senegal e il Gibuti.
Hai parlato di “disinnescare” l'idea di un design come «artificio di stile». Credi sia un problema di comunicazione su ciò che il design è e rappresenta, oppure stiamo scoprendo solo ora il suo vero potenziale grazie a un cambiamento della sensibilità collettiva?
Il design è stato praticato per secoli, istintivamente e inconsciamente, seguendo quello che potrebbe essere chiamato un “principio”: la necessità è la madre dell’invenzione. Questo finché non è stata inventata una parola per definire questa pratica. In questi termini il design è un fenomeno complesso e sfuggente, che ha significato – e continua a significare – cose diverse per persone diverse, in tempi e contesti differenti. Acquisendo così tanti significati, è facile ora trovare della confusione sul senso del design, considerando poi che non si è mai scrollato di dosso quell’assunto, nato durante la Rivoluzione Industriale, di strumento stilistico o promozionale, ovvero qualcosa relativo all’aspetto superficiale e generalmente eseguito su istruzioni di qualcun altro.
Certo, il design stesso è il primo colpevole, ma c’è molto, molto di più. Io credo che, in tutte le sue forme, il design abbia un ruolo fondamentale, un ruolo che in Hello world ho definito come “agente di cambiamento”: ovvero capace di aiutarci ad assicurare che innovazioni e cambiamenti di qualsiasi tipo – scientifici, culturali, ambientali, politici e quant’altro – siano compresi e interpretati in maniera che influiscano positivamente. Purtroppo gran parte delle persone vede ancora il design in termini di stile, ma va detto che è un cliché che va via via scomparendo. È incoraggiante vedere che sia le persone interne che esterne alla comunità del design sono sempre più aperte ad adottare una visione eclettica e stimolante. Ma abbiamo ancora molta strada da fare per ridefinire la percezione pubblica e politica. Un compito essenziale se vogliamo che il design realizzi il suo vero potenziale in quanto forma di cambiamento positivo.
Per molto tempo ti sei infatti concentrata su una considerazione del design come atteggiamento creativo e accessibile, piuttosto che esclusivamente formativo, capace di superare le barriere disciplinari e contestuali. Anche in Design Emergency, che coinvolge una vasta gamma di persone, si ritrova la stessa inclinazione. Trovo che ci sia qui un fattore particolarmente interessante, che pensa questa postura progettuale a partire da una sorta di autonomia, di resistenza creativa e “disperata”, che emerge dal basso e sovverte spesso le regole tradizionali. Può approfondire questo aspetto?
Come scrisse il grande László Moholy-Nagy nel 1946: «Il design non è una professione, ma un’attitudine». La prova di questo si trova già nella storia del design, che è piena di esempi notevoli di imprese progettuali compiute da persone che non solo non avevano alcuna formazione in materia, ma in molti casi non sapevano nemmeno che il design esistesse. Basta pensare al pugno chiuso, che da oltre 3.000 anni indica forza e unità di fronte all’oppressione; oppure alla bandiera bianca, che da circa 2.000 anni simboleggia la fine del conflitto. Quando Paola e io abbiamo iniziato a individuare le persone che secondo noi sarebbero state le più adatte per Design Emergency, abbiamo innanzitutto stilato un elenco delle sfide che volevamo indagare: la crisi dei rifugiati e degli alloggi, l’emergenza climatica, l’abuso della tecnologia, i pregiudizi di genere, il razzismo… Poi abbiamo cercato di capire quali fossero i progetti più avanguardistici in termini di innovazione in quei campi. Gli unici altri criteri che abbiamo applicato erano volti a mantenere una certa eterogeneità in termini di genere, etnia, età e geografia. La maggior parte degli intervistati aveva comunque una formazione professionale nel campo del design o in discipline correlate, come l’architettura e l’ingegneria. Ma gli altri spaziavano da agricoltori – come Isabella Tree, che sta rivitalizzando la terra della sua famiglia nel sud dell’Inghilterra – a medici – come Sara Saeed Khurram e Iffat Zafar Aga, che hanno progettato Sehat Kahani: una rete di telemedicina che oggi cura quasi 7 milioni di persone in Pakistan – fino a un gruppo di ingegneri robotici adolescenti di incredibile talento in Afghanistan.
È interessante poi notare come nel libro ci sia stata un'esplicita volontà di analizzare criticamente anche i fallimenti e gli errori verificatisi durante il processo di risposta all'emergenza con soluzioni che, nel tempo, si sono rivelate inadatte o addirittura improduttive. Mostrare l'altra faccia della progettazione, spesso nascosta o non affrontata apertamente, è molto importante anche per la profonda onestà intellettuale che si respira nelle pagine di Design Emergency. Quanto possiamo imparare dagli errori e quanto possiamo permetterci di sbagliare come designer oggi?
Ottima domanda. Tradizionalmente, la critica e la curatela del design tendono a essere celebrative, concentrandosi sul “buon design”, forse per la preoccupazione di fondo che il design fosse – e sia tuttora – una disciplina emarginata. La triste verità è che sono pochi i progetti buoni di design, ancor meno se parliamo di grandi progetti. La maggior parte sono mediocri e molti sono pessimi, ed è un bel problema poiché la qualità del design influisce su ogni ambito della nostra vita e un cattivo progetto ha dei pessimi impatti, molto spesso di forza superiore a quelli di un buon progetto. Nel migliore dei casi è irritante o deludente, nel peggiore è pericoloso. Se vuole liberarsi dei suoi cliché stilistici, il design deve prima di tutto affrontare i suoi impatti negativi, e trovare il modo di mitigare e, idealmente, eliminare i danni che provoca. Solo allora il design meriterà di essere preso sul serio. Ecco perché su Design Emergency discutiamo sempre di ciò che è andato storto oltre che dei successi.
Inoltre, i designer ambiziosi che sono lodevolmente intenzionati a usare le loro capacità per affrontare problemi complessi, devono essere consapevoli che più grande è la sfida, maggiore è la responsabilità di affrontarla con sensibilità e intelligenza. Così come progetti di design umanitario o sociale realizzati intelligentemente aumenteranno le possibilità di sostengo da parte di governi, Ong o altri finanziatori, ogni progetto approssimativo, ogni flop, avrà un feedback negativo, rappresenterà una battuta d’arresto.
L'attitudine a progettare è una disposizione innata che tutti abbiamo dentro e che deve essere stimolata a emergere. Da questo punto di vista, a volte le situazioni urgenti fanno emergere inconsapevolmente quest’attitudine. Così, per certi versi, la sensibilità di un designer è anche la sua disposizione a lasciarsi impressionare dall'ambiente circostante, e la sua abilità sta nel rispondere a questa chiamata nel modo più coerente ed efficace possibile. Possiamo trovare un lato positivo in questi tempi bui, che ci permetta di esplorare l'emergenza e di apprezzare ciò che non conosciamo?
È indubbiamente un periodo buio, questo in cui ci troviamo ad affrontare minacce sempre più complesse e inquietanti su così tanti fronti, ma ci sono anche motivi di speranza. Uno che ci riguarda da vicino è che il design ha dimostrato il suo valore nella progettazione di risposta e d’aiuto rispetto ai fenomeni tragici di questi tempi – dalla pandemia di Covid-19, alla guerra illegale di Putin in Ucraina fino ai devastanti terremoti nel nord della Siria e nel sud della Turchia –, e l’ha fatto con coraggio, generosità, intraprendenza e anche un certo aplomb. Un altro aspetto è l’innovazione tecnologica, che continua indubbiamente a trasformare la pratica e le possibilità di progetto, fornendo ai designer strumenti sofisticati per operare in modo indipendente e nel perseguimento delle proprie cause. Così medici come Sara e Iffat possono lanciare e gestire Sehat Kahani, e designer sociali come Hilary Cottam gestire enormi quantità di dati complessi per sviluppare e fornire nuove strategie di design. Infine, uno dei maggiori punti di forza del design è che si tratta di una disciplina intrinsecamente ottimista. Altrimenti perché mai qualcuno dovrebbe progettare qualcosa?
Se dovessi improvvisare un lessico di base del “design d'emergenza”, quali parole suggeriresti di tenere a mente quando si pratica il design?
Dato il profondo radicamento del design nelle nostre vite, le qualità a cui aspira tendono a essere sempre quelle apprezzate dalla società in generale e in un determinato momento storico. Fortunatamente, parole positive come „anticipazione“, „coraggio“, „diversità“, „empatia“, „sperimentazione“, „generosità“, „gentilezza“, „guarigione“, „inclusione“, „ingegnosità“, „ispirazione“, „intuizione“, „nutrimento“, „orgoglio“, „resilienza“, „intraprendenza“, „rispetto“, „sensibilità“, „sottigliezza“, „ponderatezza“ e „saggezza“ sono ancora parole salienti.
Devo dire anche che la mia scrittura sul design è definita dall’evitare parole che considero tossiche. Per esempio non descriverei mai un progetto come „artistico“ o „scultoreo“, perché ritengo in primo luogo che pensare il design come arte non sia appropriato, anzi: lo sminuisca. Allo stesso modo, evito le parole di genere. Ogni ambito della nostra vita ne è soggetto, ma soprattutto il design, che è infestato da riferimenti misogini a „capolavori“, „opere d’arte“ e, in italiano, a „maestri“. È urgente, anche qui, ridisegnare il linguaggio del design per renderlo equo, egualitario, inclusivo e meritocratico.