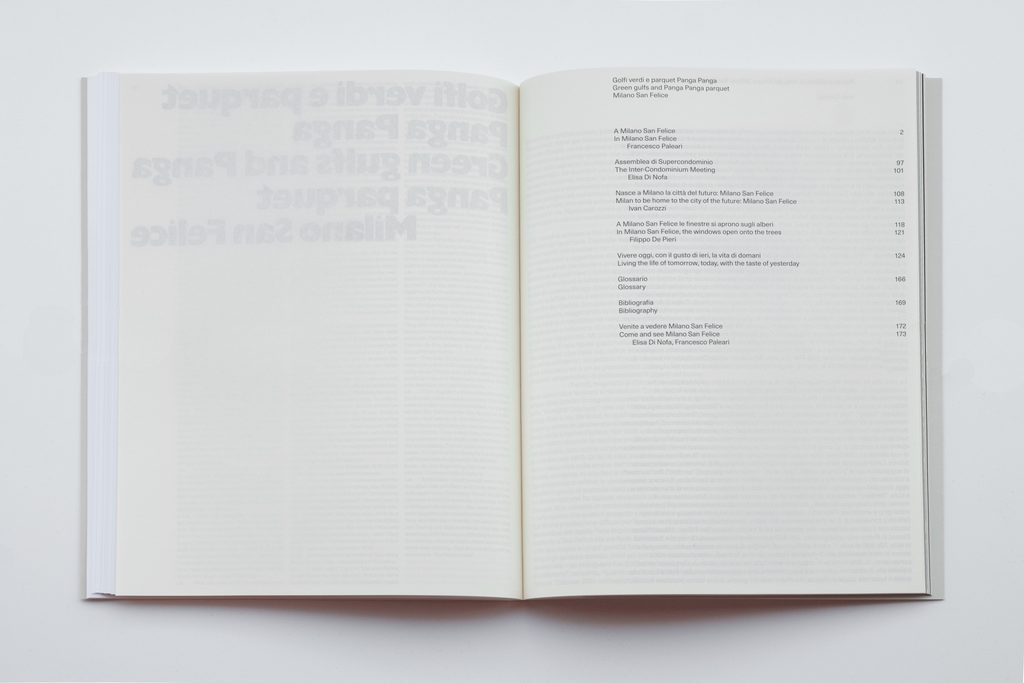La storia delle alternative alla città è lunga. Si può considerare tutto sommato come un basso profondo che accompagna da sempre le vicissitudini urbane (almeno nella modernità), considerate dai cultori della fuga nei termini di luoghi d’accentramento: spazi in cui ci sta tutto e spesso ci sta freneticamente troppo, ed essendoci tutto e troppo e nient’altro che il tutto e il troppo quel che si percepisce è un quotidiano che somiglia ogni giorno a una tempesta – e notoriamente le tempeste non sono posti semplici in cui vivere.
Insomma, il desiderio escapista è sempre e da sempre alle porte. Cosa che ha prodotto nella storia un corpo possente di critica, immaginario e utopie, e come ben si sa le utopie sono tanto orizzonti d’esercizio etico e morale quanto pratico. D’altronde l’escapismo ha molto a che fare con l’utopia, anzi ne è per certi aspetti il motore, manifestando quell’insofferenza verso l’una o talaltra realtà, identificandone il disagio e prendendolo sul serio, fino eventualmente a pensare alternative percorribili, e qui le fughe. Se da un lato quindi ci sono le utopie che pertengono prettamente all’immaginazione, svolgendo il ruolo di faro nell’orientamento del quotidiano, dall’altro ci sono le sue applicazioni. Che tendenzialmente sono (quasi) tutte finite in malora, per ingenuità, per calcoli malfatti o per speranze riposte nei metodi sbagliati.
Quel ritorno di frusta che ribalta il bovarismo imbracciando la “pace e la tranquillità” delle province e il ritmo cauto degli ambienti rurali, tanto in città quanto altrove.
Ora come ora le utopie più comuni e più percorse che fanno da contraltare urbano sono quelle che hanno a che fare con quel “verde” che un po’ riposiziona l’interesse estetico e morale di selve, boschi e giardini in città e un po’ prosegue quel ritorno di frusta che ribalta il bovarismo imbracciando la “pace e la tranquillità” delle province e il ritmo cauto degli ambienti rurali, tanto in città quanto altrove. Un fatto collettivo e sociale, questo, che si vede molto bene nella recente postura linguistica che vede i paesi diventare “borghi”, intraprendere un lavoro comunicativo di distinzione e produzione di valore (c’è chi direbbe di marketing territoriale), ma anche dal trambusto di desideri seguito al lockdown, quando in tanti riprendevano a pensare con più serietà la fuga dalla città, complici tanto le condizioni di vita, e quindi spaziali, radicalmente diverse (i giardini e le metrature soprattutto), quanto l’effettiva e recente possibilità di coniugare il lavoro, tra l’eventualità dello smartworking e il tran tran di competenze dei milioni di city user, con il sogno della vita agreste.
A ben vedere sono pochi che alla fine hanno seguito quest’idea. Lasciare la città è difficile (per diverse ragioni che ha poco senso elencare perché tutti le conoscono), e sarà anche questo che a sopperire all’utopia della fuga vera e propria ci sono le piccole utopie urbane, che oggi – se non da sempre, come dicevamo su – sono cittadelle, enclave e quartieri.
In questa prospettiva, avere sotto mano Golfi verdi e parquet panga panga, volume edito da Humboldt Books a cura di Elisa di Nofa e Francesco Paleari e con un testo di Ivan Carozzi, che racconta della storia e delle vicissitudini del quartiere San Felice, offre una certa idea di innovazione e continuità con quanto detto finora.
La promozione del quartiere si dispose come contraltare a una Milano che s’anneriva nello smog, e si raccontò nella cornice del sogno boscoso e del sentimento comunitario.
San Felice è uno dei quartieri costruiti ex-novo negli anni Sessanta (eretto tra il 1965 e il 1969), gli stessi anni in cui s’avviava – nel pieno del boom economico – un’idea di una Milano azzuffata e pulviscolosa, che s’iniziava alle grandi sovrabbondanze di popolazione, alle stagioni delle lotte e alle povertà del lavoro culturale (grazie, Luciano Bianciardi). Erano anche gli anni in cui l’edilizia popolare si inventava i quartieri Peep: l’abitare sociale delle unità residenziali avanguardistiche, che attingevano a mani basse dagli orizzonti utopici, e che portarono alla concezione di aree come il Corviale a Roma, le Vele a Scampia o il Monte Amiata a Milano. Ma ci sono anche esperienze più legate a finalità più esplicitamente escapiste perché vacanziere, come la notissima Costa Paradiso (esemplare nato in competizione esplicita alla Costa Smeralda, e conosciuta forse più per la casa di Antonioni progettata da Bini), il villaggio di Rosa Marina vicino a Ostuni e – particolarmente e inspiegabilmente simile a quest’ultima in termini di comunicazione, forme e promozione – il quartiere di Milano San Felice, che da un lato c’entra poco con la vacanza ma ricalca appieno l’idea di un vivere “nella natura”, e dall’altro non ha nulla a che fare con quartieri Peep o edilizia popolare (questione che per certi aspetti rimanda di sbieco alle operazioni immobiliari odierne su Milano, come Santa Giulia o il MIND, seppur qui il “verde” sia strettamente legato a lavoro e innovazione invece che all’abitare domestico).
Il quartiere nacque per idea dell’ingegnere Giorgio Pedroni, che a quanto si legge nei testi del libro fu un grande visitatore delle città satelliti, si interessò ai villaggi minerari di Walsum – cittadelle operaie al pari di Crespi d’Adda –, ed ebbe poi l’intuizione di edificare un nuovo quartiere sui fianchi della città, un quartiere che fosse una comunità e che soprattutto rappresentasse un’alternativa green ante-litteram a una città che, come scrive Ivan Carozzi all’interno del libro, esprimeva già «una silenziosa corruzione delle cose, così insinuante da intaccare le fibre di una camicia bianca».
San Felice ha tutte le carte in tavola di una moderna utopia ecologica, ma di quelle “privatopie” che riassemblano la logica urbana dei compound, delle new town inglesi, delle enclave e delle gated communities.
La potenza e l’interesse per il successo di San Felice sta proprio qui, nella postura comunicativa e progettuale che ebbe fin dall’inizio, e che Carozzi coglie benissimo dalla storia del “colletto annerito”: il verde. La promozione del quartiere si dispose come contraltare a una Milano che s’anneriva nello smog, nel particolato del traffico e nell’industria rampante, e si raccontò nella cornice del sogno boscoso e del sentimento comunitario (tornando a Rosa Marina e al vacanziero, la si è letta altrove così: «A Rosa Marina il tempo non scorre come in città e un minuto è fatto di sessanta intensi secondi. Rosa Marina è l’Estate, è il paese dell’eterna giovinezza»). Fatto che si vede nitidamente dalla sezione d’archivio del libro, dove vengono riportati stralci dei pamphlet pubblicitari come: «Vedremo mai la corsa della lepre attraverso i golfi?», «Questa città non l’ha creata Walt Disney. Eppure è una città da favola», fino a «Mamma, cos’è un prato?» in un inserto pubblicitario in bianco e nero dove una foto ritrae due bambini giocare sull’asfalto. Ricorrono quindi i rimandi ai “polmoni”, ai “sentieri” e ai celebri “golfi verdi”, che valgono tanto come informazione promozionale e immagine suggestiva quanto come stilema estetico e progettuale del quartiere, pensato oltretutto dai due grandi progettisti a cui venne affidata la progettazione del San Felice: Luigi Caccia-Dominioni e Vico Magistretti. I golfi verdi sono così a tutti gli effetti degli aggetti da balconi, logge e vetrate, insomma da alture che si affacciano sui larghi parchi incastonati da palazzine e case basse, tutte disposte sull’andamento curvilineo di strade, percorsi e sentieri, tra i quali si infrascano le villette isolate nella vegetazione. C’è poi un lago artificiale, il Malaspina, un campo da golf, di tennis, una palestra, da poco un centro di quartiere, una biblioteca, nonché un cinema di quartiere. Tra i racconti più rappresentativi, ci sono aneddoti di gente che finisce accidentalmente nelle rogge, la nebbia fitta per tornare a casa, il ronzio perturbante e costante delle zanzare, i fagiani, i gruppi ecologici negli anni Settanta ostili alla caccia, e pure le eccezioni più radicali e folli, come la presenza di Vito Cosmai, fondatore e inventore di Emoscambio, che molti ricorderanno per le scritte sulle provinciali (ΣMOSCAMBIO) e le storie sull’amplesso “naturale” che un po’ a noi lasciano il sapore di un’ecologia profonda e giusto un poco deviata.

Insomma, a San Felice è tutto verde. È l’utopia verde prima dei verdi, o quando comunque ancora la lotta e la sensibilità ecologista non avevano (in Italia soprattutto) il peso odierno né tantomeno la popolarizzazione – più o meno retorica – di oggi; all’incirca coevo, oltretutto, al libro e alla foto che per antonomasia hanno articolato massivamente queste sensibilità, ovvero Primavera Silenziosa di Rachel Carlson (1962) e la foto Earthrise (1968). San Felice ha tutte le carte in tavola di una moderna utopia ecologica, ma di quelle “privatopie” che riassemblano la logica urbana dei compound, delle new town inglesi, delle enclave e delle gated communities (che furono tanto care a James Graham Ballard e al mondo della balcanizzazione privata del cyberpunk), e che oggi tornano in auge come fronte privato ed elitario davanti alla crisi ecologica – questione questa che a posteriori si può dire sia stata compresa con largo anticipo da chi ha pensato e abitato San Felice.