La poeta, artista e scrittrice Wissal Houbabi, classe 1994, da diversi anni collabora con realtà politiche, artistiche e culturali con un’obiettivo: smantellare e mettere in crisi un sistema (che fino a prova contraria è) strutturalmente razziale, patriarcale e classista. Wissal si muove su vari ambiti, dalla ricerca hip hop alla scrittura di racconti brevi che esplorano la condizione della cultura diasporica, agli spettacoli di poesia orale e performativa con musica mediterranea.
Da qualche tempo vive a Bologna e tra qualche settimana condurrà alcuni laboratori all’interno del progetto Traiettorie di sguardi che mira a decolonizzare saperi, memorie, immaginari legati ai musei di Bologna. Wissal terrà quattro incontri presso il Museo internazionale e biblioteca della musica e il MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna provando a osservarli con sguardo critico a partire dalla questione della razzializzazione e della prospettiva eurocentrica con un’attenzione particolare sulla storia della musica e sulla ricerca della voce. Qui tutte le info.
Per l’occasione l’abbiamo quindi incontrata per farci raccontare, non solo di quest’ultimo progetto, ma del suo percorso generale.
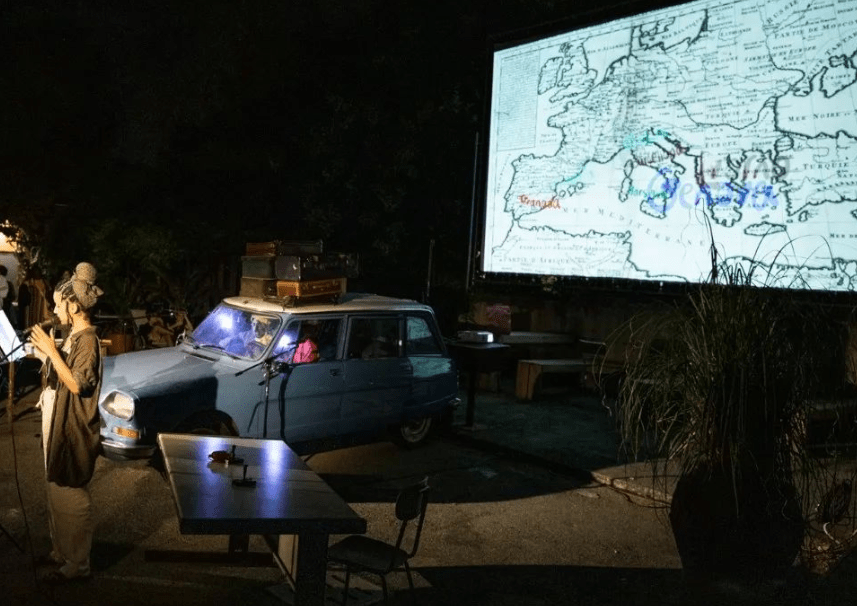
Dopo un periodo a Trieste sei approdata a Bologna, perché?
A Trieste ero per l’Università, lì sto ancora studiando Lingue. Bologna è, invece, la settima città italiana in cui vivo. È una sindrome la mia, quella di continuare a spostarmi. Non avendo una dimensione di radicamento, nel momento in cui sono andata via di casa dai miei genitori ho continuato a trasferirmi per cercare nuovi stimoli. Mi piace l’idea di partire da zero, di lasciarmi qualcosa dietro e ricominciare da qualcos’altro, andando avanti. Bologna è arrivata dopo un periodo in cui Trieste aveva esaurito per me la sua attrattività. Ho pensato di spostarmi qui perché è tra le città più vivibili e che rappresenta la storia della cultura hip hop italiana con apertura internazionale.
Come inizia il tuo percorso di militanza?
Verso gli 11/12 anni ho iniziato ad assumere una certa forma mentis. Ho costruito il mio carattere e la mia identità soprattutto grazie al rap, che mi ha dato le basi strutturali già dalla fase della pubertà. A 11 anni ascoltavo Tupac anziché andare al parco. Tutta l’adolescenza è stata una ricerca sul piano storico e politico, su come volevo pensare le cose o non pensarle, su cosa mi convinceva e cosa no, dove volevo posizionarmi. Principalmente mi interessava la storia afro-americana.
Dove sei cresciuta?
Sono nata in Marocco e intorno ai 3 anni ci siamo trasferiti in provincia di Perugia. Sono cresciuta in un paese di 300 abitanti, in una sorta di bolla. Eravamo ovviamente l’unica famiglia di immigrati. In quel paese spopolato con una routine molto precisa appassionarmi al rap e agli afroamericani era per me una cosa fuori dal mondo.
Quand’è arrivato invece l’incontro con l’attivismo?
Nel momento in cui sono andata via di casa, uscita da quella bolla. Dopo qualche esperienza nella ristorazione stagionale in giro, arrivata a Trieste ho potuto fare chiarezza su ciò che volevo. Prima per me l’attivismo erano i movimenti per i diritti civili, erano le Black Panther, altre cose molto lontane. Quando poi ho messo piede fuori e ho scoperto che c’era qualcosa in cui potevo essere coinvolta, è stato quasi automatico. E così ho iniziato ad applicare la mia formazione artistica e politica nel contesto locale o nazionale a seconda dei casi. Tutto questo è successo verso i 20 anni, abbastanza tardi rispetto a chi inizia facendo le occupazioni nelle scuole.
In quello che scrivi c’è un ritmo e un’energia che rendono tutto così urgente e coinvolgente. Quanto la musica ti ha aiutata in questo?
Devo tutto alla musica. Per me è un grande motivo di vanto rivendicarlo in contesti istituzionali, accademici o intellettualoidi. La mia capacità critica viene da lì. Anche se a un certo punto questa capacità critica si è scontrata con il fatto che iniziavo ad essere critica con i rapper stessi, cosa che il pubblico del rap non è capace di fare.
Lo ius culturae non è la mia lotta, scrivevi. Da qualche tempo Bologna ha scelto di dare simbolicamente la cittadinanza onoraria a ragazze e ragazzi stranieri. Cosa ne pensi?
Male non fa sicuramente. Fa parlare un po’, tiene un po’ viva la questione ed è importante che il Comune abbia preso una posizione. Quello che mi chiedo però è: dopo l’atto simbolico qual è il percorso? Perché, in generale, è importante avere consapevolezza di ciò che si vuole e del percorso che si vuole fare. Così come far emergere i motivi per cui certi percorsi o certe modalità sono difficili da praticare.
La mia critica allo ius culturae è rivolta anche a quelle persone afrodiscendenti in Italia che hanno costruito un percorso proprio su quello. Mi chiedo: perché puntare a dieci, quando tutti vogliamo mille? E sappiamo che puntare sullo ius culturae è una toppa che non rimuoverà il problema che sta alla base.
Spingere su qualcosa che è più fattibile rispetto a qualcosa di realmente desiderabile per me è il contrario della politica, è una modalità strategica che mi dà fastidio. E succede purtroppo spesso, perché quando si inizia a fare politica le ragioni del compromesso ti portano a smettere di esplicitare ciò che si vuole fare per dire piuttosto solo ciò che si può fare. Quindi, ok la cittadinanza onoraria, ma io vorrei sapere dove vogliono arrivare, e vorrei che si portasse il dibattito su ciò che ci impedisce di farlo, utilizzando quegli stessi limiti come armi per affrontare un percorso e per alimentare il conflitto.
Vedremo. Se Bologna vuole essere una città progressista, noi ci aspettiamo tantissimo e chi è stato votato ha una grande responsabilità.

Tra le altre lotte che ti stanno a cuore c’è quella del femminismo intersezionale…
Nel momento in cui è diventata di forfait, in realtà, ho smesso di usare la parola intersezionale. Nel senso che oggi in Italia se si è femministe si è automaticamente femministe intersezionali. È entrato nello starter pack. Nonostante io stessa sia una femminista intersezionale. Perché sono donna, sono figlia di immigrati con un livello di povertà che non ti puoi immaginare. E non ti puoi immaginare cosa non ci è mancato: tutto. Pensando a chi avevo intorno a me ovviamente. Essere in Europa era già la conquista insostenibile.
Dicevo: ho smesso di utilizzare quel termine nel momento in cui ha perso il suo rapporto con la sua etimologia storica e politica. Perché fu coniato da Kimberlé Crenshaw all’interno di un contesto che parlava di donne nere in cui definirsi in questo modo, nell’intersezione tra più oppressioni, è stato molto importante per riconoscersi in qualcosa che era difficile da nominare e verbalizzare.
In Italia “intersezionale” è invece diventato un modo per dire “io vivo nella mia esperienza più oppressioni” senza però mettere al centro la matrice razziale. E nel momento in cui intersezionalità significa tutto, finisce per non rappresentare più nessuna.
Quindi chi usa in Italia questa parola oggi sbaglia?
Non critico il fatto che si usi questa parola, ma è problematico il fatto che abbia perso il legame con la sua storia, con la sua etimologia che è data dall’esperienza di chi ha avuto bisogno di pensare a questo concetto. E anche se il concetto è diventato strumento comune, io faccio fatica a parlare di intersezionalità quando intorno a me c’è tutto tranne la comunità di persone razzializzate.
L’intersezionalità in Italia, credo, rappresenta maggiormente le persone che fanno parte della comunità LGBTQIA, perché le donne razializzate qui di fatto non costituiscono ancora un reale movimento politico come è quello della comunità LGBTQIA che ha una lunga storia alle sue spalle, soprattutto a Bologna, ma che però è prevalentemente formata da persone bianche.
Mi stai dicendo che a livello di coscienza c’è ancora un po’ di strada da fare, anche a Bologna…
Sì un sacco.
Veniamo al progetto Traiettorie di Sguardi. Come ti stai preparando? Hai fatto delle visite ai due musei? E cosa hai notato rispetto al loro retaggio coloniale?
Ho fatto un tour dei musei una domenica per conto mio e scelto i due musei su cui volevo concentrarmi, anche in continuità con il mio percorso artistico e politico.
Il mio primo contatto con Bologna, tra l’altro, fu grazie al Museo della Musica, perché stavo cercando un libro molto raro che era solo nella sua biblioteca. Ma all’epoca lo trovai chiuso e dopo non sono più riuscita a visitarlo. Quando poi è arrivata questa proposta ho pensato che dovevo partire prima di tutto da lì. Quindi ci sono andata e devo dire che sono rimasta delusa. Mi sono detta: l’Europa non è sempre stata così bianca in realtà. Non tutto è stato partorito in questo modo, perché c’è una cultura mediterranea. Ed è come se la storia fosse stata, in un certo senso, sbiancata. Basta guardare, ad esempio, alla storia della Spagna per scoprire che è diventata Europa “bianca” solo con i re cattolici a fine 1400 e che lì nacque una diaspora verso il Marocco, che oggi è la testimonianza musicale di quello che era la Spagna del Medioevo.
Su questo e molto altro cercheremo di ragionare. E sono curiosa di sapere le altre persone che parteciperanno agli incontri cosa ne pensano.
Il progetto è incentrato sulla dicotomia e la complementarietà tra voce e silenzio, sulle storie silenziate e sulle voci che mancano, e sulla consapevolezza della propria voce.
Poi ci sposteremo al MAMbo dove c’è un’idea di museo che mi interessa di più, legata al contemporaneo, e proveremo a fare insieme qualcosa di più sperimentale.
Come pensi di incidere nel concreto?
Faremo una fanzine distribuita gratuitamente nei musei comunali, che sarà un oggetto politico. E sarà un modo anche per ragionare insieme sul concetto di museo. Io stessa ho lavorato in un museo per anni e conosco bene le dinamiche di un’istituzione che non riesce a stare al passo coi tempi, che non riesce a filtrare aria nuova, a respirare, a mutare. Un museo è spesso la cristallizzazione di alcune scelte in un momento determinato. Dovrebbe essere l’esatto contrario.
Per me parlare di istituzioni è comunque sempre importante perché pone questioni che conosco bene. Non perché ho delle idee, ma perché ci ho sbattuto la testa. Ho sbattuto la testa col “torna domani, questo non si può fare, no tu non puoi”, contro una burocrazia di base che per le persone razzializzate diventa un inferno. Perché si aggiunge a un’esplicita intolleranza, e io ricordo tutto: ricordo gli sguardi, i commenti della polizia, le ammissioni di razzismo da parte di alcuni ufficiali, ecc. ecc.

Hai detto anche che concedersi l’arte da immigrati talvolta sembra un lusso. Perché?
Ci sono vari fattori. Il primo è materiale. Se tu hai un permesso di soggiorno e lo devi rinnovare ci vuole un contratto di lavoro che dica che sei autosufficiente. Quindi o stai in Italia o fai l’artista.
Come vivono gli artisti? È una grande domanda. Fare arte costa un sacco, significa anche investire denaro e non aspettarsi nulla indietro, significa avere il tempo per produrre.
Io mi sono potuta permettere di fare arte nel momento in cui non dovevo più pensare ai documenti, perché prima non poteva nemmeno saltarmi per la mente, sarebbe stato un suicidio.
L’altra questione riguarda il fatto che fare l’artista significa rappresentare qualcosa, rappresentare qualcuno, significa che la gente ti affida una capacità immaginifica e si affida a te per poter avere una visione di mondo. Quella di fare arte è, quindi, una grande conquista, soprattutto in un paese come l’Italia dove tutto è arte, ma arte molto radicata. È ovvio perciò che un corpo straniero non si sente coinvolto, figuriamoci poi nella storia dell’arte. Sicuramente però tra una generazione o due daremo per scontate molte più cose che noi non abbiamo potuto.
Tornando alla decolonizzazione degli sguardi, in città c’è un quartiere, la Cirenaica, che ha lavorato molto su quest’aspetto a partire dalla sua odonomastica. Cosa ne pensi?
È molto interessante. Perché dal punto di vista urbanistico c’è molta storia che vale la pena conoscere: tipo perché in certi quartieri si elogiano certi personaggi invece che altri, qual è la percentuale di donne nelle nostre strade, ecc. A Bologna ci sono, per dire, cose che in altre città non ho mai visto, c’è un forte sentimento internazionalista che si riscopre nei nomi delle vie e delle piazze o dei parchi. Trieste, per dire, è molto più italica e nazionalista, ci sono ancora molti fascisti per le vie.
Qual è invece il tuo quartiere e quali sono i tuoi luoghi preferiti?
Sono in Bolognina. Lì c’è la mia piccola comunità affettiva. Passo le mie giornate in zona mercato Albani, mi piace andare a prende un caffè da Fermento, farmi tagliare i capelli al Salone Marrakech, andare a trovare il mio amico Didier alla Casa del Mondo dove fa i suoi progetti con i bambini, andare a studiare alla Casa di Khaoula, mi piace andare a fare spesa al mercato, camminare, guardare le cose che succedono attorno a me, avere tutto a portata di mano. Una cosa che non mi piace, che anzi trovo molto grave, è che non ci sia neanche una libreria. Invece ci sono molti supermercati. Qualcuno apra una libreria!
Progetti per il futuro?
In questo momento sto scrivendo un libro sull’hip hop. Sto provando a demistificare diverse questioni per dare un contributo a una cultura che mi ha dato tanto.




