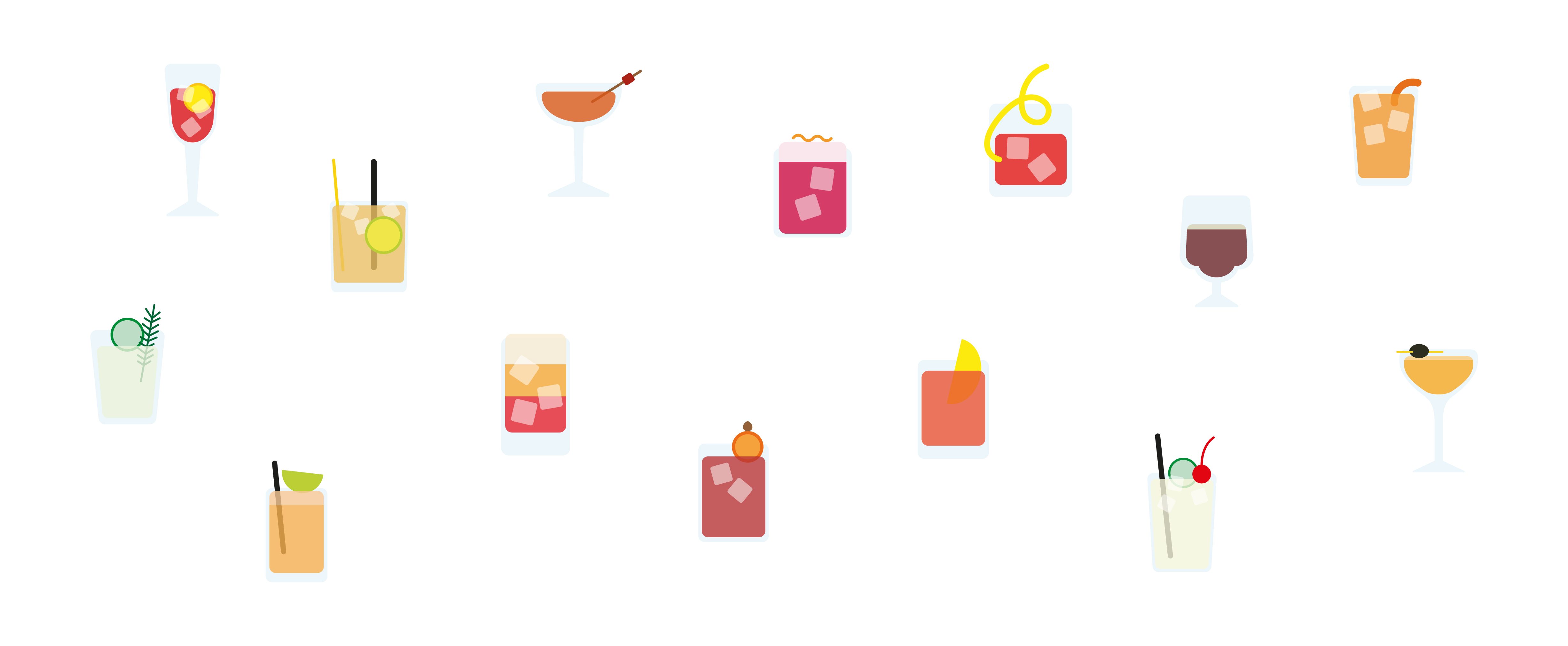Nel 1967 a Milano la moda del cocktail non era molto diffusa: a dirlo non sono io ma il compianto Mirko Stocchetto del Bar Basso. In un’intervista ci ha raccontato che l’idea del famoso bicchierone del Negroni nacque per attirare i clienti milanesi, che non erano abituati a bere drink come aperitivo, ma solo bianchini o liquori come Campari, Fernet-Branca, Ramazzotti e Zucca, giusto per citare i quattro meneghini che hanno fatto la storia. In effetti all’epoca, salvo rare eccezioni (soprattutto grandi hotel e qualche indirizzo storico), il cocktail non era per tutti, nonostante l’AIBES (Associazione Italiana Barman e Sostenitori) fosse stata fondata già da quasi 20 anni, e precisamente il 21 settembre 1949 – guarda caso all’Albergo dei Cavalieri in Piazza Missori 1.
Non che il cocktail fosse un’invenzione millenaria: tra le varie storie, leggende e versioni diverse, tutte ovviamente evaporate nell’alcol, parliamo di Ottocento: 1806 se consideriamo la prima definizione di cocktail pubblicata su un giornale, il Balance and Columbian Repository di Houston, ovvero una “bevanda stimolante composta da superalcolici di vario tipo, zucchero, acqua e amari”; 1860 circa se ci riferiamo al primo libro con delle ricette, il Bartenders’ Manual di Harry Johnson; 1862 se prendiamo in considerazione la guida del padre di tutti i barman, „How to Mix Drinks or The Bon-Vivant’s Companion del Professor Jerry Thomas“.
Certo in Italia – soprattutto a Milano e a Torino – ci fu la felice parentesi della Miscelazione Futurista, un periodo memorabile per il bar (o meglio quisibeve, non era consentito l’uso di parole straniere) che produsse geniali polibibite (bada bene, non cocktail) preparate con ingredienti autarchici quali grappa, arzante (brandy), vini, vermut, amari e bitter e in cui la creatività dei miscelatori fu affiancata da quella di grafici e artisti come Fortunato Depero, Nikolay Dugerhoff, Ugo Pozzo, che fecero la fortuna di marchi come Campari e Amaro Cora.
Il Futurismo nacque all’interno di alcuni locali milanesi come Caffè Centro, Savini, Camparino, Cova, luoghi dove gli avventori si scambiavano idee, opinioni e pure qualche cazzotto. Poi purtroppo ci fu un ventennio in cui dai pugni si passò ai pugnali, ma questo è un altro discorso che non ha nulla a che vedere con la Miscelazione Futurista, a parte che tra la guerra e la ricostruzione non è che andare al bar fosse la priorità.
Nel frattempo al Bar Casoni di Firenze, nel 1919, il Conte Camillo Negroni e il barman Fosco Scarselli inventarono il Negroni: il Conte trovava troppo leggero l’Americano e chiese al bartender di sostituire l’acqua di seltz con del corposo gin. L’Americano alla moda del conte Negroni divenne poi il celebre Negroni, successivamente reinterpretato da Mirko Stocchetto come abbiamo visto sopra. Fondamentalmente una variante dell’Americano, nato a Milano nel 1860 nel bar di Gaspare Campari col nome di Milano-Torino, successivamente diventato Americano con l’aggiunta di soda in onore del pugile Primo Carnera (questa è una delle mille versioni di questo drink, la mia preferita e anche più credibile, sempre a livello personale).
E così, dopo i primi cenni di ripresa del Dopoguerra, quando ci si ritrovava nei bar a guardare la televisione e a bere la cosa che costava di meno, arriviamo agli anni Sessanta e Settanta, quelli del boom, quando anche in Italia si cominciarono a bere cocktail seriamente. Prima però bisogna menzionare un altro drink italiano famoso in tutto il mondo che non è stato inventato a Milano: il Bellini, creato da Giuseppe Cipriani all’Harry’s Bar di Venezia nel 1948 in occasione della mostra dedicata a Giovanni Bellini.
Anni 80: nella Milano da bere dove tutto era possibile – cantata dallo spot della Ramazzotti, “l’amaro di chi vive e lavora, l’amaro di una vita, l’amaro di una giornata che non è mai finita” -, ci si ripuliva la coscienza coi soldi pubblici, persino gli spiccioli per bersi un aperitivo al Gin Rosa e da Savini; nel frattempo in luoghi come il Bar Cavour, Al Panino e Burghy nascevano i paninari, che ci piacciano o no un simbolo di quella Milano che catturò persino l’attenzione dei Pet Shop Boys col singolo Paninaro del 1986.
Senza dimenticare i bagordi degli anni 90, quando il signor Vinicio Valdo inventò “l’aperitivo alla milanese” (poi, ahinoi, “happy hour”), trattenendo i clienti nei bar (Cap Saint Martin, Roialto, Milano, Invillà, giusto per dire i più riusciti) dando loro da mangiare gratis per fare in modo che continuassero a bere. Molto prima che l’happy hour diventasse un fenomeno di massa e che i miei genitori mi invitassero a bere i negroni al Diva (poi diventato Cape Town) e al Tribeca Lounge, col risultato che nella maggior parte dei locali l’aperitivo si trasformò in una schifezza con cibi immangiabili e cocktail imbevibili e cari. Contava solo la grandezza del buffet, e tanti saluti al fegato.
È proprio quel periodo di decadenza che dobbiamo ringraziare ora che sono in corso la rinascita dell’aperitivo e dei bar italiani: se non avessimo toccato il fondo nessuno si sarebbe sognato di ricominciare da capo, eliminando il buffet e tornando alla qualità delle materie prime, alle bottiglie premium, alla frutta fresca di giornata, facendo nascere un numero di locali dedicati alla ricerca del cocktail e dell’aperitivo perfetto inimmaginabile solo dieci anni fa.
Articolo pubblicato su GRANDE! ZERO – Bere bene in città del 16/06/2017