Tony Lewis. Alms, Comity and Plunders è il primo progetto italiano dell’artista afroamericano Tony Lewis (Chicago, 1986), realizzato appositamente per lo spazio della cripta del Museo Marino Marini. Abbiamo intervistato il direttore del museo, Alberto Salvadori, che ci racconta della sua battaglia per rendere viva con l’arte contemporanea una città mangiata dal turismo e dagli anglobeceri.

ZERO: Ciao Alberto. Ho l’occasione di conoscerti durante l’allestimento della personale dell’artista americano Tony Lewis all’interno dello spazio del Museo Marino Marini, di cui sei direttore da diversi anni. Conosco il tuo lavoro, perché sei un curatore colto e preparato che ha sempre lavorato tra l’Italia e l’estero, e il tuo primo lavoro curatoriale è stato all’interno di una buona istituzione come la Gam di Torino. Ti chiedo dunque, per iniziare la nostra chiacchierata, quale sia il tuo rapporto con Firenze, dove vivi e lavori, e come vedi la relazione tra questa città e gli USA.
Alberto Salvadori: Partirei dalla relazione con Firenze. Qui ci sono trentasei università americane, che implicano una presenza costante di migliaia di studenti americani, anche di provincia. La loro presenza numerica così massiccia non implica però un rapporto con la nostra storia, che non viene capita. Spesso vengono qui e non imparano neanche l’italiano. Questo è un atto di colonialismo inconsapevole, nella maggior parte dei casi. E poi sono affascinati solo dal segmento della nostra storia che nella loro storia ha avuto importanza: il Rinascimento. Perché la nascita degli Stati Uniti d’America è stata molto legata questo periodo. Quindi vengono qui e studiano solo quello – ho un sacco di amici che insegnano nella Università americane, con indirizzi ben precisi. Lavorare a Firenze, rispetto a quello che facciamo noi, è un lavoro diverso.

Quindi stai dicendo che Firenze rimane sempre e comunque una città molto turistica, anche per quanto riguarda l’arte?
Diciamo che Firenze va in parallelo con Venezia – solo che a Venezia c’è la Biennale e grandi istituzioni come Palazzo Grassi, e grandi identità legate all’oggi che a Firenze non ci sono. In termini di grande visibilità l’arte (contemporanea) non c’è. Firenze è un luogo che vive soprattutto il centro città attraverso tre grandi modalità: turismo, accoglienza – ristorazione e alberghi – e shopping. E anche andare al museo inteso come andare agli Uffizi o all’Accademia è una forma di shopping: è un passaggio fugace all’interno di luoghi simbolici. Quindi lavorare sul contemporaneo a Firenze è sempre stato importante, sin dal primo momento, da quando ho impostato l’identità del Museo come luogo fatto non per i turisti. Si tratta di un’operazione che ho sviluppato per chi a Firenze ha tra i 15 anni e i 50, e anche oltre. Tendenzialmente il museo è rivolto a questa fascia importantissima che, per volontà o accidentalmente, vive a Firenze ed è interessata all’oggi, non necessariamente al passato.

Sono curiosa di conoscere il tuo percorso da Torino a Firenze.
Ho una formazione classica. Il mio primo lavoro in un museo è stato a Torino alla Gam, ma mi sono laureato in Storia dell’Arte dei Paesi Europei in età moderna, tra ‘600 e ‘700 a Pisa. Ho fatto una tesi noiosissima sull’archeologia inglese di quegli anni. Poi ho fatto la specializzazione, che ai tempi era la scuola per accedere alle sovraintendenze, di altri tre anni sempre a Pisa, e ho studiato il Mercato dell’arte nell’800 in Italia. E poi mi sono fatto, ormai 15 anni fa, parallelamente e come passatempo costruttivo, il master per curatori a Brera. Insieme a me c’era Bruna Roccasalva, e altri amici. Marco Meneguzzo era il mio professore di riferimento. Ebbi poi due assegni di ricerca, sempre sul ‘700 inglese, per il Getty Museum. Ero un po’ schizofrenico: l’arte contemporanea era stata per me da sempre una passione personale. Ma non pensavo di finirci a lavorare.
Hai parlato di Getty Museum, che è a Los Angeles. Tu hai una peculiarità che qui in Italia non è comunissima: al Museo Marino Marini hai deciso di alternare artisti contemporanei con artisti storici, e artisti internazionali con quelli italiani. Quindi ho dato per scontato che tu avessi studiato all’estero.
Si, due anni. Ho studiato un anno, che è stato fondamentale per me, alla University of Sussex, dove ho avuto due grandissimi professori che mi hanno istigato la passione per il contemporaneo vero che sono David Mellor e Thomas Crow. Ho studiato li 22 anni fa, poi mi sono fatto altro anno e mezzo alla Reading Universtity e due anni alla UCLA dove studiavo Arte antica. A Londra erano gli anni fantastici ’93-’94, dove emersero tutti gli artisti che conosciamo oggi. Il master a Brera ha rappresentato la chiusura di un percorso, e, siccome ero a Milano, andai a fare un tirocinio alla Gam a Torino, dove capii che questo lavoro mi piaceva e lavorai per un anno e mezzo come assistente di Elena Volpato che era già la curatrice della videoteca all’epoca. Una bravissima studiosa. E poi ho avuto uno stop di un anno, per cose personali.
Di dove sei originario?
La mia famiglia è della campagna tra San Gimignano e Volterra, posti bellissimi. Sono rimasto lì fino ai 18 anni. Mi stavo annoiando dopo un anno a casa e chiesi al mio professore di Pisa se mi trovava un lavoro divertente e così mi introdusse alla Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti dove curai un catalogo generale della Galleria con Carlo Sisi, e ci sono rimasto sette anni. Facendo un lavoro sulla parte storica, dal 1792 fino agli anni ’50 del Novecento. Ho fatto questo monumentale libro, circa 3000 pagine, insieme a diversi collaboratori, e poi da lì, sono sempre rimasto con la valigia in mano.
Hai sempre voluto scappare?
In generale io non amo questa città. Amo tante cose di Firenze, ma con difficoltà. Per caso mi chiesero se volevo lavorare al Museo Marino Marini e creare una storia su questo museo. All’epoca ebbi la fortuna di incontrare un presidente, Carlo Sisi, un intellettuale raffinatissimo, che sposò la mia idea di lavorare restituendo una storia. Il Museo non aveva – e tutt’ora non ha – né personale né una dotazione economica. È una fondazione privata a partecipazione pubblica, i due soci sono la Fondazione Marini di Pistoia, che è la fondazione madre, e il Comune di Firenze, di fatto è un luogo che non ha mai avuto una dotazione economica. Non era stato previsto da nessuna delle due parti questo ulteriore sviluppo. Era messo nelle peggiori delle condizioni: era un luogo contenitore. Cosa che tendenzialmente purtroppo oggi si tende a pensare che debbano essere i musei, dei contenitori. Perché i Musei italiani, per la maggior parte, dipendono dall’amministrazione pubblica.

Quindi hai rinnovato il carattere del Museo Marino Marini?
I luoghi devono avere un’identità, come le persone, per avere dialogo, confronto o scontro. E questa identità andava costruita. Ho proposto di lavorare su un contesto, creando un luogo che fosse per certi aspetti una sorta di kunstalle cittadina, un luogo di produzione di progetti. L’analisi logica era: sono in un museo storico, ho la collezione di Marino Marini, non posso prendere la mostra del National Geographic e metterla qui, non ha senso. Potrei, ma non ha senso. Un problema di Firenze era la mancanza di continuità. C’era il bisogno di creare un luogo che lavorasse sulla ricerca nel contemporaneo con continuità, portando a Firenze una dimensione nazionale e internazionale legata all’arte giovane e che ci fosse questo passaggio di consegne, come una sorta di eredità morale ma che poi ridiventava anche materiale da artista a artista. Tutto ciò ha prodotto nel corso di questi sette anni degli effetti estremamente positivi in termini di conoscenza, di visibilità e di comunicazione anche sulla figura di Marino Marini. Una figura che è stata importante ma che è caduta un po’ nell’oblio, come capita sempre, la storia è circolare. Un giorno poi lo recupereranno. Allora ci siamo messi all’opera io e la persona che lavora al museo, che è Gabriele Sorelli, e con lui, con la supervisione di un presidente illuminato, abbiamo creato questo contesto dove ogni euro che spendiamo non è un euro dell’amministrazione pubblica, e tutto nasce da un fundraising che io faccio sul territorio. E poi le cose vanno avanti anche da sé, dopo averle impostate: credo di poter dire senza presunzione che ora il Museo è un luogo abbastanza amato dagli artisti. Amato da un pubblico. In questi anni, facendo un lavoro di nicchia, di ricerca, assolutamente non nazional popolare abbiamo incrementato del 43% i visitatori, siamo passati da 11000 paganti a 17000 paganti, più tutti gli ingressi gratuiti e altro.

Parli di nicchia, infatti lavori con artisti particolari, e Tony Lewis ne è un esempio, è un anno che si parla bene di lui e della sua opera in Italia per il lavoro che compie De Carlo. Come avviene la scelta degli artisti che inviti al Museo?
Chiunque, guardando lo storico delle mostre dal 2009 a oggi, vede che c’è un filo conduttore che è legato a un’indagine sulla scultura oggi, nel senso più dilatato del termine, quindi concettualmente una sorta di indagine a 360 gradi senza più confini e barriere in termini materici, formali o ideologici. È un percorso estremamente legato a me: non scelgo dei dictat di mode o altro. Faccio il mio percorso, chi è interessato mi segue, però rientra in questo discorso che per me è importantissimo, la costruzione di un’identità. Nasce anche dal fatto che io amo molto viaggiare e investo gran parte di ciò che guadagno in viaggio. È l’aspetto per me più intrigante, la grande fortuna di questo mestiere è che puoi conoscere tanti artisti. Il lavoro di Tony, per esempio, l’ho visto tre anni fa.

A Chicago? In che mostra, forse quella curata da Theaster Gates?
Esatto, a Chicago, nella collettiva curata da Theaster Gates. E da lì ho iniziato a seguire il suo lavoro. Lavorava già per Shane Campbell, la sua galleria di Chicago appunto. Non sapevo nemmeno, due anni fa a Fiac vidi due lavori alla galleria di Massimo De Carlo e avendo un rapporto di amicizia con loro della galleria e di stima reciproca, sono andato due volte a trovarlo, da li ho fatto due studio visits, prima di parlare della mostra.

Quello studio bellissimo, grigio e scuro, nell’area ex industriale?
Si, lo studio meraviglioso. Ecco come è andata. Io lavoro così, il mio lavoro è questo. Poi amo molto invitare altri curatori a fare le mostre al museo. Tutto però all’interno di una cornice che sta dentro questo pensiero di un legame e di costruzione di un percorso che poi unitariamente lo puoi leggere come una possibile esplorazione nell’ambito della scultura. Ripeto: lavoro al Museo Marino Marini quindi c’è una cornice. In alcuni casi alcuni artisti, come ad esempio João Maria Gusmão e Pedro Paiva, hanno fatto dei veri e propri lavori su Marino Marini, ma di loro spontanea volontà, non chiedo mai di intervenire in quel senso.
Quindi tu fai vedere il posto agli artisti e loro creano un progetto in relazione?
Si, perché il posto è un posto speciale, molto diverso dal concetto del white cube, della galleria.
È un luogo molto difficile.
Si, difficilissimo. Per molti è un bel challenge. Si misurano con qualcosa che per loro è nuovo. E un’altra cosa che spero di continuare sempre a fare è lavorare con gli artisti in termini di produzione. In fondo in un museo piccolo, destinato come questo come dire, alla ricerca, la produzione di nuovi lavori è fondamentale. Infatti non ho mai fatto una retrospettiva, ho impostato un lavoro che è totalmente dinamico verso il futuro, guarda avanti. Ti confesso che la prima vera retrospettiva che farò, il prossimo 17 settembre, sarà Robert Green. Si sta comunque sempre parlando di una super nicchia, un artista importante, raffinatissimo, molto amato dai curatori e dalla critica, che in Italia non ha mai avuto una mostra, e che in generale ha avuto pochissime mostre, ma avrà due exploits al Whitney e al Beaubourg, perché è un artista importante, essendo morto …
Anche per Tony questa è la prima personale in Italia, in uno spazio pubblico intendo.
Esatto. Tanti artisti qui hanno fatto la loro prima mostra in Italia, o anche la loro prima prima !
E poi mi diverte molto lavorare anche in altri ambiti: ho una passione per la ceramica, e quindi ho costruito una trilogia sulla ceramica contemporanea. Partendo dal ‘900 a oggi. Facendo una mostra su Gio Ponti, una seconda con la Betty Woodman curata da Vincenzo De Bellis, e poi la terza la faremo a fine anno con Julian Sterne, un ceramista straordinario.
Lo spazio che utilizzi è sempre quello del piano di sotto?
No, la ceramica la inserisco in giro per il Museo. E Julian sarà un progetto molto interessante. Rispetto alla ceramica, mi sono posto il problema che la ceramica musealizzata, nella quasi totalità dei casi – a meno che non fossero oggetti celebrativi o commemorativi – escludeva di fatto gli oggetti d’uso dalla loro funzione primaria, mettendoli in una teca. E questa trilogia nasce dal fatto che abbiamo esposto 50 pezzi di Gio Ponti per la Richard Ginori che era tutta produzione e che oggi, invece, è tutto oggetto musealizzato. La seconda è stata Betty Woodman, un’artista che produce anche oggetti d’uso. E il terzo è Julian Sterne, un vero e proprio ceramista e il nostro progetto è di portare al Museo un’installazione dove i visitatori utilizzeranno la ceramica.

Molti artisti negli ultimi due anni sono tornati a lavorare con la ceramica.
A me infatti interessa molto. Perché la ceramica, come l’altra cosa che ho fatto insieme a questa trilogia, quella sui libri d’artista e gli archivi, è un ambito di ricerca che lascia grande libertà agli artisti. Forse i libri in misura ancora maggiore: sono indagini sui materiali, sullo spazio, sul concetto e, tranne alcuni che hanno delle quotazioni altissime, la maggior parte sono comprabili e liberi. A me questo aspetto piace molto. E la ceramica si avvicina molto, è un lavoro che sta concettualmente tra la scultura e l’architettura, e l’oggetto d’uso quotidiano.
È interessante il fatto che tu faccia tante collaborazioni. Che è, purtroppo, un’attitudine poco italiana. E ho visto che un’altra peculiarità del Museo è la collaborazione con tanti artisti giovani anche italiani.
Cerco sempre di fare collaborazioni con curatori e artisti diversi. Nel programma infatti c’è sempre come regola un artista italiano e un artista toscano. Essendo il Museo toscano. Quest’anno è stato invitato Nannucci. Un’altra cosa alla quale tengo moltissimo è il fatto di non fare il classico catalogo delle mostre, ma dei veri e propri libri con gli artisti, che escono magari dopo un anno.
Per questa mostra?
Sarà così. Ho sempre cercato di lavorare nel museo senza omologare il percorso a quello degli altri musei. Ad esempio, il comunicato stampa esce una settimana prima e, nonostante questo, non spendiamo mai un euro di pubblicità e in questi anni siamo uno dei pochi, pochissimi, musei italiani usciti tre volte su Artforum cartaceo, Frieze, su Flash Art, anche l’international, insomma, siamo usciti su tutto …. Ogni tre mesi la redazione di Artforum ci chiede la programmazione e gli artisti che facciamo. Probabilmente poi lo chiedono a tutti …

photo-Dario-Lasagni
Ne dubito fortemente. Artforum fa una ricerca molto dettagliata e sofisticata, si sa.
Sono felice che abbiano iniziato a chiedercelo da un paio di anni, è segno che questo micro luogo è guardato.
Ho letto una tua vecchia intervista online, sui personaggi di Firenze che lavorano nel contemporaneo. Una frase mi ha molto colpito: “il contemporaneo è il miglior antidoto alla spersonalizzazione della città”.
È proprio così: l’arte contemporanea è davvero il miglior antidoto alla spersonalizzazione della città. Sentirsi vivi in questa città significa sentirsi presenti all’oggi, essere contemporanei in questo senso perché è una città rischiosissima in questo senso. È anche, tra le altre cose, una città che ti mette in una posizione di rendita. È una città comoda da questo punto di vista, puoi fare poco e vivere comunque bene. Se erediti la casa della nonna in centro puoi fare il tuo lavoro per passione, affitti su Airbnb. Vivo qui dietro, nella via saremo residenti il 10%, è una follia.
Infatti Firenze, a livello culturale è famosa per i turisti più che per gli italiani. Gli americani, gli inglesi, vogliono venire tutti a Firenze, la culla della cultura passata. Ma venite a Milano!
Ma infatti, pensa a un artista come Tony, intelligente, economicamente potenzialmente ricco. Vieni qui, vai su internet, ti prendi una bellissima casa sulla collina di Firenze per 3.000 dollari, la vita è bella, bevi un buon vino, mangi benissimo. Per poco. E poi c’è tanta cultura. Quella del passato, che poi sono il primo ad amare. Quando vado a New York, sono il primo ad andare alla Frick Collection, o vado a vedere due ritratti di Rembrandt al Met che mi piacciono. Come si fa a dire che questa città non è bella. E questo è il vero problema di Firenze, ed è sempre stato così. Gli americani ricchissimi, gli anglobeceri, che sposavano queste bellissime fanciulle fiorentine di nobiltà decadute, avevano case pazzesche. Negli anni ’20 e ’30, ad esempio, c’è stata la scuola steineriana, i baba famosi dell’epoca, gli Yogi, dall’Europa venivano qui, c’è un mondo esoterico nascosto. Fino agli ’80 era una città interessante, era la città del peccato. Per esempio, i grandi magnati dell’acciaio che venivano da Philadelphia o dintorni, che avevano magari il primo telefono della storia, venivano qui e vivevano volontariamente come nel 1500. Erano famosi questi collezionisti di Cézanne che avevano una villa bellissima, con un carro trainato dai buoi. C’è un libro bellissimo, In villa, di Somerset Maugham…
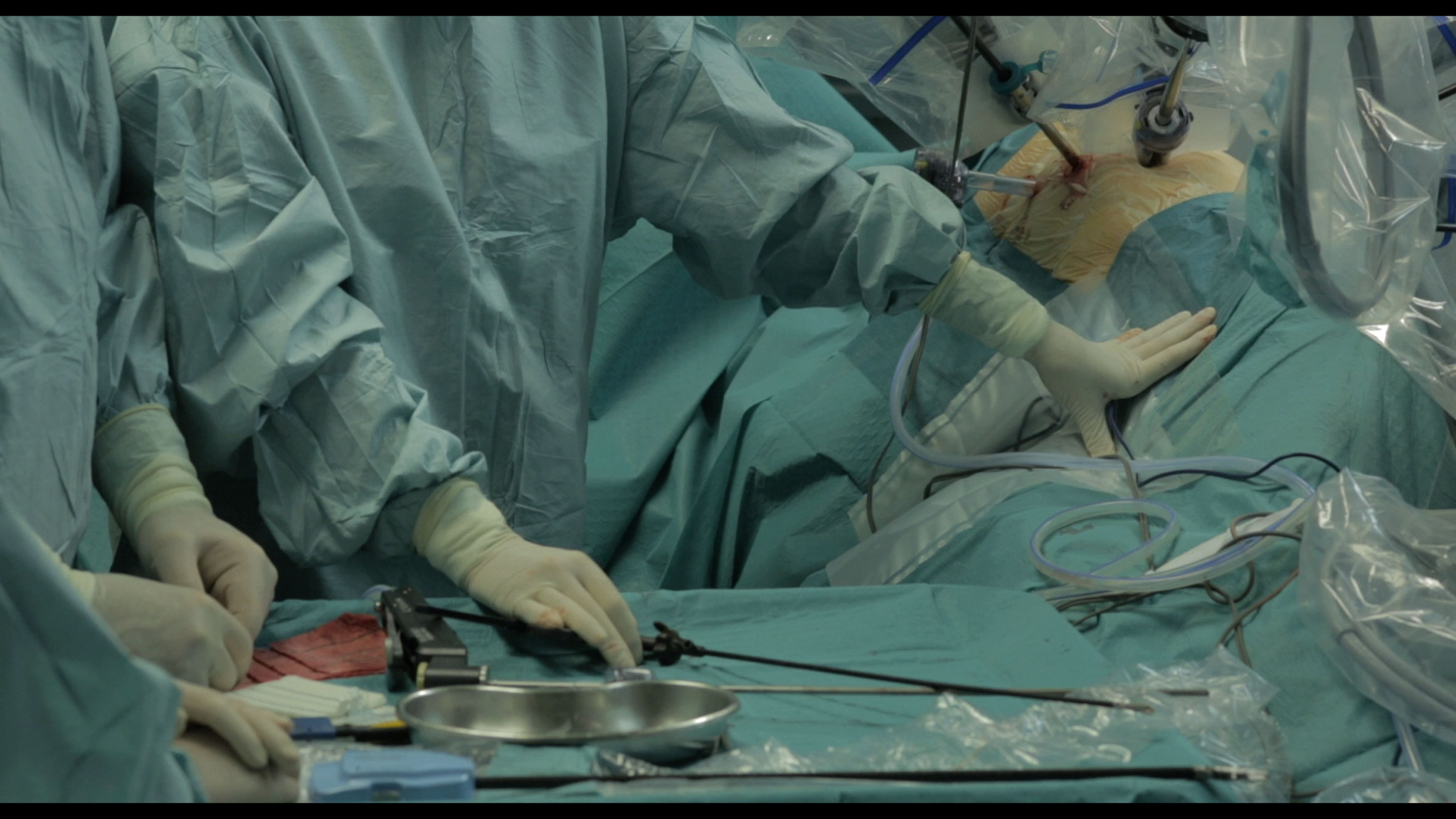
Beh lui era molto attratto da questa tipologia di vita, i ricchi, belli, le feste ..
Esatto, infatti il libro tratta di questa storia d’amore e la descrizione di questa vita di questi anglo americani che vivono a Firenze, c’è una bella descrizione di una passeggiata notturna della città. Il passaggio importante è stato quando Firenze è diventata capitale. Fino all’epoca veniva chiamata la città degli orti, come al Rinascimento, viveva una dimensione ancora molto piccola che piaceva molto e c’era questo sostrato nascosto. Oggi questa massificazione tende a portare porta via tutto, non c’è spazio per questa cosa, bisogna consumare.
Visto che mi hai raccontato molto della città di Firenze e dei suoi cambiamenti, veniamo alla parte che Zero ama di più, quella più divertente.
Vai.
Quali sono i posti che frequenti? Essendo così piccola magari sono sempre i soliti.
La mia vera e grande passione è il cibo. Prima dell’arte. Credo di essere stati uno dei primi in Italia ad avere la tessera dello slow food, negli anni ’90. Quando ancora era un inserto del manifesto, sai Gambero Rosso, quindi da questo punto di vista Firenze mi diverte molto. Amo molto andare al Mercato di Sant’Ambrogio, quando sono in città il sabato mattina non manco mai. Amo molto andare in alcune trattorie della città che sono Il Troia, Cafaggi, uno dei miei luoghi preferiti. E poi Firenze si, è la città delle trattorie, non dei ristoranti, amo molto Ruggero. Anche Camillo è buono, è una finta trattoria: la qualità del cibo è altissima, è tradizionale, ma non si spende poco, però si mangiano delle cose che fanno solo lì. Il pasticcio di piccione è straordinario. Il santo Bevitore è un posto buono dove sono molto bravi. Firenze ha delle eredità che sono un po’ austriache e un po’ inglesi, infatti uno dei piatti storici in queste trattorie buone sono i gamberi al curry e il vitello con riso e curry. Totalmente inglese. Da Camillo si mangia, per me, il curry più buono in città.
Poi amo molto andare a farmi delle passeggiate, vedermi le chiese da solo. Il Duomo è pazzesco. Poi un posto molto bello dove andare a prendere il caffè è il Caffè delle Oblate, con una terrazza bellissima. È una biblioteca pubblica. Ce l’ho vicino a casa quindi la sera ogni tanto vado. Non sono molti i bar dove mi piace andare perché bevo molto bene a casa. Non c’è un equivalente del Bar Basso a Firenze in questo senso. C’erano dei bar storici che però purtroppo hanno perso questa loro aura.
Ci sono però delle zone con dei bar e locali, mi viene in mente il quartiere di Santo Spirito.
Si, Santo Spirito è il luogo dove ci si ritrova. Sai, ora io sono un po’ grande, è un posto per i venti-trentenni. Questi sono un po’ i posti dove vado, non vado mai in discoteca. Anche se c’è un posto molto divertente dove ogni tanto vado con la mia compagna, che è una delle discoteche gay più antiche di Italia, il Krisko
Come il Glitter o il Plastic di Milano?
Esatto.
E la musica la segui?
Amo molto i concerti. Qua a Firenze c’è il Musicus Concentus alla Sala Vanni, dove fanno bei concerti.
Infatti stasera, con Tony, Greg e Cheneé andiamo a sentire Bilal che canta proprio li. Vieni con noi!
Mi piacerebbe, anche perché loro sono dei cari amici che fanno un bel programma. Ma tra poco parto e vado via per il compleanno della mia compagna.
E dove andate?
Andiamo in Maremma. Ecco, il Musicus è un posto molto figo, vedrai. Amo la musica, infatti al Museo abbiamo prodotto un programma musicale abbastanza tosto.
Ma infatti, per ciò che ho potuto notare e dai tuoi racconti, questo Museo è molto fortunato ad averti: con questo bagaglio che hai assorbito negli anni, gli studi, i viaggi, le passioni etc. avresti potuto andare a lavorare a New York, o a Los Angeles, e invece tu hai preferito prenderti cura di questo luogo storico, molto bello, ma che appunto era stato un po’ trascurato.
Ci sto bene. Ora sono quasi dieci anni e ti confesso che in vita mai non ho mai fatto la stessa cosa per più di otto o nove anni. Fino a ora è stata un’esperienza molto bella di grande creatività, di grande gioia. E credo che la cosa più interessante che uno possa fare sia costruire qualcosa dal niente e lasciarlo a qualcun altro. Questo è molto importante. Se poi quello dopo di te fa meglio, allora è perfetto. Sarei ancora più contento.
Questo è un po’ il mood con cui sei partito con la programmazione: il passaggio di consegna tra il maestro, in questo caso Marino Marini, e gli artisti contemporanei, può rappresentare il tuo passaggio di consegna a curatori più giovani.
Mi auguro infatti a breve di spostare i miei interessi altrove e che ci sia un passaggio di consegna e che chi viene dopo di me porti avanti questo lavoro con una personalità diversa. Che lo faccia crescere ancora, penso sia la cosa più divertente. Non amo l’idea, molto italiana, di “tenersi” le cose. A me non piace. Infatti faccio mille cose, collaboro con un sacco di gente, anche se non sono uno per nulla social. Non amo stare in mezzo alla gente. Magari tendo, non apposta, a tenere a distanza persone che non conosco.
Un’altra domanda allora che ti pongo è sulle tue relazioni in questa città. Chi frequenti, chi sono i tuoi amici?
Frequento principalmente persone che non c’entrano niente con il mio lavoro. HO egli amici che mi porto dietro da quando avevo vent’anni che rappresentano la mia famiglia. Penso a Silvia Pellizzari, la montatrice storica di Studio Azzurro, un’altra amica storica si chiama Letizia e vive a Venezia e coordina una scuola di restauro. Un’altra è Katia, anche lei vive a Venezia e fa un altro lavoro rispetto al mio, è una raffinatissima storica dell’arte. Poi c’è la Chicca, Francesca Recchia, è lei che ha fatto di tutto di più, da Documenta con Okwi Enwezor, e vive da 3 anni a Kabul, e ci si vede tre volte all’anno, insomma questa è la mia famiglia.
E gli artisti con cui lavori?
Dipende. Con alcuni si diventa amici, con altri no, siamo rimasti in buoni rapporti, ma non amici. È una parola importante. Non riesco a estenderla troppo. Poi ti dico, casa nostra è un porto di mare: abbiamo una stanza per gli ospiti che è sempre piena. Questa è un’attitudine che, se hai studiato all’estero, ti porti dietro.
Anche la tua compagna lavora in ambito culturale?
Si, è curioso perché è una specialista in mobili antichi e pietre dure e il suo lavoro è quello di valutare le collezioni private. Arte antica. Infatti non mi segue quasi mai sul lavoro. Privatamente si. Comunque non ho mai capito l’amicizia in ambito relazionale, come costruzione di relazioni, per me l’amicizia ha dei principi fortissimi. E gli amici veri esistono. Quello che ho sempre cercato di fare è di essere me stesso al di la di tutto.
Mi pare che ci siamo detti tante cose interessanti.
Rossella, trattami bene! ahah!
Guarda Alberto, non c’è n’è bisogno!





