«Vive a Milano. Head of content di Alkemy Digital Enlaber, ha diretto Vice Italia fino al 2012. Giornalista e film-maker, ha co-fondato l’Ultimo Uomo nel 2013 con Daniele Manusia e nell’aprile del 2015 Prismo, rivista online di cultura contemporanea. Scrive regolarmente per GQ, L’uomo Vogue, Linus, e ogni tanto anche per IL, Undici, The Paris Review e Rivista Studio».
Citata testualmente, è la biografia online di Timothy, detto Tim, Small che, vista l’intraprendenza del personaggio, stamattina potrebbe già avere un paragrafo più di ieri sera. Detto altrimenti, se dai una controllata ai dietro le quinte dei progetti editoriali più effervescenti degli ultimi anni, il nome di Small, in un modo o nell’altro, lo trovi.
In questi giorni il suo «l’Ultimo Uomo» celebra il terzo compleanno. Abbiamo colto l’occasione per incontrarlo e farci dire tutto. Ma tutto tutto, tipo quella scena dei Goonies con l’interrogatorio di Chunk e il frullatore.
Senza che la cosa ci abbia sorpresi, tutto è proprio quello che Tim ci ha detto, nessun pudore farlocco o reticenza. In fondo, ad ascoltarlo e a ripensare ai progetti legati al suo nome, una cosa è evidente: Tim Small non le manda a dire. Tendenzialmente preferisce scriverle. O, più di recente, cucirci sopra un progetto editoriale come manco un sarto.

Zero – Che cosa spinge uno che ha portato «Vice» in Italia a mollare tutto?
Timothy Small – In parte l’incoscienza; ho 33 anni e ho iniziato a Vice quando ne avevo 22, come stagista. Ho fatto poi micro avanzamenti nell’ufficio a Londra; all’epoca eravamo in 7, una situazione completamente diversa da quella attuale. C’erano solo Vice America, Vice Inghilterra, Giappone…
Avevi studiato là, giusto?
Sì, avevo studiato in Inghilterra, poi master a Londra. Scrivevo, ero un ragazzino e loro mi presero per uno stage; un giorno il caso vuole abbia risposto a una telefonata di Andrea Rasoli, che poi è diventato il publisher di «Vice Italia». Mi disse: «I’d like to open Vice in Italy» e quando risposi in italiano rimase un po’ spaesato. Da li iniziò un processo che portò al primo numero, nel giugno 2005.
Eri appena rimpatriato?
Da poco. Sono nato e cresciuto a Milano, a 17 anni sono andato in Inghilterra e sono tornato a 22. C’è stato un anno in cui andavo e tornavo da Londra perché avevo ancora casa lì, infatti il primo numero di «Vice» l’abbiamo corretto stampando le bozze nell’ufficio di mia madre, un appartamento in piazzale Accursio. Eravamo io, Federico Sarica, che oggi è direttore di Rivista Studio, e Fabrizio Ferrini, che a quei tempi faceva «Caffè e latte» e adesso «Hunter».
Poi abbiamo imboccato strade separate… Fabrizio si è allontanato piuttosto presto; noi abbiamo messo insieme lo staff e «Vice Italia» è cresciuto. Ormai sono passati tanti anni, molte persone sono andate via e altre sono arrivate. Io ero li da 7 anni e non conoscevo nient’altro; probabilmente ero un po’ stufo, perché quando lavori per così tanto tempo in un’azienda editoriale, soprattutto in una realtà caratterialmente forte come «Vice», o incarni quello spirito e in qualche modo lo diventi, oppure non ti ci riconosci più a pieno.
Appunto, quando ho iniziato avevo 22 anni, 30 quando ho mollato; nel frattempo ho vissuto la mia vita, accumulato esperienze diverse e visto i miei interessi andare in altre direzioni. Ecco, mosso dall’incoscienza di uno che non aveva mai fatto altri lavori, ho detto basta.
Ma avevi le spalle coperte, suvvia…
Ni, nel senso non troppo. Ancora non ho una casa di proprietà, pago un affitto per dire, però vantavo un po’ di collaborazioni freelance, giravo video, continuavo a scrivere e già pochi mesi dopo aver lasciato «Vice» ho iniziato a collaborare in maniera continuativa con «GQ Italia» e questo mi ha aiutato molto. Ho firmato un contratto di collaborazione continuativa, che ai tempi si faceva ancora. Scrivo per tantissime riviste, quindi all’inizio sopravvivevo di quello, poi anche di altre cose che facevo fra l’Italia e l’America; nel frattempo avevo fondato «The Milan Review», una piccola casa editrice di fumetti e letteratura. E insomma, mi sono detto vediamo cosa succede… Oggi non credo lo farei, perché conosco meglio il mondo del lavoro e non sono certo sia saggio lasciare qualcosa e sperare.
Quindi incoscienza fino a un certo punto…
Ho avuto anche fortuna, comunque.
Chiaro. Per «Vice» hai anche diretto la fiction, giusto?
Sì, dal 2011 all’anno successivo ho curato i numeri dedicati alla narrativa. Ogni anno si pubblicava uno speciale e ne ho curati 2 a livello globale. Poi ogni numero dell’edizione americana, in quegli anni, aveva un racconto e io gestivo i rapporti con gli scrittori. Anche grazie a «The Milan Review», fondato con il mio amico Riccardo Trotta, avevo un mio network.

Che cosa è cambiato da quando sei arrivato? Immagino tu segua e legga ancora «Vice»
Onestamente negli ultimi anno lo seguo poco. Ho qualche impressione, ma qualsiasi cosa dicessi sarebbe superficiale perché non sono più dentro.
Quando ero lì abbiamo lanciato il canale video realizzando solo cose per il web. Nel frattempo sono andati in televisione in Italia e nel resto del mondo. In America sono diventati un’azienda gigantesca. L’ho vista dall’inizio ed era un’azienda direi strana, unica, di famiglia, però iniziava ad avere l’ufficio in Germania, a Parigi, a Barcellona, in Asia…
Immagino vi conosceste tutti
Eravamo in pochi: ci saranno state in America 30, 40 persone, 10 a Londra, 5 in Svezia dove c’era l’altra edizione e probabilmente 5 in Giappone. Solo dopo l’apertura della sede italiana sono partiti «Vice Francia», Germania, Spagna… Oggi è un colosso presente in credo più di 30 Paesi. Ne ho vissuto tutta l’evoluzione iniziale, quando era solo una rivista cartacea, senza la versione web.
Ricordo un editoriale di un paio di anni fa del „New York Times“ in cui si spiegava come e perché uno dei concorrenti più credibili della Cnn fosse proprio Vice
Sì. Qualche anno fa si diceva che «Vice» sarebbe dovuta diventare la Cnn dei giovani, muovendosi dall’idea che Cnn avesse un pubblico mostruoso, ma non riuscisse a raggiungere gli under 40. «Vice» era il contrario. Non dico ci siano riusciti, però ci sono quasi.
«Ci sembrava assurdo che un italiano non potesse fare un articolo del genere»
Parliamo dei tuoi progetti: siamo qui perché «l’Ultimo Uomo» compie in questi giorni 3 anni, mentre «Prismo» ha festeggiato il suo primo anniversario ad aprile. Come sono nati, da quali passioni, quali necessità?
«l’Ultimo Uomo» è nato da un’idea mia e di Daniela Manusia, che scriveva con me su «Vice». Gli avevo affidato una rubrica di calcio intitolata Stili di gioco, che oggi è il titolo del suo tumblr e il nome della newsletter di «l’Ultimo uomo». Avevamo entrambi voglia di vedere prodotti editoriali legati allo sport in maniera diversa. In parte ci rendevamo conto che sul calcio, e la cosa è ridicola, gente come noi, desiderosa di condividere articoli su Facebook, dovesse andare a pescare i pezzi meravigliosi di Brian Phillips, che adoro, per carità di Dio, ma è uno di Oklahoma City che scrive del Napoli.
Ci sembrava assurdo che un italiano non potesse fare un articolo del genere sia dal punto di vista più squisitamente narrativo, che da quello dell’analisi tecnico tattica.
In Italia i periodici non hanno mai funzionato, non hanno mai fatto parte della nostra cultura; il mensile con l’articolo lungo, con l’approfondimento, la rivista borghese come il «New Yorker», per intenderci, non ci sono mai stati, e forse anche per questo praticamente tutta la comunicazione sportiva nel nostro Paese era incentrata sul quotidiano.
L’idea era di ricavarci uno spazio nostro, in cui pubblicare questo genere di articoli. Detto altrimenti, volevamo capire quanto e se fossimo in grado di fare Grantland in Italia e per farlo abbiamo messo insieme un po’ di amici pescandoli fra designer, programmatori, appassionati di sport.
Nel primo mese siamo stati notati da 20mila persone, il secondo da 50 e il terzo da 100mila; magari c’è qualcosa, ci siamo detti. Ora siamo a un milione e mezzo di pagine viste mensili.

Ecco, come funziona «l’Ultimo Uomo»?
Ha un direttore che è Manusia, lui imposta la linea editoriale e sceglie i suoi collaboratori. Riceve un grande aiuto da parte del caporedattore centrale, Emanuele Atturo, e stanno entrambi a Roma. Ci si sente regolarmente, per quanto io sia a Milano. La cosa importante da considerare è che a un anno dalla sua fondazione, ho venduto «l’Ultimo Uomo» ad Alkemy, un’agenzia di servizi digitali con sede a Milano nell’ambito della quale volevo aprire un dipartimento dedicato ai servizi online, offrire consulenze aziendali e poter realizzare progetti nostri come, appunto, «l’Ultimo Uomo». Quindi, con il supporto di Alkemy, non solo in termini economici ma anche di personale, abbiamo ridisegnato tutto. È nata Alkemy Content, la divisione che dirigo io, all’interno di Alkemy Communication. È una situazione sperimentale, ma sta dando grandi frutti.
«…non ci interessano il programmatico o lo spazio promozionale invasivo, quelle cose che fanno povertà»
«l’Ultimo Uomo» si sostiene grazie a questa proprietà, giusto? Non mi sembra offriate spazi pubblicitari tradizionali
Cerchiamo di lavorare con poche pubblicità, non ci interessano il programmatico o lo spazio promozionale invasivo, quelle cose che fanno povertà. Vogliamo costruire un modello basato sulla qualità dei contenuti; se sei autorevole nel tuo campo puoi lavorare e vendere a determinati brand. Infatti ci siamo mossi così: abbiamo collaborato con clienti importanti come Adidas, Coca Cola, Sky, Nike, e prodotto contenuti originali per loro. Per Adidas abbiamo pubblicato tre longform interattivi, che ci hanno fatto vincere premi internazionali e fatto davvero bene. Sia a noi che a loro.
Online vale la stessa cosa: presente il banner sopra l’articolo, quello che odiano tutti? Ecco, no; se riusciamo a fare contenuti di qualità sponsorizzati dal brand, al mio lettore arriva quella, la qualità. Lui l’articolo lo leggerebbe comunque e in più gli sto comunicando valori legati al marchio in questione. Per intenderci, invece dell’articolo sulle scarpe di Messi, ne faccio uno sul calciatore. Non ti scrivo una cosa dedicata alle calzature di Cristiano Ronaldo, ma ti racconto di quanto sia veloce lui, e questo aiuta a comunicare il brand in maniera migliore.

La fai facile, ma quanto tempo è passato prima che clienti di questo peso arrivassero?
Adidas è entrata 6 mesi dopo…
Appunto, e in quei sei mesi come hai campato?
Avevo qualche soldo da parte dopo la mia uscita da «Vice» e cose che mi hanno permesso di tenere in piedi «l’Ultimo Uomo» anche nel periodo di avviamento. Sia chiaro, nessuno veniva pagato: con tutti i nostri collaboratori ci siamo detti «ragazzi è una sfida, vediamo come va».
Stai suggerendo che la famigerata crisi del giornalismo possa essere contrastata attraverso contenuti profilati e di alto livello?
Non so se si combatta così, ma di certo la qualità non fa male. Non penso però sia una questione di articoli approfonditi, piuttosto di stimolo a far qualcosa di diverso, a ragionare sul tuo prodotto editoriale e non come fanno tante riviste in Italia, quasi stessero portandosi sulle spalle la responsabilità di educare il popolo.
Se ci ragioni in termini di prodotto, c’è un target là fuori che vuole comprare il mattone, il libro di 1500 pagine sulla battaglia in Kosovo del 1360. E magari c’è anche gente che vuole un fumetto di 30 pagine di Linus, l’importante è far bene quella cosa, essere rilevanti per il tuo pubblico e ragionare dal punto di vista economico.
Con «l’Ultimo Uomo» ci siamo ritagliati la nostra nicchia, sapendo dell’esistenza di un target che siamo andati a colpire con contenuti specifici, con cose che secondo noi erano interessanti per quel pubblico.
Certo, quando dico andare a colpire un target sembra un concetto preso dal marketing, in realtà è un ragionamento intuitivo: quello che abbiamo fatto si è basato molto sul naso, su cose che ci piacevano davvero. Abbiamo solo seguito un’intuizione nata andando al pub con gli amici e vedendo tutti insultare Massimo Mauro perché la sanno più lunga di lui, notando come poi si rimanesse a parlare di calcio per tre ore, magari dei movimenti dei terzini del Milan nel ’94. La riflessione a quel punto è stata naturale: se questo è il livello di approfondimento italiano, se in America esistono riviste sportive approfondite, perché non farlo qua?
Non fa una grinza
C’era un buco di mercato. Non ho mai ritenuto stupidi gli italiani e nemmeno credo detestino leggere. Sono più convinto che la responsabilità sia da attribuire a chi, i contenuti, li crea. Se le persone ignorano quello che scrivi, sei tu ad aver sbagliato qualcosa. Ovviamente è sempre più difficile, perché la competizione oggi è con Facebook, con Candy Crash e Plants vs Zombies, con Playstation 4 e Oculus Rift, con il cinema 3d e la birra con gli amici. Di alternative per trascorrere il tempo ce ne sono parecchie e per questo devi lavorare quel tanto di più per capire cosa voglia davvero la gente. Ma non solo; occorre anche cercare di cogliere i bisogni inespressi. Ovvio, non c’è un focus group che ti dica quanto gli italiani vogliono una rivista d’approfondimento sportivo, però magari ci arrivi con il naso giornalistico…
Mi sembra tu stia parlando da editore, che poi è forse il tuo ruolo principale. Bene, all’editore dico che se esasperassi il suo ragionamento, potrebbe capitare prima o poi di intuire che il pubblico abbia bisogno di una grande rivista sui lepidotteri. A quel punto?
Mi darei da fare e troverei un direttore capace di farmi una grande rivista sui lepidotteri. Finora ho sempre e solo fatto cose che mi piacevano, sono una persona egoista in questo senso e se una cosa mi piace bene, altrimenti non la faccio o trovo i modi per evitarla.
Quindi non solo il focus group, una cosa deve anche interessarti personalmente
Tutti i progetti a cui lavoro mi gasano e mi viene voglia di farli; se poi uno riesce a confezionare un prodotto editoriale anche capace di migliorare un po‘ la vita culturale delle persone – e te lo dico da egoista megalomane – allora mi fa piacere. Faccio sempre lo stesso esempio: quando abbiamo pubblicato «l’Ultimo uomo», Daniele voleva scrivere un articolo su Yoann Gourcuff, grande trequartista mai espresso nel suo pieno potenziale, uno che avrebbe potuto essere il nuovo Zidane ma non lo è mai diventato. Insomma, fosse stato una canzone degli 883 si sarebbe intitolata Dovevo essere il nuovo Zidane.
Daniele scrisse l’articolo, bellissimo, approfondito, psicologicamente preciso, tagliente, sottile, quasi commovente anche nell’analisi tecnica. Mi ripetevo, «Cavolo bellissimo, ma quanti lo leggeranno?». Bene, eravamo agli inizi e fu il nostro primo articolo di successo. Fece 7mila lettori, che allora per me era tantissimo. Oggi un nostro articolo ne fa 150mila, ma ai tempi era sconvolgente anche perché venivo dall’editoria indipendente.
Non credo di aver colto; come ha funzionato, hai pubblicato l’articolo e?
Sì dai, abbiamo usato i social, un po’ di reputazione l’avevamo, gente che ci seguiva…

Invece The Towner è partito già con uno sponsor, Moleskine. Pensi che questa possa essere una delle prospettive dell’editoria?
Sì, dall’inizio la mia idea è stata andare proprio da loro. Erano il cliente perfetto.
Puoi descrivere The Towner?
È una rivista di città e cultura, che è diretta nell’edizione italiana da Valerio Mattioli, anche al mio fianco come caporedattore di «Prismo», e in quella internazionale da me. Ha uno staff in giro per il mondo, da Beirut a Los Angeles, New York, Londra…
«Nel futuro parleremo un po’ anche di architettura e urbanistica, altri argomenti su cui c’è una carenza, in Italia, dal punto di vista dell’editoria pop»
In quante città la pubblicate?
Escono l’edizione italiana e quella internazionale, che in realtà è l’edizione americana. Ogni giorno pubblichiamo uno o due articoli, è solo online ed è sponsorizzata da Moleskine. La versione italiana tratta di città, cultura, posti, parla di storia in modo diverso dalle altre riviste.
Per me è importante distinguersi e chiedo perdono perché so di essere su Zero, ma vogliamo fare un lavoro lontano dal sito di listing. Trovo poco carino un sito che parli solo di appuntamenti, che dica quali sono i migliori pub, i migliori ristoranti, le 10 piscine, i 9 concerti. Vero, tu mi stai riempiendo l’agenda, ma a me manca quella cosa molto bella per cui se vai a Mantova con un tuo amico di Mantova quel tuo amico ti racconta storie assurde su Mantova. E magari le storie dei suoi amici, la scena culturale, gli scrittori, i musicisti passati di lì; sono queste cose a farmi innamorare di un posto e molto più dei concerti in arrivo. Sia chiaro, è un servizio utilissimo, che però noi non diamo.
Nel futuro parleremo un po’ anche di architettura e urbanistica, altri argomenti su cui c’è una carenza, in Italia, dal punto di vista dell’editoria pop.
Non annoio il lettore con repliche dirette, preferisco tornare sugli orizzonti dell’editoria, quel nascere con un contenuto già sponsorizzato prima ancora di averlo prodotto. È stata una tua idea?
Sì, ma non abbiamo inventato noi i brand magazine, sia chiaro. Quello che volevamo fare era lavorare con un cliente di prestigio come Moleskine, credibile nel suo campo, autorevole nel mondo della creatività, fra giornalisti, scrittori, artisti, illustratori che poi sono il nostro target. In questo senso abbiamo il vantaggio che, pubblicando libri, Moleskine è già un editore, cosa che implica un rispetto per il profilo creativo differente, che in altre aziende magari richiede un processo didattico per essere ottenuto. Con Moleskine è stato più facile, tanto da farmeli percepire più come un editore che come un partner commerciale. Vogliamo trasferire dei valori e dare a nostro modo qualcosa, un regalo, al target di Moleskine che, appunto, corrisponde al nostro.
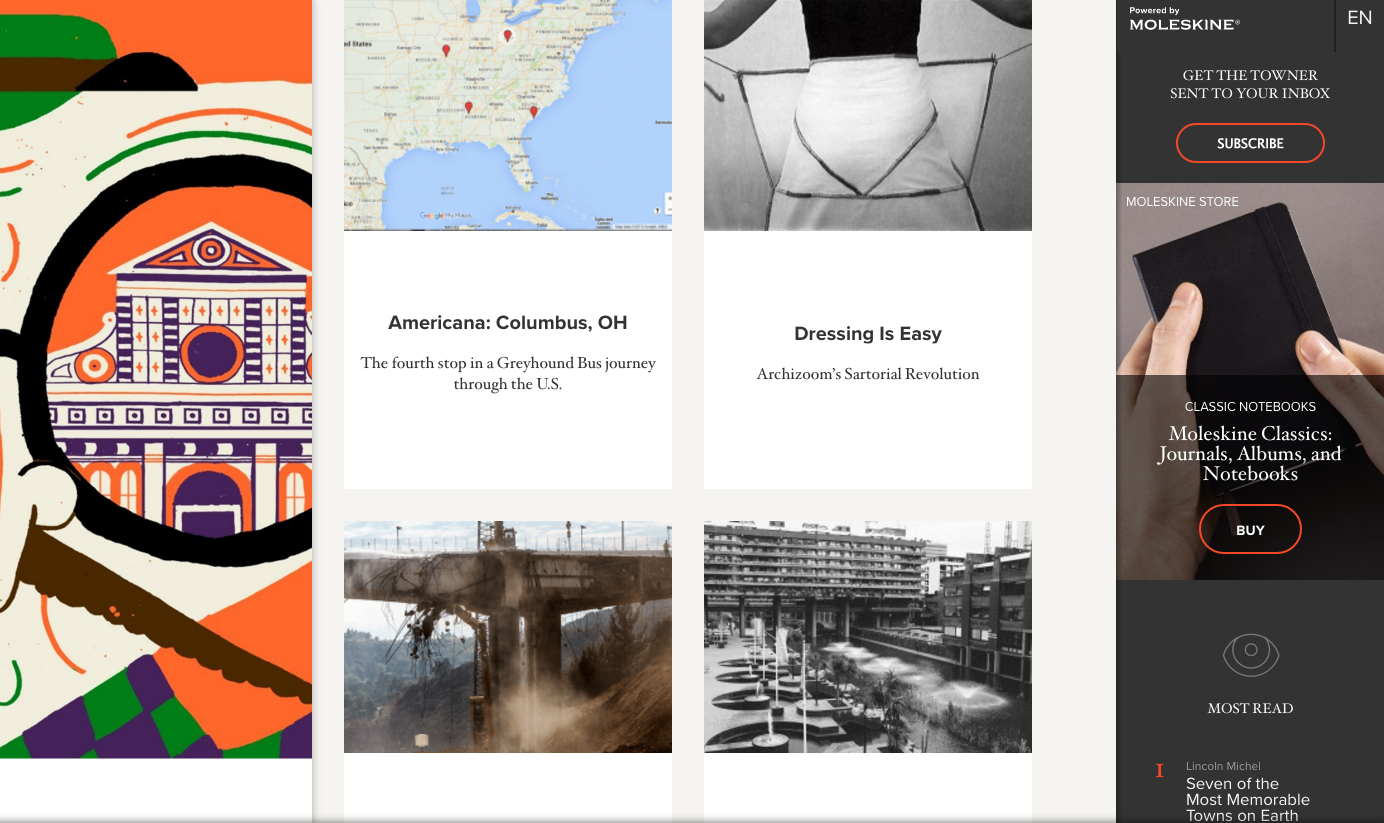
Insisti sui contenuti di alta qualità, ma ti faccio notare che, per esempio, il „Guardian“ accusa una perdita operativa di 56 milioni e rotti di sterline solo quest’anno, e pare che la tendenza permarrà anche per i prossimi
D’accordo, ma arriva anche da 3 anni di spese folli, in cui hanno aperto qualcosa come 56 uffici regionali, perché volevano diventare il più grande quotidiano digitale del mondo. Hanno 950 milioni di pagine viste, ma anche un numero di assunti sconsiderato – tanto che sono stati annunciati 250 licenziamenti di cui almeno 100 fra i giornalisti, ndr. Insomma, non credo a loro servano una redazione a San Francisco e una a Los Angeles. Hanno speso tantissimo e costruito qualcosa di assurdo.
Questo per dire che occorre giudicare caso per caso. Non penso che se un progetto di branded content va male, allora sia il branded content tout court a non funzionare. Se Rcs licenzia 800 persone, non penso sia il giornalismo digitale a non andare. È forse più probabile il gruppo abbia preso decisioni pessime e ora tocchi pagarne lo scotto. Pensa a «Grantland» stesso: lo aprono ed è un successone, lo chiudono, Bill Simmons litiga con quelli di Espn e due settimane più tardi firma un contratto con Hbo. Motivo? Semplice, lui è uno bravo, è un’altra delle menti rubate alla scienza. Se avesse fatto il microbiologo probabilmente avrebbe trovato la cura per il cancro.
Oggi tante multinazionali stanno aprendo redazioni proprie. Se da una parte è una prospettiva interessante, dall’altra non credi sia un rischio per l’editoria tradizionale?
La strada che ho intrapreso per lavorare all’interno di un’agenzia digitale parte da ragionamenti simili.
È come se tu concepissi prodotti da vendere, o sbaglio?
In alcuni casi sì, in altri rispondo a gare, oppure consulenze, o sviluppo contenuti dal punto di vista puramente corporate riempiendo di testi i siti aziendali. Quindi dipende, è uno spettro ampio, ma nel caso di un prodotto come «The Towner» capisco cosa tu intenda quando citi le multinazionali e le loro redazioni. Non lo vedo come un rischio; quello che abbiamo messo in piedi, e certo non dico tutti debbano replicare, è un sistema che consente un certo tipo di giornalismo e ci permette di portare avanti un modo di raccontare e parlare alle persone basato su contenuti di qualità, che poi per me rimangono l’aspetto più importante.
Se produci cose buone, rimangono tali che tu le abbia fatte per Moleskine oppure per Rcs. Peraltro non dimentichiamoci che in Italia non è che le aziende editoriali siano pure; non ce n’è una che non abbia interessi in altre industrie. Ma se le cose sono fatte nel modo più giusto e migliore possibile, allora il progetto è sostenibile.
Tutti parliamo di Snow Fall da quattro anni, ma senza la Bmw non l’avrebbero fatto. Quindi vuoi fare Snow Fall e non hai i soldi per potertelo permettere? 100 anni fa magari saresti andato dai Rothschild chiedendo di finanziarti, come si fa nel capitalismo. Oggi i brand hanno i soldi da spendere e non sono soddisfatti del modello pubblicitario tradizionale, che per molte ragioni non ha funzionato o non funziona più. Ecco allora il tentativo di fare cose differenti.
Fin quando troverò qualcuno disposto a finanziare progetti editoriali di qualità, e noi potremo fare in modo che gente in gamba come Daniele Manusia, o Valerio Mattioli, o Cesare Alemanni, possa fare bene il proprio lavoro, io sarò contento. Poi, ovvio, la strada che ho intrapreso io non è per forza quella giusta per tutti.
Gli argomenti che ti piacciono finiranno prima o poi
No invece. Ora, per esempio, sto lavorando a un progetto che sarà il fiore all’occhiello di tutta questa operazione. Sarà online a settembre e sarà bellissimo. Si chiama Il tascabile.
Ormai progetti, più che scrivere
Non ho quasi mai tempo di scrivere. Quello che faccio ha una componente strategica e un’altra che consiste nel saper lavorare con le aziende con un approccio quasi „pre creativo“. Mi è richiesto un certo livello di conoscenza del mercato editoriale, una caratteristica propria di un editore, ma non sono uno che mette insieme una cosa e lascia fare. Sono molto presente: alle riunioni di redazione di «Ultimo Uomo» ci sono, su «Prismo» e «The Towner» anche, per il lancio de „Il tascabile“, pure. Per farla breve, spendo il mio tempo dove serve di più.
Ti interessi di letteratura, videogiochi, fumetti; che cosa racconta meglio l’epoca che stiamo vivendo?
Forse il film di Angry Birds.
La questione evoca una narrazione integrata, proprio e soprattutto per Angry Birds, attorno al quale si costruisce un mondo accessibile da tanti ingressi. A proposito, molte riviste alla moda, passami la definizione, vivono questa ossessione moderna dello storytelling. È un vezzo, o qualcos’altro? E soprattutto che cos’è lo storytelling?
Ecco, faccio molta fatica a capirlo. Da un punto di vista analitico dobbiamo in primis essere d’accordo su termini e definizioni, poi possiamo dibatterne. Ho letto articoli che spiegano perché «lo storytelling sia il male del giornalismo» partendo da una definizione e da presupposti specifici. Ma la questione è che non è detto lo storytelling sia per forza quella roba lì. È come se sostenessi che la tavola è la maledizione delle sale da pranzo, perché sotto ci è morta un sacco di gente, perché i tavoli sono fatti a mano dai bambini e chissà cos’altro. Insomma, ho studiato filosofia e so che con la retorica è possibile far credere a tutto. Dipende da quel di cui stiamo parlando. E dall’amore.
Allora dammi una definizione e il tuo relativo giudizio di valore
Eh, non lo so; è un termine inventato dal marketing e lo puoi mettere ovunque. È come quando la gente mi chiede cosa ne pensi dell’ironia. Boh, che cazzo ne so?, se mi fai leggere una battuta che fa ridere ok, è buona. Altrimenti fa schifo. Fine. Storytelling, in fondo, significa raccontare. Non sono Sun-Tzu, non passo la mia vita a pensare a massime filosofiche. Posso solo dirti se un prodotto è buono oppure no, giudicando i casi uno alla volta.
Elencami gli autori che ti piacciono e che leggi
In Italia credo si sia commesso un errore grave nel considerare poco Guarigione, il libro del 2014 di Cristiano De Majo. Bellissimo, è quello che io considero oggi un romanzo interessante. È un andare avanti e indietro nel tempo, un libro di memorie che racconta la vita di un uomo cui nascono due gemelli e che affronta una malattia. Non ha trama. A dire il vero faticherei a dirti di cosa parla la maggior parte dei libri che ho amato. Perché non è importante cosa raccontino, può essere qualsiasi cosa.
Ben Lerner mi piace molto. Pete Dexter l’ho amato. Tutto Denis Johnson. Meridiano di sangue. I racconti di Cheever. Tutto Barthelme. William Gibson. Nella non-fiction è notevole Io e Mabel di Helen MacDonald, uscito per Einaudi quest’anno. Adelphi ha da poco ripubblicato la ristampa della biografia di Philip K. Dick scritta da Emmanuel Carrère, Io sono vivo, voi siete morti. Adoro anche la noir fatta bene, tipo Charles Willeford, Richard Price, Elmore Leonard. Il romanzo migliore che abbia mai letto è probabilmente Parla, ricordo di Nabokov.

Versione Kindle?
Fatico a leggere su Kindle e lo evito, sempre non si tratti di volumi enormi come quelli di Stieg Larsson. Ultimamente mi sono molto piaciuti la Trilogia dell’area X di Jeff VanderMeer e quest’estate ho intenzione di divorare la Mars Trilogy di Kim Stanley Robinson.
Non mi hai nominato giornalisti; non ti piacciono?
Sono fan di John Jeremiah Sullivan e di Americani, la sua raccolta di saggi per Sellerio. È un grande giornalista… Poi, guarda, me ne verranno in mente altri, ma ora no… Ah, c’è quello che mi ha fatto capire come si possa scrivere bene di videogiochi, Tom Bissell, l’autore di Voglia di vincere, un libro bellissimo.
Siamo tornati a parlare di cultura. A qualche mese dal suo primo compleanno, raccontami meglio «Prismo»
Si può dire sia il passaggio da «l’Ultimo Uomo» a «The Towner». L’idea è nata all’interno di Alkemy, di cui oggi sono socio, perché volevamo aprire una rivista diversa da «l’Ultimo Uomo», qualcosa che trattasse la cultura a modo nostro, che desse uno spaccato di cos’è oggi il mondo. Anche in questo ambito secondo noi c’era un vuoto, una mancanza legata a un discorso generazionale: ho sempre trovato assurdo che in Italia, se apri la pagina culturale de „La Repubblica“, siano ancora lì a spiegarti cosa sono un reality show o un blog, oppure a dirti che il cibo cinese non si esaurisce con gli involtini primavera. Sembra quel ragionamento da massaia di Vercelli secondo il quale devi dire tutto a tutti come fossero colti uguali.
Non ci credo. Penso invece sia opportuno scrivere una cosa come andrebbe scritta; se non la capisci, cazzi tuoi, ti informi. Io, le cose, le ho imparate perché ho letto articoli di cui non capivo niente.
Far venire voglia a qualcuno di leggere implica non ripetergli concetti e cose che già conosce. Sto dicendo che devi dare alle persone cose interessanti, stimolanti, nuove. Ho letto articoli a metà perché non li capivo e le cose che non capisco le voglio conoscere, e quindi leggo altre cose, e mi informo, e inizio a capire; ed è così che si crea una cultura. Non ripetendo sempre le stesse tre cose.
Una volta andavi su un sito o una fanzine dove c’era una recensione di quel disco che ti piaceva, ci trovavi menzionato un altro album e correvi a informarti. Questa cosa è mancata, forse resiste solo nel giornalismo musicale. Perché devo far finta che il pubblico sia scemo? Perché non posso dire che i videogiochi sono una forma d’arte? Se te lo dimostro, alla lunga si diffonde una consapevolezza.

Concordo, per quanto a volte si incappi in un critichese autoreferenziale
Hai ragione, in Italia o ne sai tantissimo, e quindi l’approccio è da super elite, oppure Antonio Ricci. Manca la via di mezzo, manca tutto quello che rende bella la cultura, manca il ragionamento borghese sulla cultura. Noi volevamo fare su «Prismo» proprio questo: cercare di mettere insieme più cose alla medesima temperatura, come Frigidaire; magari hai l’articolo su un videogioco indie, poi qualcosa sull’ultimo di Carrére.
Quanti siete?
In Alkemy, fissi a Milano nel mio dipartimento, siamo in dieci. Tutta Alkemy invece penso che si avvicini a 300 persone. Per la parte content, siamo in nove su «l’Ultimo Uomo, per «Prismo» in 5, per «The Towner» 7, considerando le due edizioni. E poi ci sono i redattori esterni. Abbiamo un network di scrittori che comprende 300 persone, alla fine, «l’Ultimo Uomo» ha pubblicato 1200 articoli…
Mi risulta niente di tradotto, giusto?
Esatto. Siamo noi a essere stati tradotti in Spagna, Inghilterra e Francia.
Che cosa indica il fatto che oggi un articolo venga visto meno del video a corredo?
Non penso sia mai stato diverso. Ma sono abbastanza convinto che la pubblicazione costante di contenuti nuovi e validi prima o poi trovi il suo pubblico. E ci sarà sempre un ragazzino di 14 anni che per impressionare l’amica le passerà quel libro scovato online.
Probabile. Secondo te, in Italia, c’è una specie di pregiudizio da parte del giornalismo, diciamo, culturale nei confronti di argomenti e formati nuovi?
Non lo so. Penso al longform che abbiamo dedicato a Gareth Bale per Adidas due anni fa: quando ne parlai con un mio amico scrittore gli dissi «leggilo, è bellissimo». Se ne parlo con un illustratore gli dico «hai visto che cazzo di illustrazioni abbiamo fatto?». Se lo descrivo all’amico web designer gli dico «guarda come è ben progettato». E quando parlo con un investitore gli faccio notare che su Google, in Italia, quel pezzo è intercettato subito dopo la voce di Wikipedia. È, alla fine dei conti, un bellissimo contenuto. Non gli puoi rimproverare niente.
E per quel contenuto non abbiamo speso 1 euro di Seo; abbiamo investito tutto sulla qualità, sulla cura, sull’amore. Tanto che la gente ha voluto leggerlo. Fine. In un certo senso, abbiamo fatto le cose come vanno fatte, da sempre, che si stia parlando di digitale o meno.
La questione è che io oggi posso muovermi in questa direzione, oppure posso continuare a fare prodotti scadenti e investire milioni di euro in media, magari regalandoli a società che si arricchiscono vendendoti click fasulli. E alla fine chi paga? Il pubblico, i lettori, la cultura italiana.
Certo, puoi continuare a lavorare così; se punti a fare 1 milione di visualizzazioni domani è la strada giusta. Ma se preferisci ottenere un ottimo posizionamento, oggi puoi pensare a soluzioni diverse. Ed è un approccio per nulla avulso dal business, sia chiaro. Penso che il giornalismo “tradizionale” si debba svegliare a questa realtà. La gente è stanca di prodotti scadenti.

La domanda però era un’altra
Ah ah, scusa. Ok. Secondo me se il direttore di un grande periodico sportivo vedesse quel progetto, non avrebbe problemi a capirne l’efficacia. Non penso ci sia un rigetto automatico. Piuttosto ritengo che in Italia si sia commesso per tanti anni un gravissimo errore nelle grandi redazioni dei quotidiani, vale a dire considerare internet un nemico.
Però tu hai fatto tutto trasferendoti dall’Inghilterra a Milano
Perché la città mi piace, si vive bene, si lavora bene, c’è una cultura abbastanza internazionale, le cose si fanno, c’è una certa facilità nel recuperare i capitali per finanziare i progetti. E si può dialogare con altre città del mondo, nonostante Milano non sia certo una grande capitale. In più non hai gli svantaggi di vivere a Londra, New York o Parigi. Non c’è la tristezza che vedi passeggiando per le strade della City, quelle facce da persona pronta al suicidio. A New York se non sei miliardario vivi come uno studente squattrinato fino a cinquant’anni. E speri ti muoia un parente ricco.
Non dico che a Milano si viva come a Napoli o a Palermo, con quella piacevolezza intrinseca data dal clima, dalla bellezza. Però si vive bene, si mangia bene, ci si muove bene.
So che sei anche appassionato di cucina; dove vai a mangiare?
Sì, è vero, cucino. La questione è che io voglio bere e mangiare insieme, quindi il mio problema è che odio gli aperitivi. Odio mangiare due pizzette di merda oppure dover passare due ore con gli amici per scegliere dove andare a cenare. Se sono seduto in un bel posto, voglio poter ordinare del buon cibo. Non mi pare una follia.
Quindi dove vai?
Alla Saketeca Go, dove si mangia e si beve benissimo: enoteca della Madonna, sake della Madonna, i ragazzi sono simpaticissimi, sembra un baraccio di Tokyo a Milano. È buonissimo e molto genuino. Poi vado spesso al Picchio a bere una birretta. Mi piacciono i posti genuini, oppure mi piace mangiare e bere bene. Quello che non mi piace è la via di mezzo.
Che cosa cucini?
Thai, libanese…
Hai origini mescolate vero?
Mio padre è mezzo inglese, un quarto ungherese e un quarto libanese, ed è nato in Egitto. Forse anche solo geneticamente, mi piace mangiare il cibo di ogni parte del mondo. Thai. Libanese. Giapponese, messicano, turco, greco, vietnamita, cinese, peruviano.
E dove vai a ballare?
Mi piace ascoltare la musica, ma non vado a ballare. Mai. Non vado ai festival neanche per sogno, mi devi dare un milione di euro per farmici andare.
Perché?
Perché è tutto una merda; mi piacciono la pace, la tranquillità, gli amici. Per me la situazione perfetta è una casa di campagna con dieci amici; si cucina, si beve, si gioca a carte, si sta tutta la sera fuori a ridere. Questo è bello. Bellissimo. Mille persone dentro un capannone è una merda, un inferno. Sto proprio male. Se entro in discoteca e tre persone mi sbattono addosso, voglio andarmene. Non l’ho mai apprezzato nemmeno da ragazzino, però allora non potevo dirlo perché sai, «è sabato, andiamo a divertirci». Cosa che deve aver generato il mio alcolismo, perché mi dovevo dovevo devastare per rilassarmi.
Puoi svelarci i numeri delle tue testate e qualcosa che dobbiamo aspettarci?
Tra Italia e America «The Towner» conta complessivamente 100mila visite al mese e ha 100 giorni di vita. «Prismo» ha un anno e tre mesi e ne fa 200mila al mese. «l’Ultimo Uomo» compie tre anni e ne fa 700mila. A breve usciremo con un nuovo verticale. Non so ancora cosa sarà, ma so che sarà a breve.




