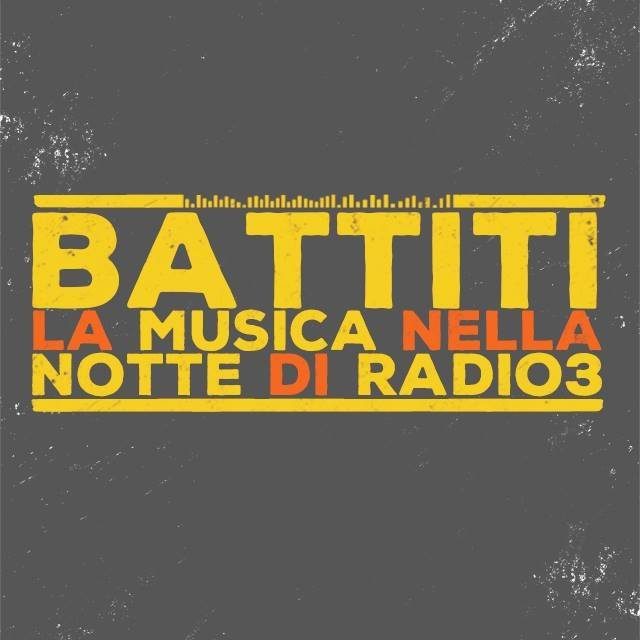Tre decenni, tondi tondi. Sono quelli passati da Pino Saulo dietro un microfono o una regia, dentro uno studio, con le cuffie in testa e le orecchie che più aperte non si può. Insomma trent’anni di Radio – nello specifico trent’anni di Rai Radio. Più di venti di questi al timone di “Battiti”, la trasmissione notturna di Rai Radio 3 dedicata alla ricerca musicale, ai suoni obliqui, al jazz d’avanguardia così come all’elettronica sperimentale, fino ai suoni non occidentali.
Abbiamo raggiunto Pino per un viaggio nella sua carriera e, approfittando della sua esperienza abbiamo ragionato insieme sui cambiamenti di costume del pubblico, su come si rimane curiosi e sulla radio come uno degli ultimi strumenti culturali democratici. Per rubare le parole (o le note) al grande trombettista americano Rob Mazurek: ecco a voi Pino Saulo, “King of Rome”.
Partirei dal principio: come, quando e perché nella tua vita arriva la radio?
Sono approdato in radio soltanto nel 1994, prima facevo tutt’altro. Ho iniziato con “Audiobox” che era il programma dedicato alla sperimentazione radiofonica, alla radio art. Qui avuto la fortuna di iniziare a lavorare con Pinotto Fava che era l’ideatore del programma. Dico fortuna perché abbiamo fatto cose diverse e interessanti, lavorando su un concetto che all’epoca era ancora denso di sviluppi: la radio era un luogo speciale, il luogo deputato per fare un certo tipo di sperimentazione, anche in virtù della possibilità di usare una certa strumentazione, una cosa che poi è un po’ venuta meno nel corso degli anni immediatamente a venire con la facilità di accedere a dispositivi elettronici che consentono delle cose che prima erano molto più complicate. È stata un’esperienza che mi ha aperto la mente soprattutto riguardo a un giro di elettronica che rimane vitale ancora oggi. Poi nel 1995 ho iniziato anche a prendere il timone del jazz, serviva qualcuno che prendesse in mano la programmazione e mi sono ritrovato a occuparmi anche di quello e da allora non me ne sono più staccato.
Eri già appassionato di jazz o lo sei diventato per l’occasione?
C’era già una passione antica. Ascolto musica da quando ho tre anni, stavo attaccato alla radio tutto il giorno, a quei programmi che c’erano negli anni Sessanta e Settanta, fino a “Stereo Notte” negli Ottanta. Come molti della mia generazione ho approcciato il jazz partendo da certe esperienze rock che in qualche modo aprivano la strada, come i King Crimson o i Soft Machine o certe cose americane. Da lì poi tutta l’avanguardia: partendo dall’Art Ensemble of Chicago e Archie Shepp, per poi tornare indietro e scoprire tutto quello che c’era prima. Insomma una forte passione preesistente che ho avuto la fortuna di mettere a frutto capitando al momento giusto nel posto giusto.
E quindi gli inizi, il jazz… E poi? "Battiti"?
Dopo “Audiobox”, e parallelamente al jazz, ho fatto un programma che si intitolava “Inaudito”; poi ho curato e condotto Fahrenheit e agli inizi degli anni 2000 – prima ancora di fare altri due programmi che si intitolavano “Fuochi” e “Invenzioni a due voci” – ho ideato e condotto una cosina che si chiamava “Agguati”. Un programmino curioso e pieno di buone intenzioni, anche se gli esiti non sono stati eccezionali. L’idea era quella di fare delle pillole di durata variabile dai dieci ai trenta minuti che andassero in onda la sera senza un orario prestabilito, insomma dei piccoli agguati sonori. Una cosa bella a dirsi ma complicata a farsi. Poi a un certo punto ho iniziato ad occuparmi della programmazione notturna, con un programma che si chiamava “Esercizi di Memoria”. All’interno di questo programma abbiamo creato una parte più squisitamente musicale che avevamo chiamato “Fonorama” (su suggerimento di Antonia Tessitore) e poi nel 2003 è iniziato “Battiti”, sempre con Antonia e con una giovanissima Sara Zambotti, poi diventata una delle voci di “Caterpillar”. Negli anni dentro “Battiti” sono passati altri conduttori e redattori, da Letizia Renzini a Francesca Zammarelli, da Nicola Catalano a Giovanna Scandale; oggi oltre ad Antonia e Ghighi Di Paola c’è Chiara Colli – nome ben noto ai lettori di Zero! – e Simone Sottili. Sai, il nostro è un lavoro bello e privilegiato, ma ovviamente quando lavori in una grande azienda c’è tutta una parte di lavoro non visibile dall’esterno, di tipo amministrativo – tutte cose necessarie che sono intorno al programma – che assorbono tante energie. È una macchina complessa…
Visto che citi la difficoltà di confrontarsi con una macchina così complessa come la Rai, mi viene da chiederti quali sono state le maggiori difficoltà ma anche le sorprese più piacevoli, cose che sei riuscito a fare contro ogni aspettativa.
Direi che alla fine sono riuscito a fare un po’ tutto quello che contavo di fare. Ad esempio dei dischi, credo i primi che siano stati prodotti a Radio Rai. Il primo è stato proprio quello che facemmo nel ’97 dedicato a Coltrane a trent’anni dalla morte. Lì anzi fu una cosa più complessa perché organizzammo un incontro dedicato a Coltrane con Stefano Zenni, Marcello Piras e altri studiosi, e i loro testi, opportunamente rivisti, finirono in uno speciale di Musica Jazz, con il cd del concerto di Tiziano Tononi e il suo gruppo in allegato. Dopo di quello ne ho fatti tanti altri: sono, per ovvi motivi, particolarmente legato a quello dell’Art Ensemble of Chicago, registrato nei nostri studi e nato da un’idea di Isio Saba che ne era lo storico manager. Poi seguì una serie di concerti che organizzavamo come “Battiti” in una situazione molto divertente: eravamo riusciti a trasformare una delle grandi sale arredandola come fosse un garage, una cantina. Divani, divanetti, cuscini per terra… portavamo del vino e del formaggio, il pubblico e i musicisti si rilassavano, chiacchieravano fino a quando cominciava il concerto.
Tutta quella serie di concerti sono diventati dischi per un’etichetta che ho ideato e diretto per Rai Trade e che abbiamo chiamato “Tracce”, sulla quale sono usciti anche alcuni concerti registrati al festival “New York Is Now” – il primo festival che ho organizzato con l’Auditorium/Musica per Roma – come ad esempio l’omaggio di William Parker a Curtis Mayfield, che si avvaleva della presenza di Amiri Baraka. Sempre su Tracce abbiamo pubblicato le registrazioni che Pasquale Santoli aveva fatto con Robert Wyatt nel 1981 per il programma “Un certo discorso” o l’incontro tra l’Italian Instabile Orchestra e Anthony Braxton… Insomma, un po’ di cose interessanti. Vanno ancora ricordati i festival: nel 2004 la prima edizione di “New York is Now” con l’Auditorium, incentrata su William Parker e la scena free newyorchese. Nel 2006 “Le Labbra Nude” che era più dedicato allo spoken word e poi “Be music, night”. Ho collaborato anche con Romaeuropa per una rassegna intitolata “Viva”, che ha conosciuto due edizioni e che era più incentrata sulla scena underground e sperimentale. E infine ci sono state due edizioni di “Fauves!” nate sempre come collaborazione tra Radio3 e la Fondazione Musica per Roma.
Hai fatto un excursus che abbraccia un grande spazio temporale. Come è stato svolgere questo lavoro (anzi, lavori) in decenni diversi, anche proprio da un punto di vista pratico, logistico, di confronto con il pubblico.
“New York is Now” nacque da una constatazione abbastanza semplice e paradossale: dai festival jazz (in Italia ma anche in Europa) erano completamente scomparsi gli afroamericani. Esclusi Herbie Hancock o Sonny Rollins che magari venivano a Umbria Jazz, insomma esclusi i nomi grossissimi. Dirlo oggi suona abbastanza buffo, ma era così. D’altra parte c’era questa scena che mi sembrava estremamente interessante, diciamo post-free, con un grande catalizzatore come William Parker. La possibilità vera e propria di fare qualcosa è venuta fuori nel momento in cui hanno aperto l’Auditorium, grazie a Flavio Severini che prima di arrivare all’Auditorium Parco della Musica gestiva la Palma (oggi il Monk) e aveva avuto il grande merito di riportare il jazz alla ribalta a Roma. Con Flavio e Roberto Catucci da una parte e con Antonia Tessitore e Letizia Renzini che lavoravano a “Battiti”, organizzammo tutto in maniera molto diretta, mettendo insieme una serie di musicisti affini e quasi costruendo il programma insieme a loro. Penso fosse la prima volta anche per l’Auditorium, l’organizzazione di un festival tematico, e credo sia rimasta un’esperienza formativa e intensa.
Rimanendo sul tema temporale: il pubblico dei festival o dei live come lo hai visto cambiare?
Il pubblico ovviamente è cambiato. Gente che aveva vent’anni trent’anni fa ora ne ha cinquanta e via dicendo. Ma sono cambiato anche io e ad esempio ho iniziato a interessarmi a cose diverse. Se penso all’ultimo festival – “Fauves!” – la cosa interessante è che c’era un pubblico di una fascia d’età abbastanza bassa, che è un po’ quella degli ascoltatori di “Battiti” (ma va detto che la fascia d’età si è abbassata anche un po’ per tutto il pubblico di Radio 3…). Insomma ci sono alcuni aspetti nella produzione e consumo della musica oggi che un po’ mi ricordano quanto avveniva già negli anni Settanta, con riviste come Gong o Muzak nelle quali nello stesso numero magari trovavi un articolo su Gato Barbieri o uno su Robert Wyatt e uno su Stockhausen. Ecco mi sembra che in alcune occasioni e in certe programmazioni ci sia più o meno la stessa eterogeneità.
Fin qui abbiamo parlato di grandi enti, aziende dello spettacolo e culturali di livello nazionale e internazionale. A Zero interessano ancora di più tutte quelle piccole realtà che si muovono in città come uno sciame meravigliosamente rumoroso. Arriviamo insomma a Roma: che rapporto hai con questa città? Cosa oggi ti interessa musicalmente di quello che accade qui?
Le cose più interessanti sono proprio quelle che si muovono nei piccoli posti. Il Trenta Formiche, il Fanfulla, le cose che organizza Miniera. C’è una dimostrazione di curiosità di apertura non tanto verso il “nuovo”, che è un concetto astratto che domani sarà già vecchio, quanto verso cose interessanti e poco definibili. Mi viene in mente il concerto meraviglioso di Azu Tiwaline al Trenta Formiche [n.d.r. lo scorso 23 febbraio, organizzato da La Diferencia]. Mi sembra che quel tipo di scena sia la più interessante. Non è un caso che tutto questo nasca in situazioni con un’economia precaria o che comunque non hanno grandissimi mezzi, che non possono contare sull’appoggio di organizzazioni forti. Le istituzioni tendono ad essere un po’ più conservatrici e meno aperte alle novità, soprattutto quando c’è un linguaggio effervescente che non è stato ancora codificato o non è di successo. Mi sembra appunto una situazione di estrema vitalità, considerando che ci sono tante cose diverse, per esempio questa nuova rassegna dedicata all’improvvisazione al Fanfulla
Ah sì certo, Altera!
Esatto. Da una parte Fabrizio Spera che è un musicista che ha iniziato a suonare e organizzare concerti nei primissimi anni Novanta, con esperienze internazionali importanti (insomma una vera autorità nel campo della musica improvvisata!) o altri musicisti suoi coetanei, ma intorno ci sono tanti musicisti più giovani, c’è l’incontro di scene e generazioni diverse. Pensando ad altre città ed ad esempi forti come “Jazz Is Dead” che si tiene a Torino, forse quello che manca a Roma è un catalizzatore di questa effervescenza in formato festival. Penso al festival come luogo di aggregazione, di formalizzazione di una serie di istanze, in cui in due, tre giorni metti a fuoco tante cose interessanti. A Torino ne sono venuti fuori diversi, a Milano pure; ce ne sono altri molto interessanti in giro per la Penisola; a Roma forse c’è meno continuità. Poi è interessante notare come certe proposte apparentemente di nicchia o d’avanguardia possano richiamare migliaia di persone. Certo, si può parlare di moda, di hype ma sta di fatto che questo è sempre esistito. Magari c’è chi va a un festival attirato da un nome importante e poi rimane per seguire tutto il resto. Anche negli anni Settanta c’erano folle oceaniche a vedere Archie Shepp o Cecil Taylor anche se pochi sapevano veramente chi fossero…
Ma che in certi casi si può sfruttare per fare cose molto positive.
Sì, certo. L’esplosione del free jazz nell’Italia degli anni Settanta era legata fondamentalmente all’equazione con la lotta degli afroamericani. L’idea era che il free rappresentasse quella radicalità in musica. Una formulazione un po’ ambigua che però conteneva indubbiamente molti elementi di verità e faceva sì che ci fosse un grosso seguito per fenomeni musicali di cui in realtà si sapeva poco nello specifico. Coincidenze di questo tipo sono necessarie. Uno mette a disposizione degli elementi, delle ipotesi, delle connessioni, insomma un’offerta che poi sta a chi vuole ricomporre, vederci un disegno, e magari approfondire.
Il discorso che fai sul pubblico mi riporta a una cosa su cui rifletto sempre di più negli ultimi anni: lo scollamento tra classi sociali nell’offerta e nel consumo di cultura. Come dicevi tu negli anni Settanta magari ti ritrovavi a sentire Archie Shepp quasi per caso, ma succedeva anche perché avevi le possibilità economiche di accedere a quella cosa. Oggi per un’esperienza più o meno assimilabile servono un sacco di soldi e quindi, intellettualmente e proprio fisicamente, sono tagliate fuori la maggior parte delle persone.
Il discorso di classe è un discorso che esiste su qualunque cosa. È quasi un a priori, perché l’appartenenza a una classe sociale determina non soltanto dal punto di vista economico la possibilità di accedere a certe cose, ma influisce sulla curiosità intellettuale, sulla volontà e sulla capacità di poter approfondire. Banalmente se nasci in una famiglia dove ci sono dei libri è più facile che tu legga e viceversa. Questo è il grande scollamento che esiste a livello sociale, no? Il paradosso di questi ultimi anni è un altro: c’è una sorta di orgoglio dell’ignoranza, che è una cosa paradossale. Prima ci si vergognava di essere ignoranti, adesso invece c’è una sorta di orgoglio imperante contro gli “intellettuali” in generale, una cosa che ha causato anche uno scollamento politico. C’è una barriera di classe molto più forte rispetto al passato. Gli anni Settanta sono forse stati l’ultimo decennio interclassista e sicuramente anche grazie al fatto che la cultura costava di meno ed era più accessibile.
Certo poi è un discorso che dal sociale passa al personale in un secondo, dipende dalla storia familiare, le passioni e la fortuna di ciascuno. Però parlando in modo generale mi sembra che la tendenza sia questa, anche a Roma.
Sì, è vero, ma ho notato anche una cosa. In tanti posti e situazioni la gente ci va, paga il biglietto e poi rimane fuori a bere. È una cosa che mi ha sempre fatto ammattire, dico, hai speso quindici euro, comprato anche da bere aggiungendo altre spese e poi manco ti senti il concerto per cui sei venuto? Da una parte questo conferma che la musica rimane un elemento di socializzazione potentissimo e senza eguali, dall’altra parla del desiderio di “esserci” più che di qualunque altra cosa. Mi ricordo l’ultima serata di Fauves! nella prima edizione, quella in cui tra gli altri c’era Eric Chenaux. Un concerto tosto, canzoni lunghissime. Ne ricordo una con la sua voce che modulava e ripeteva la stessa strofa per un tempo interminabile: alla fine ci fu una sorta di ovazione. Merito indubbiamente di Eric Chenaux e della sua capacità espressiva e comunicativa, ma, forse, prima ancora che dalla musica, il pubblico era rimasto conquistato dal fatto di “esserci”, appunto. La cosa più importante era essere in quella data situazione, il che comportava anche mantenere le orecchie aperte e prestare attenzione a concerti non facili come quello di Chenaux o Ben LaMar Gay. Insomma, per tornare al tuo discorso, assolutamente sì, questo scollamento socio-economico esiste eccome al netto di luoghi come i centri sociali che negli anni hanno fatto un importante lavoro di cultura dal basso. Ma quella della curiosità intellettuale è una tematica determinata in gran parte dalla classe in cui nasci, dagli stimoli che ti vengono dati e dal tipo di aspirazioni che hai.
Il problema poi come accennavi tu è decisamente politico, perché non sembra esserci una spinta “pubblica” pronta a colmare il divario che nasce in seno ai nuclei familiari. E questo mi porta a chiederti: la Radio invece, che dalla sua nascita è uno strumento largamente popolare, ha mantenuto questa sua funzione?
La radio è gratuita e accessibile a tutti in qualsiasi momento. Offre una serie di possibilità enormi. Se pensiamo solo all’offerta musicale di Radio 3 c’è una programmazione impressionante con centinaia di concerti trasmessi ogni anno, in diretta o in differita, dalla classica al jazz: una sorta di festival infinito. In questo senso la radio è straordinaria ed è uno strumento democratico. Ma è comunque un media che richiede un “salto”, un minimo di sforzo in più rispetto alla televisione. E comunque sì, anche proprio storicamente come dici tu, la radio ha avuto una funzione culturale fondamentale. È proprio quello che si diceva prima sulla classe, la distinzione tra acculturazione e inculturazione: l’inculturazione è quella che avviene nel tuo ambiente di nascita, sono le cose che ti circondano e che assorbi in modo “naturale”, l’acculturazione è un processo di apprendimento di cose che invece appartengono a un altro ambiente e quindi è una cosa molto più faticosa e lunga. La radio è tra gli strumenti più potenti per colmare questo gap, fornire delle chiavi di ingresso per un mondo che poi disegni e inventi tu con la tua capacità di fare connessioni.
Negli anni avrai compilato centinaia e centinaia di scalette e tracklist per i tuoi programmi. Quali sono quegli artisti che sai di poter inserire sempre e comunque? Insomma che sono un po’ la tua comfort zone, che ci stanno sempre bene in quello che proponi
Ci sono alcune cose a cui sono molto legato, musiche anni Ottanta che corrispondono ai miei vent’anni, penso ai Rip, Rig + Panic o a certa no wave. Sul jazz i miei classici sono sempre quelli: Coltrane, Coleman, Don Cherry, l’Art Ensemble of Chicago, Mingus. La cosa che mi fa piacere è comunque rendermi conto che le scalette, al netto di qualche punto fisso, cambiano radicalmente nel corso del tempo.
Infatti avevo un’appendice a quest’ultima domanda: cos’è che nel panorama musicale di oggi ti ha stupito e ti piace particolarmente?
La cosa fondamentale è rimanere sempre curiosi. Cercare di capire cosa succede e non rimanere bloccati su opinioni precostituite. Oggi mi interessa molto tutta una certa scena elettronica che in Africa si esprime al meglio. Muqata’a, Azu Tiwaline, Deena Abdelwahed o quella espressa dall’etichetta Nyege Nyege Tapes. Poi c’è l’hip-hop un po’ “sbilenco”, penso a Pink Siifu, Shabazz Palaces, billy woods… E ovviamente c’è la scena inglese che è sempre estremamente interessante e vitale. Insomma ci sono tante cose diverse e interessanti e proprio per questo oggi un festival dovrebbe poter rappresentare questa varietà e questa ricchezza. Io mi considero privilegiato e fortunato per il lavoro che faccio, anche se ho il rammarico di non riuscire a sentire tutta la musica che c’è in giro…