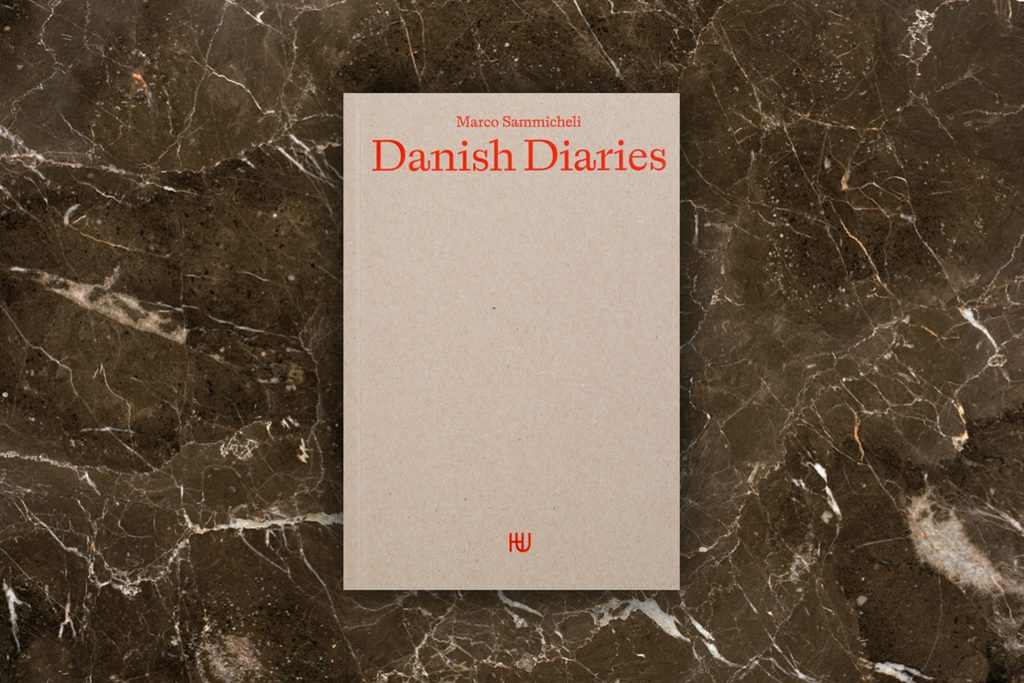Marco Sammicheli è curatore, critico, scrittore, con progetti worldwide e una vita dedicata al mondo della progettazione. La sua pratica unisce, trasforma e plasma, culture e mondi diversi, attraverso un unico linguaggio, quello del design. Una passione così fervida che ha il sapore della devozione, come una religione. Marco Sammicheli ha fatto delle parole la sua arma di seduzione, attraverso le quali racconta persone e progetti, indaga la storia, la interroga e la riporta in auge, in un meraviglioso gioco di rimandi e di opposti che si attraggono. Lo abbiamo incontrato in Triennale, la sua nuova (seconda) casa, di cui attualmente è curatore per il settore design, moda e artigianato e direttore del Museo del Design Italiano.
«Nulla è più contemporaneo dell’eterno, perché c’è sempre, non tramonta mai. Invece il contemporaneo esiste e un minuto dopo è già vecchio.»
Knud Walter. Per molti potrebbe essere il nome di un vecchio marinaio olandese, oppure di un aitante condottiero tedesco. Però, i molti, non sanno che questo è lo pseudonimo con cui firmavi i tuoi articoli su Zero. In questa redazione hai trascorso 10 anni della tua carriera, da collaboratore fino a direttore della testata. Come è stato quando te sei andato?
Molto doloroso. Perché Zero ti entra nelle vene, e soprattutto, ti insegna un modo di scrivere estremamente rapido ed efficace. Contratto, sincopato. Un ritmo che ti rimane addosso, che ha il sapore dell’invettiva, del fumetto, dello slogan. Dopo che me ne sono andato ho dovuto rieducare la mia scrittura. Però è anche vero che con Zero ho subito imparato a scrivere un Tweet, concentrando tutto in 140 caratteri. In questi 10 anni ci sono stati tanti momenti entusiasmanti, dalla barca che mettemmo nel naviglio fatta con le copertine dei numeri, alla parete magnetica allestita qui in Triennale. Poi Open la residenza artistica, organizzavamo degli incontri e nel pubblico spesso vedevi personaggi del calibro di Umberto Eco. Zero è un incubatore, un aggregatore, infatti proprio a questi eventi, tutt’oggi, puoi trovare il massimo dell’avanguardia e il massimo dello sconosciuto. È quella che Andrea [Amichetti ndr.] definisce l’estetica della cameretta. Tutti, anche i più grandi hanno iniziato dalla cameretta; i loro progetti e le loro idee avevano una forza tale da poter uscire da quella dimensione intima e abbracciarne un’altra, ben più grande.
Tu da piccolo, nella tua cameretta, sognavi già il design?
Succede che da bambino i miei genitori mi portano a vedere una mostra a Palazzo Grassi allestita da Gae Aulenti e Pierluigi Cerri – Futurismo e i futuristi – e nel cortile c’era un aereo. Ecco quell’oggetto lì mi aveva acchiappato. Un po’ perché era l’unica cosa che a quell’età ero riuscito a comprendere della mostra, e un po’ perché in quell’aereo era racchiusa un’idea di futuro, di velocità, che mi aveva stregato e allora ho cominciato a guardare le cose diversamente. Così come quando guardavo le vetrine di Casarredo, negozio di arredi che c’è a Fano, nella mia città, ricordo che quelle cose mi piacevano. Le guardavo perché erano strane, colorate, potevi toccarle e anche portarle a casa. Lì è nata questa mia libidine nei confronti degli oggetti. In edicola insieme alle figurine prendevo le riviste come Domus. Facevo lo speaker nella radio della mia città, e non andavo a ballare, quindi i pochi soldi che avevo finivano tutti lì.
Un altro capitolo della tua vita, sia professionale che privata, è la Danimarca. Una nazione, una cultura, una realtà progettuale, che hai indagato, portando a galla molti suoi legami con l’Italia.
La Danimarca arriva nella mia vita sempre grazie al design. Vinco una borsa di studio al Bauhaus e lì incontro questa ragazza, Maria. Capelli biondi, bellissima, gli occhi azzurri e mi innamoro. Ora stiamo insieme da vent’anni. E in questi vent’anni ho scoperto che Copenaghen non è Rio de Janeiro, e ti conquista lentamente. È minuta, e soprattutto è più bella vista dall’acqua, da un’altra prospettiva. Lì capisci che è una terra di marinai, di mercanti, di sportivi. Poi tra le mie tante riflessioni e indagini, a un certo punto ho iniziato ad annotarmi tutti questi casi di collaborazione tra Italia e Danimarca. Due paesi così diversi ma uniti da dei progetti pazzeschi. Così scrivo questo libro – Danish Diaries – perché avevo la necessità di raccontare alle mie figlie la mia idea di Danimarca. Un po’ perché non parlo bene il danese, e quindi non riesco a cogliere tutte le sfumature di quando Maria parla con le bimbe, e un po’ perché in questi anni sono stato tanto in silenzio in Danimarca e alla fine, scavando nella mia memoria e mettendo insieme i pezzi, ho collezionato una galleria di mostri: di persone che mostrano e di persone che nella mostruosità hanno un’eccezionalità meravigliosa. Persone mai allineate, sempre disobbedenti, in pena o goliardici, ma che hanno creato cose meravigliose.
A proposito di legami. Tra le tue indagini, ce ne sono alcune che ricorrono spesso nella tua pratica: sacralità e progettazione; passato e presente. Quanto c’è di personale in queste ricerche?
Io credo che in ogni cosa della vita ci sia una certa predestinazione. Io vengo da una famiglia molto religiosa, non ho avuto il dono della fede e quindi a un certo punto ho pensato che mi potessi legare a Dio attraverso il lavoro. Così chiesi di fare la mia tesi di dottorato sul design per il sacro, nello specifico l’architettura sacra che ha visto una serie di architetti realizzare delle chiese che dovevano essere il nucleo generativo dei quartieri. E poi dentro la Chiesa però dovevano essere inseriti gli arredi, le luci, i gioielli, i paramenti sacri; ‘e questi, chi li fa? L’architetto!’ Ecco questo aspetto mi ha affascinato moltissimo, ed è diventato il progetto della mia tesi, e poi un libro, e da lì ho continuato a coltivare questa ricerca. Quando i professori in maniera molto sospettosa mi dicevano “ah l’architettura sacra…”, che era tra un ‘che palle’ e un ‘chi se ne frega’, io rispondevo: “nulla è più contemporaneo dell’eterno, perché c’è sempre, non tramonta mai”. Invece il contemporaneo esiste e un minuto dopo è già vecchio.
Quindi è questa componente effimera del presente che ti spinge a scavare nella storia?
Per me la storia è un enorme repertorio che non finisco mai di interrogare. Nella storia trovi una ricorsività, cerchi di capire cosa si ripete, a volte molti errori o anche qualità. Nel mio libro La tradizione del nuovo ho messo nero su bianco la mia curiosità investigativa, vedere la pattern recognition, come la chiamava William Gibson, ovvero riconoscere la matrice anche quando c’è la novità assoluta. Quando incontro i designer oggi, spesso sono incapaci di verbalizzare il pensiero sotteso al loro lavoro. Si aggrappano alla storia, ai progettisti del passato, utilizzano espressioni del tipo “un po’ come avrebbe fatto Mendini o Prouvé”. Loro credono sia un modo di crescere di valore, mentre invece scoprono subito le carte di un atteggiamento più simile a Pinterest. Tobia Scarpa diceva, “il designer è un raffinatissimo ladro, sta a lui non farsi scoprire”. Invece oggi i designer si fanno scoprire subito, per accreditare il proprio lavoro, ancorarlo a qualcosa che li possa aiutare.
Che cos’è oggi un buon progetto? Mi sembra che nel 2023 più che di progetti si parli di persone che progettano. Forse è questa componente umana la vera forza del design a Milano?
Senza dubbio, penso però che a Milano, nel design, ci sia un forte cambio generazionale. C’è una fascia di mezzo di grandi professionisti che però non sta lasciando il segno. Se chiudi gli occhi non ti viene in mente niente di ciò che hanno fatto. Comunque ci sono dei progettisti che ammiro. Odo Fioravanti, Alberto Meda, Chiara Andreatti, David Dolcini. Poi gli Zaven, Gam Fratesi, Sovrappensiero, Mist-O. Spesso coppie, che sono la somma di più mondi. Prendi per esempio, Sottsass il suo studio era ricco di persone che venivano da tanti mondi, molte delle quali oggi sono maestri a loro volta. In lui c’è stata una generosità e una capacità di far crescere queste persone. Molti suoi colleghi non hanno allevato dei delfini. L’eterna battaglia tra padri e figli, e a un certo punto devi uccidere i tuoi padri per non soccombere a loro. Questo nella creatività avviene spesso in maniera dolorosa, tra fallimenti e sacrifici, tra sudore e attesa. E poi un’altra componente che affligge le nostre generazioni, sia la mia che la tua, è l’impazienza. Questa riduzione del tempo, del risultato. Do ut des, now. In generale affronto il presente con molta cautela, forse ancora devono passare un po’ di anni prima di essere così sicuri del contemporaneo. È un atteggiamento che mi ha insegnato la Triennale, ovvero l’attenzione. Quando curi mostre, quando dedichi ricerche, pubblicazioni, fai un lavoro che inevitabilmente si assume la responsabilità di legittimare e di scegliere. Però, nonostante tutto questo, sono molto grato. Occuparsi di design a Milano alla Triennale è un grande onore, e un’enorme responsabilità. Fare sì che questa non sia solo una forma di ripetizione ma anche aggiunta di conoscenza.
E, oltre al design, di che cosa è fatto la Milano che ami?
Di Milano amo tante cose. È piatta, è piccola, con la bici in 20 minuti sei dove vuoi. E poi il design, o comunque ciò di cui mi occupo, qui c’è tutto l’anno. Quando esco da Missori e vedo la Torre Velasca sono contento, perché sono un nerd, ma anche perché ho capito di avere affinato degli strumenti per poter godere appieno di tutto questo. In molti dicono che Milano non ha monumenti e devi scoprirla dall’interno. Però è una città di persone, forse è per questo che qui è stato inventato l’aperitivo, e qui tutti si occupano di relazioni pubbliche. In questa metropoli tu sei sempre carne fresca, c’è questa curiosità antropologica per cui tu porti della novità. È una città in cui la merce di scambio è il lavoro. Se tu fai, allora sei e dai. Altri dicono che Milano non sia bella, ma la bellezza di Milano è la bellezza del moderno, del presente, di un momento che stai costruendo tu, dove alla fine la città non è scenografia ma è piedistallo. Nonostante io ami Milano non immagino di vivere qui la mia vecchiaia. Perché mi manca il mare e perché penso sempre che in un futuro vorrei andare da qualche parte, anche se qui sa di casa. Non so se saprà anche di pensione.