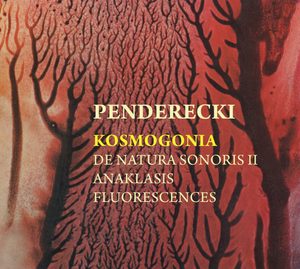Ogni opera d’arte (o quasi) può essere considerata psichedelica quando c’è la visione. Ci si perdoni il gioco di parole, ma il concetto a questo punto è chiaro: usciti ormai da tempo dal decennio che la psichedelia l’ha nutrita più di ogni altro, ovviamente i Sessanta, la storia della musica (ma non solo) ci ha insegnato che tutto – se con l’attitudine e lo sguardo volti a stravolgere le normali coordinate spazio temporali, a creare connessioni tra corpo e mente, magari mescolando le percezioni sensoriali visive e uditive – può avere “effetto psicotropo” (dai Broadcast ai Massive Attack, per menzionare due nomi che i generi musicali ordinari vorrebbero pressocché agli antipodi). E allora impossibile negare che questo esperimento sugli ascolti psichedelici ci diverta tantissimo, per il modo in cui prescindendo da qualsiasi genere musicale (reale o percepito…) i risultati abbiano sì qualche punto di contatto, ma sicuramente molte interpretazioni differenti – seppur perlopiù tutte orientate alla dilatazione e distorsione del tempo, alla dimensione del viaggio interiore o esteriore, del movimento verso qualcosa di “alieno”.
In tempi non sospetti (cioè a fine Novanta) i Jennifer Gentle di Marco Fasolo sono stati forse la prima band italiana a recuperare e reinterpretare la “psichedelia” facendo tesoro dei grandi classici dei Sessanta ma stravolgendo, deformando alla propria maniera le strutture delle canzoni, i timbri, le direzioni melodiche intraprese. Dopo dieci anni di silenzio discografico sono tornati con un album omonimo che è un’opera pop psichedelica complessa, variegata, visionaria, contaminata con numerosi fuori pista sonori (dal funk a frequenze disturbate quasi noise). Una narrazione che si moltiplica in mille rivoli tra il super orecchiabile e l’alieno, perfetti per un live a metà tra il confortevole e il disturbante. Sono attualmente in tour, con un passaggio il 15 novembre al Monk per il Rome Psych Fest e l’occasione era ghiotta per chiedere a un “experienced” della psichedelia come Marco Fasolo la sua versione dei fatti. La presenza di nomi quali Suicide e Ligeti accanto a Barrett e Flying Saucer Attack non ci scompone affatto, ma rende ancor più interessante lo sviaggio.
SKIP SPENCE – “OAR” (COLUMBIA, 1969)
Psichedelia come viaggio nella mente di chi crea e di chi fruisce. La mano sugli strumenti suonati e ogni suono materializzano il mondo interiore, l’intimità.

THE RED CRAYOLA – “THE PARABLE OF ARABLE LAND” (INTERNATIONAL ARTISTS, 1967)
Una finestra su un mondo inedito, che rivisita il proprio tempo. Dissociandosene.

FLYING SAUCER ATTACK – “NEW LANDS” (DOMINO, 1997)
Un vero viaggio siderale. Si ha la sensazione di muoversi al di fuori di tempo e spazio.
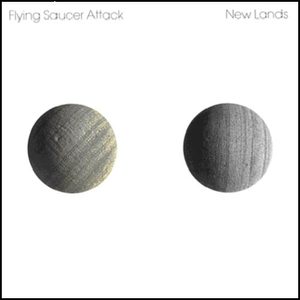
SYD BARRETT – “THE MADCAP LAUGHS” (HARVEST, 1970)
Il lato infantile come purezza. Mettersi a nudo con le proprie visioni.

JOHN FRUSCIANTE – “SMILE FROM THE STREETS YOU HOLD” (BIRDMAN RECORDS, 1997)
Perdersi nei propri incubi, avendo il coraggio di donarsi all’ascoltatore, anima e corpo.

GYÖRGY LIGETI – “LUX AETERNA” (1966)
Musica autogenerata. L’autore si annulla. Esce di scena. Diventa invisibile. Le voci, ora, non sono piú umane.
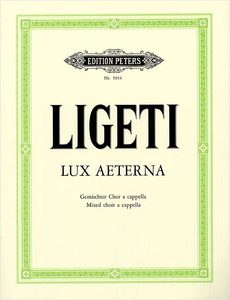
THE BEACH BOYS – “SMILEY SMILE” (BROTHER RECORDS, 1967)
Spingersi oltre i propri limiti, perdendo la ragione. Costruire il proprio mondo, mattone dopo mattone, creando una “realtà” altrimenti impossibile.
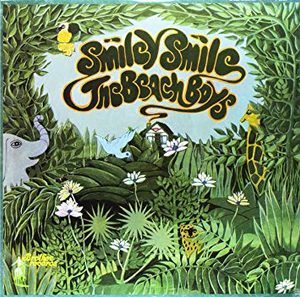
GIOVANNI GABRIELI – “SONATA PIAN’ E FORTE” (1597)
Arriva come un’estasi chimica. Pianure nebbiose, e ci si estranea dalla realtà.

SUICIDE – “SUICIDE” (RED STAR RECORDS, 1977)
Il ritmo ci ipnotizza e ci aliena. Esorcismo musicale come via di redenzione.

KRZYSZTOF PENDERECKI – “KOSMOGONIA” (1970)
Il potere del Rumore, del suono che diventa un’esperienza fisica, tattile. Una struttura architettonica che ci contiene e ci abita nel contempo.