Chiunque abbia messo piede almeno una volta – magari in un’età compresa tra i 15 e 25 anni – in via Nomentana 113, probabilmente avrà un ricordo o un aneddoto legato a quel posto che dal 1997 si chiama Hellnation. C’è chi c’è cresciuto, chi c’ha passato l’adolescenza, chi gli anni dell’università. Difficile definirlo solo un negozio di dischi. Forse di quelli vecchia maniera, dove si scoprono cose, si conoscono persone, dove c’è un altro tipo di socialità. Il merito è del suo proprietario, Roberto Gagliardi – per gli amici Robertò, viste le sue origini francesi. Da quel 1997, Hellnation è un negozio di dischi, un’etichetta, da qualche tempo anche una casa editrice, ma soprattutto un riferimento per alcune sottoculture romane che Roberto ha saputo osservare e far crescere, divenendo nel corso degli anni – e anche al di fuori del G.R.A. – un pilastro solido per la scena punk, hardcore e skinhead. La sua storia a Roma comincia con la Bande A Bonnot – nome non puramente casuale – nel 1991 e va avanti ancora oggi, con uno sguardo attento alla contemporaneità e all’underground e uno stile inconfondibile, schietto e tenace. Roberto è stato il primo a Roma a festeggiare il Record Store Day, che quest’anno si celebra il 16 aprile, ma questo è solo uno dei tanti pretesti per fare di nuovo incursione nel suo negozio e sentirlo parlare per quasi due ore.

ZERO: Cominciamo dalle presentazioni. Quando e dove sei nato, come hai iniziato ad appassionarti di musica e quali sono stati i primi dischi che hai comprato?
ROBERTO GAGLIARDI: Sono nato nel 1964 in Francia, in una città industriale tipo Torino, Montbéliard, che sarebbe la roccaforte della Peugeot, e ci sono rimasto fino all’86/87, appena finiti gli studi in Lettere e Filosofia. Sono andato via il giorno in cui mi sono laureato e tre giorni prima della chiamata alle armi… Sono un disertore totale! A quel punto mi sono trasferito a Pescara, dove i miei genitori – di origine abruzzese – erano tornati già da qualche anno. Quanto arrivai a Pescara iniziai a fare il barman e il gelataio, ma già mi occupavo di musica. I primi dischi acquistati nella mia vita sono stati Rockin’ All Over the World degli Status Quo, il primo album dei Dogs (quelli francesi, NdR), Different, Who Are You degli Who e un Elvis Presley. Già con i Dogs mi ero avvicinato al punk, diciamo che la Francia beneficiava del fatto di avere l’Inghilterra a due passi, quindi noi ereditavamo subito quello che c’era in giro già dalla fine degli anni 70. Ho vissuto direttamente il punk, compravo le riviste, andavo ai concerti. Facevo anche sport, giocavo a calcio, ma sai non si rimorchiava col pallone, invece la musica ti dava occasioni di socialità. Adesso invece è il contrario (risate, NdR). Ricordo che a 14 anni i miei genitori mi portavano e venivano a prendere ai concerti a 20 chilometri dalla mia città: mi sono visto i Dogs, tantissime volte i Dr. Feelgood, ma anche Camel, Caravan, James White and the Blacks.
Come ti sei avvicinato al punk, non solo in qualità di ascoltatore ma anche di persona attiva nel giro?
Già in Francia, a 15 anni, suonavo la batteria in vari gruppi punk. Facevo concerti e iniziavo a organizzare cose, anche se in modo molto approssimativo. Appena arrivato a Pescara, ho lasciato perdere gli studi e contemporaneamente al lavoro ho iniziato le fanzine. Una si chiamava Bang Bang Boom, un’altra Papa Oom Mow Mow e poi c’era Rave On. Due di quelle fanzine si occupavano di rock e punk francese, avevo questa fissazione folle di provare a far conoscere la musica francese anche in Italia. Con un’altra traducevo le newsletter dell’Elliot Murphy fan club e di Paul Roland, furono i miei primi contatti con grandi artisti.
Ovviamente si faceva tutto per posta?
Certo, tutto avveniva per posta. Ricordo che nell’89 ho organizzato un tour dei Negazione e andavo a fare le telefonate nella cabina telefonica dove lavorava mio zio alla Sip… Dopo che mia madre aveva ricevuto 600 mila lire di bolletta del telefono non ne voleva più sapere dei miei «Tour di merda»! Comunque nell’88/89 iniziai a organizzare non solo concerti ma anche i primi tour, mentre a Pescara avevo già portato vari gruppi punk, Nation of Ulysses della Dischord, Burning Heads, li facevamo in un posto che si chiamava Il Villaggio Globale. A quei tempi, fanzine e concerti erano solo una questione di passione, extra lavorativa – attaccavo magari alle 5 di mattina al bar, finivo alle 14 e poi mi mettevo a fare quelle cose lì.
A Pescara c’era una scena?
C’era un pubblico in quel periodo, ma c’erano anche gruppi – Vegetable Men, Dirty Kids, il giro new wave.
Poi, a un certo punto, ti sei trasferito a Roma. Ci racconti dell’esperienza con la Bande A Bonnot?
Emilio Mangio, che avevo incontrato mentre portavo in tour i Thompson Rollets a Roma, mi aveva accennato dell’intenzione di aprire un negozio di dischi indipendenti, una label e di voler organizzare tour facendo attenzione anche a cosa accadeva in Francia. Nel 1991 mi trasferii a Roma e abbiamo iniziato subito con booking, etichetta, negozio e distribuzione. La sede era in via Valsassina, avevamo tutta Dischord e Alternative Tentacles. Dentro la Bande A Bonnot oltre a me ed Emilio, c’erano Vittorio De Mita, Carmelo Seminara, ex Manimal-Forte Prenestino, a cui si aggiunsero Pepo e Paolo Petralia negli ultimi due anni, ‘96 e ‘97. Quello è stato per me un periodo di grande apprendistato, anche se abbiamo sbagliato molto e ci è costato tanto: eravamo una realtà piccola che è cresciuta progressivamente e siamo un po’ implosi, sia per problemi economici sia per problemi tra di noi.
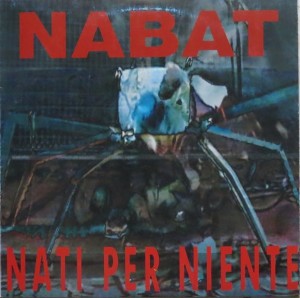
Ci siamo trovati spesso a doverci confrontare con altre realtà più grandi, penso a Loredana Berté per i Fratelli Di Soledad (Bande A Bonnot pubblicò nel 1994 Salviamo il salvabile, in cui era contenuto E la luna bussò…, NdR), o alla Flying Records – un grosso distributore di Napoli, realtà che ci permetteva di vendere anche tanto, ma che a quel punto ci mise nella condizione di dover scegliere se fare un salto di qualità o restare come eravamo. Avevamo già dei titoli di qualità che vendevano anche 4/5000 mila copie – Massilia Sound System, Fratelli Di Soledad, Ciclone, il secondo album di Growing Concern, il primo dei Nabat – e dovevamo decidere se farci distribuire da una major…

Ma all’interno della Bande A Bonnot c’era una spaccatura, non eravamo tutti d’accordo e io personalmente non ero propenso a fare quel salto, credo per un aspetto romantico e naive. L’esperienza con la Bande A Bonnot è stata importante per la mia crescita professionale e un disastro economico totale. Ma mi ha permesso di mettere definitivamente le radici a Roma.
Com’era Roma in quella prima metà degli anni 90? Cosa si ascoltava, quali erano gli spazi per i concerti e i negozi di dischi che diffondevano musica tendenzialmente punk/hardcore?
A inizio ‘90 a Roma era il periodo delle Posse, quindi c’era un certo interesse per l’hardcore, ma quello maggiore era per gruppi come 99 Posse, Assalti Frontali, il post Pantera, roba di militantismo hip hop. Il Forte Prenestino era un posto calamita, fondamentale in quegli anni, e c’era il Cinema Puccini, con l’occupazione a Casal Bertone. Negozi che vendevano punk e hardcore erano Disfunzioni Musicali e poi c’era l’Ottico, un posto vicino alla Stazione che era il ritrovo del giro hardcore e vendeva anche dischi (ed era realmente un ottico, NdR). Noi come Bande A Bonnot avevamo in più l’aspetto sociale di diffondere il verbo anche negli spazi occupati.

Al Forte, ad esempio, abbiamo organizzato tantissimi concerti. Fugazi, di cui seguimmo tutto il tour italiano, Grotus, abbiamo fatto due volte i NoMeansNo e i Victims Family, che erano un gruppo jazzcore incredibile: allora c’era un consenso pazzesco, se si facevano i concerti in Piazza d’Armi era strapiena. L’apice lo abbiamo raggiunto con i Rage Against The Machine al Villaggio Globale, ma più avanti. Dal ‘91 al ‘97 ci siamo occupati continuamente di quel tipo di management e per quanto riguardava le uscite facemmo anche i 45 giri, tra gli altri ci furono Bikini Kill con il singolo insieme a Team Dresch, Fratelli Soledad, Nabat ma anche cose più sperimentali.
Erano pieni anni 90, quindi: cd o vinili?
Facevamo tutto in doppio formato, anche se quelli erano gli anni del cd. Per quanto mi riguarda il vinile non è mai “tornato” qui, perché c’è sempre stato. È sempre stato il supporto favorito.
Il tuo approccio nei confronti della musica è cambiato rispetto a 20 anni fa?
Penso di aver conservato lo stesso spirito, personalmente non ho mai avuto preclusioni nei generi musicali. Molte persone mi identificano con la scena hardcore, ma è uno sbaglio, continuo a ripeterlo: se vedi la discografia della mia etichetta, Hellnation, non c’è un disco hardcore. Dal punto di vista strettamente musicale, l’hardcore non mi interessa, preferisco altri generi. Quello che mi ha appassionato della scena hardcore è il suo funzionamento, come mai quel genere – che trovo musicalmente così gretto – abbia trovato così tanto successo. La risposta credo stia nel fatto che l’hardcore è una calamita di tutti i problemi sociali, ma anche mentali e psicologici, di una generazione. È un’immedesimazione che riguarda la fascia d’età dai 15/16 anni ai 25/26, in genere chi continua a seguirlo anche dopo lo fa più per una questione di romanticismo. A me appartiene la scena hardcore ma non la musica hardcore. E questo senza denigrare nessuno.
L’hardcore è una calamita di tutti i problemi sociali, ma anche mentali e psicologici, di una generazione
Quali sono state le altre realtà che negli anni 90, nel periodo di “formazione” con la Bande A Bonnot, erano di esempio?
Un posto importantissimo – per noi fondamentale come Bande A Bonnot – è stato il Blitz (in zona Colli Aniene, NdR), realtà autogestita estrema molto connotata politicamente, dove facevamo un sacco di concerti.

E poi c’era il Sisto, nato quando ci fu la divisione in due di Alice nella Città in Brancaleone e, appunto, Sisto; in realtà facemmo molti concerti punk anche nel primo Brancaleone – Red Alert, tre volte Melt Banana, Nabat, Locust… Ma qui siamo già nel ‘96; c’era poi il Break Out a Primavalle, dove c’era una programmazione decisamente hardcore, come anche al Garage di Piazza Sonnino, dove si riuniva la scena hardcore il sabato pomeriggio. Io ero un po’ legato a tutte e avevo magari qualche preferenza connessa più alla logistica: mi è sempre piaciuto fare le cose fatte bene, non è che siccome sei una realtà autogestita devi fare le cose a cazzo di cane.
Il discorso sulle realtà autogestite credo sia il punto di incontro fra l’aspetto politico e quello umano.
Ho sempre avuto un atteggiamento molto chiaro, ho sempre cercato di collaborare il più possibile con le realtà autogestite, ma senza precludere i club, perché alla fine credo che gli stronzi li puoi trovare dappertutto. Il cuore e la mente però tendono a farmi lavorare con le realtà autogestite, che oggi a Roma sono meno numericamente ma più preparate dal punto di vista professionale. Io mi trovo benissimo con La Strada, che è il mio posto del cuore, ho iniziato a lavorarci a metà anni 90 e collaboriamo molto bene ancora oggi, sono perfettamente organizzati e la cosa che mi piace tantissimo è che ho visto il susseguirsi delle generazioni, tutto il rinnovamento, e l’atteggiamento che hanno le nuove generazioni è impeccabile come quello di chi c’era prima, la condotta è la stessa. Ci capiamo in pochi minuti. Purtroppo, non c’è più questo rapporto con il Forte Prenestino, che ci ha aiutato tantissimo a crescere con la Bande A Bonnot negli anni 90, ma a cui anche noi abbiamo dato tanto in quel periodo.

Cos’è cambiato rispetto agli anni 90 per quanto riguarda il pubblico?
Si riusciva a calamitare maggiormente le generazioni più giovani. Credo, anche per via di internet, che siano cambiati i rapporti, la socialità, il modo di cercare la musica, di capire e leggere gli eventi, di fare politica… Negli anni 90 il concerto dava la forma all’evento, ma prima c’era l’aspetto politico, che era predominante. Il concerto era una cosa in più, si pensava: viene Manu Chao, nome importantissimo perché fa politica, verranno tante persone e potremmo diffondere il verbo con più efficacia. Che poi, non tutti gli spazi e non tutta la scena erano politicizzati. Nei primi anni 90 c’era un posto come Torre Maura, che si poneva come riferimento per la cultura antagonista, anarchica, si occupava di un certo tipo di hardcore e crust alla Discharge, più politicizzato. L’altro tipo di hardcore, quello da intrattenimento che verso metà anni 90 faceva parte di una sorta di revival, non aveva nulla a che vedere con la militanza, si parlava soprattutto di nuova immissione di alcuni gruppi sul mercato. Ora che ci penso, in quegli anni organizzammo anche dei concerti al primo Circolo degli Artisti, quello a Piazza Vittorio, con Agnostic Front e Cro-Mags. Per quanto mi riguarda, mi identificai parecchio con un tipo di hardcore italiano un po’ emo, quello dei Concrete, per intenderci.
Negli anni 90 il concerto dava la forma all’evento, ma prima c’era l’aspetto politico, che era predominante
E invece, relativamente al rapporto tra scene e spazi, quali sono le diversità rispetto agli anni 90, secondo te? A prescindere dall’hardcore, dai tuoi racconti ho come la sensazione che allora ci fosse più interazione tra le varie realtà.
Negli anni 90 c’era un crocevia di realtà, posti e persone che si accavallavano. Oggi credo che a Roma ci siano ancora parecchie cose e di qualità – la programmazione del Monk è di alto livello, ma ancora più eccezionale è il lavoro del DalVerme: la qualità è ottima, il lavoro che fanno i ragazzi è con lo spirito DIY giusto e senza preclusioni per i generi, poi c’è una persona come Claudia (Acciarino, NdR) che apprezzo molto per come si approccia al lavoro. Tiro giù il cappello anche rispetto al lavoro del Sinister Noise. La grande diversità con gli anni 90 è che allora era un mondo ibrido, oggi è tutto molto più separato: chi si vuole sentire il punk va da una parte, l’oi! da un’altra, il noise e il garage ancora da un’altra. Ce n’è per tutti, ma la divisione ha diminuito la curiosità, la possibilità di scoprire cose nuove… Questa fame – come dico io, il fatto di stare a cazzo dritto per un po’ – serve per capire soprattutto quello che manca, visto che negli ultimi tempi c’è stato servito tutto sul piatto d’argento.
Facciamo di nuovo un passo indietro. L’esperienza con la Bande A Bonnot a un certo punto finisce e passa il testimone a Hellnation, realtà – che è limitato definire semplicemente “negozio di dischi”, e non solo perché è anche un’etichetta – di riferimento assoluto per la scena punk/skin/hardcore a Roma. Ci racconti come è avvenuto questo passaggio?
La Bande A Bonnot chiude nel giugno del 1997, quando scappo di nuovo, stavolta da Roma – in quel periodo litighiamo tutti tra di noi e tutti contemporaneamente con le nostre donne! Torno a Pescara e per un po’ mi rimetto a fare il gelataio. Dopo sei mesi sono di nuovo a Roma e trovo la sede di Bande A Bonnot sfitta, quindi faccio una proposta di affitto al proprietario e, con grande fortuna, mi riprendo le chiavi del negozio. È a quel punto che nasce Hellnation, il negozio ma anche l’etichetta, che oggi gestisco con la mia compagna Alessia. Quando ho riaperto sapevo cosa fare e cosa non fare. Sapevo di dover gestire l’etichetta in maniera diversa, senza cercare di essere espansionista: non investire più di tanto, avere più prudenza, che è quello che ci ha fregato con la Bande A Bonnot. Sono riuscito a riaprire con soli 5 milioni delle vecchie lire – soldi che avevo guadagnato in gelateria e che ovviamente ho ributtato subito nella musica – perché avevo dei contatti che mi avevano permesso di fare un po’ di catalogo con due spicci.

Come hai impostato il negozio? Sei sempre stato un riferimento per la scena punk/hardcore, ma io ricordo di aver comprato tanta new wave da Hellnation…
Beh, sapevo di non potermi permettere un vasto assortimento di dischi, perché le possibilità erano quelle che erano e pure la clientela non è mai stata troppo estesa. Quindi fin dall’inizio ho deciso di impostare il negozio mettendo i dischi che piacciono a me, ovviamente con un occhio anche a quello che succede nelle sottoculture, nella scena. Cerco di dare a chi viene qui dei consigli, quasi mai ordino dischi su internet ma cerco – nei limiti del possibile – di indirizzare la clientela. Poi questo è soprattutto un posto dove le persone si incontrano, dove c’è scambio di idee, organizzazione di concerti, molte presentazioni di libri.
E poi ci sono le magliette, anche quelle estremamente caratterizzanti per quanto riguarda la scelta delle stampe.
Sì, lì è un discorso legato a una mia forma di romanticismo, una personale passione per un certo tipo di grafiche.
Hai attraversato fasi diverse, con Hellnation?
Certo, e ho anche avuto dei grossi dubbi se continuare o no – nel 2000/2001 ho provato a rilanciarmi con l’etichetta, ma il negozio non andava come doveva andare, quindi ho provato ad aprirmi musicalmente, anche a sonorità afro, ad esempio. Finché non ho deciso di impostare il negozio attraverso l’etichetta, e non viceversa, iniziando a occuparmi di sottoculture, quelle che sentivo più vicino – il punk, il movimento skinhead. Anche con l’etichetta, che è partita subito nel 1997 quando ho riaperto come Hellnation, ho fatto degli errori mostruosi, facendo uscire una serie di dischi senza ragionarci troppo. Ma sono stati tutti dischi a cui ero legato più per aspetti umani che per altri ragionamenti, magari di vendita. La prima uscita fu un album degli Yuppie Flu, poi Student Zombie, Notorius, dischi che hanno venduto ma che comunque erano soprattutto dischi del cuore. Eravamo amici e ci si dava una mano. Poi piano piano ho deciso di indirizzare l’etichetta verso una scena che mi interessava sempre di più, quella delle sottoculture – il movimento skin, quello oi!, ma anche la new wave – e in generale gli aspetti più underground di quelle scene musicali.
Cos’è che ti appassiona in particolare della sottocultura skinhead?

È una sottocultura strana, ci sono gli stereotipi legati al modo di vestire o a certi cori, ma restano dei valori importanti, dall’aspetto della cultura di strada ai principi di militanza politica – l’antifascismo e l’antirazzismo -, o l’apoliticità intesa come odio verso i partiti. C’è anche l’aspetto musicale che mi piace, l’interesse per il rocksteady o il primo oi!: c’è stato una specie di loop nella mia vita, per cui ha ripreso a interessarmi quel genere di musica che ascoltavo da giovane, ma anche perché le radici della scena skin sono molto nel rhythm and blues e soprattutto nel soul, che forse è più di tutte la mia musica. In Francia ho avuto l’opportunità di vedere i Jam a 18 anni e per me è stata l’illuminazione.
E dal punto di vista socio-culturale, rispetto alla presa che continua ad avere ancora oggi sui ragazzi?
Lavorando e organizzando i concerti ho notato il dinamismo della scena skinhead, anche in rapporto ai numeri – non tanto come remunerazione economica, ma proprio per il fatto che ai live ci vadano sempre 2/300 persone. Mi ha affascinato tantissimo come ci fossero così tante persone a un concerto di musica oi!: ragazzi che sopportavano quel tipo di musica, che compravano i dischi e i libri. Sono rimasto sorpreso da questa partecipazione anche fisica ai concerti, da questo aspetto violento-non violento.
L’interesse per la scena skin, a quanto mi sembra di capire, è però (ri)esploso a un certo punto della tua vita. C’è stato qualcuno o qualcosa che ti hanno dato modo di avvicinartici nuovamente?
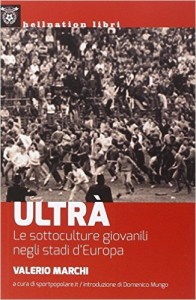
Il mio grande maestro è stato Valerio Marchi, i suoi libri e la Libreria Internazionale di San Lorenzo, fondata da lui. Erano già cose che mi appartenevano a 14/15 anni, il movimento skinhead lo seguivo già in Francia, ma le ho ritrovate 30 e passa anni dopo, anche attraverso le grandi affinità tra quella cultura di strada e gli scritti di Valerio Marchi – Teppa, Ultrà, tutti libri che ho ristampato con la mia casa editrice. Quel mondo lì era poi molto vicino a quello del calcio underground, che mi ha sempre appassionato: non mi ritengo solo un ultrà del calcio ma anche della musica, ho sempre tifato esageratamente e mi è costato pure molto – anche per questo mi sono state appiccicate delle etichette, tipo «Quello è l’amico degli skin». Ma del resto è una scena che mi ha sempre affascinato, soprattutto negli ultimi 5/6 anni.
Secondo te, a Roma, quali sono stati i luoghi di riferimento fondamentali per la scena skinhead?
La Strada è stato il palcoscenico fondamentale. Per me, tutto è cominciato lì nel 1995, quando con Bande A Bonnot organizzammo il concerto di Nabat, The Stab e Ghetto 84: fu il primo legame con la scena, dopo il quale ci trovammo a stampare il disco dei Nabat e di Classe Criminale. A quel punto mi sentivo legato a quella scena e quella gente lì, c’era una simbiosi umana molto forte.
Capita che qualcuno di più giovane si affacci in negozio?
Raramente, ma ogni tanto capita. Qua dentro ho visto gente crescere…
Te lo stavo per chiedere: sono abbastanza certa che molte persone che hanno ancora un legame forte con la musica siano cresciute qui. Mi fai qualche nome?
Damiano dei Payback, che ora vive a Siena, ha una famiglia, è diventato uno dei migliori serigrafi in Italia e di cui continuo a stampare i dischi; Paolo Petralia, cantante dei mitici Colonna Infame, ed ex-Comrades, boss di SOA Records, oggi cuore e mente dietro il ristorante vegano So What? e che ho aiutato, nel 2010, a pubblicare il libro Vegan Riot: Paolo è una persona con cui ho un rapporto che va oltre l’amicizia, è davvero un rapporto speciale; e poi Zerocalcare, è cresciuto qua, veniva a prendersi i suoi dischi e io lo prendevo continuamente per il culo sui suoi disegni… E poi! Ancora oggi è un appassionato di punk e ha anche disegnato le copertine per alcuni dischi che ho pubblicato con Hellnation. E poi anche Davide del Traffic… Tutte persone che ho visto crescere e diventare uomini.

Gli sforzi sono raddoppiati, qua non ho un orario di negozio, non è che attacco alle 10 di mattina e chiudo all’1 e poi riapro nel pomeriggio. Qua stai sempre a lavorare, dalle 8 di mattina alle 8 di sera: non ho pausa, preparo i pacchi, seguo l’etichetta, l’avvento di Internet ha abbreviato i rapporti coi clienti – Amazon ha creato questo mostro per cui fa avere le cose in un giorno alle persone, quindi anche io devo riuscire a far avere ai clienti il disco di Bull Brigade in un giorno. Devi stare sempre sul pezzo, ad esempio per me Facebook è un mezzo potentissimo che uso molto, ma d’altra parte continuo anche ad essere favorevole all’attacchinaggio. Uso tutti i mezzi che ho a disposizione, eccetto il cellulare che ancora non ho. Per quanto riguarda i formati, il cd e il vinile hanno convissuto da sempre, il vinile non è mai sparito perché è da sempre il mio formato preferito, ma non ho niente contro il cd, anzi penso che ci sarà un ritorno. E ti dirò di più, in questi giorni escono anche le prime ristampe in cassetta, i 666 con Perché In Fondo Lo Squallore Siamo Noi, con le cover degli 883, cose vecchie di Colonna Infame, e poi ho deciso di ristampare in cassetta una compilation di Rough Trade che vinsi alla radio in Francia – sentivo la radio tutte le sere, con mio padre che diceva che dovevo andare dietro alle ragazze invece di ascoltare sempre quella cazzo di radio.

Che musica ascolti in questo periodo?
Ho recentemente completato la mia collezione di dischi di Joni Mitchell di cui sono molto fan, come anche di Judee Sill, una cantautrice folk morta di overdose negli anni 70, l’artista outsider del giro CSN&Y. Mi ascolto ancora tanto garage, ma pure Alan Vega e i Lounge Lizards, di cui sono super fan.
Dacci qualche dritta di musicisti new wave e punk francesi che ami.
Kas Product e Marc Seberg. Per il punk, Dogs, che ascolto ancora parecchio, Bijou, band pop punk, e poi Starshooter, Olivensteins e Charles De Goal.
Parlaci dell’etichetta. Come scegli i dischi e i gruppi da pubblicare?
I gruppi sono scelti un po’ come tutto il resto, l’aspetto umano è quello che viene prima di tutto, e poi quello musicale – ci tengo che il gruppo registri bene, che la grafica sia curata. Ho deciso di fare una cosa un po’ all’inglese: in Italia c’è la tendenza a fare tutti tutto, mentre in Inghilterra quello che hanno in più è la divisione dei ruoli: il grafico che fa il grafico, il promotore che fa il promotore, e via dicendo. E comunque, oltre all’aspetto musicale, ci deve essere la scintilla: per gli ultimi dischi che ho fatto – Dalton, Gli Ultimi, lo split a tre fra Filippo Andreani, Pat Atho e Zerocalcare, Plakkaggio – è andata così. Se siamo amici è molto meglio, faccio fatica a fare un disco con persone con cui non c’è affinità, che non guardo in faccia. D’altra parte, mi sono scottato parecchie volte anche con l’etichetta, lasciando fare ai gruppi quel che cazzo gli pareva. Ancora oggi, comunque, a Hellnation non ci sono contratti, si chiude con una stretta di mano. Ai gruppi non mi permetto di chiedere mai soldi e concedo sempre il 10/15% delle copie. L’unica cosa è che registrino per conto proprio, anche se io ho comunque una preferenza, lavoro molto bene con Valerio di Hombre Lobo, secondo me è la migliore orecchia che abbiamo a Roma. L’etichetta sono abituato da anni a portarla avanti così, è come se ci fosse uno stampino Hellnation. L’aspetto umano toglie molti problemi, poi inutile illuderci di farci dei soldi, ci rientro perché le copie si vedono, ma non faccio molto di più.

Ci sono delle etichette che sono state di riferimento nei 90 per te? E quali sono quelle che oggi apprezzi di più?
Chiswick per il punk, New Rose e Closer in Francia, vicine anche ai suoni new wave, poi ovviamente ci sono state Dischord e Alternative Tentacles agli inizi, anche se poi hanno avuto un calo. E poi oggi Soul Jazz per me resta sempre Soul Jazz: anche se è un po’ sputtanata ha fatto un gran lavoro di ricerca. Sono un grande fan anche di Analog Africa, che si occupa di afro funk e ricerca sul territorio. Mi piacciono molto le ristampe di Marco sul punk.
Marco Sannino di Radiation Records?
Sì.
Qualcuno potrebbe pensare che ci sia competizione, e invece…
Macchè. Marco di Radiation ha un grande negozio di dischi, sono tutte persone che si danno tanto da fare e con cui collaboro molto. Non c’è concorrenza ma amicizia e rispetto reciproco, ho un’ammirazione per come ha portato avanti il negozio e l’etichetta, ha divulgato il verbo in maniera magistrale, secondo me è il migliore negozio di dischi che abbiamo in Italia. Collaboriamo perché quando Marco stampa un disco di oi! me ne dà parecchie copie per distribuirle e viceversa, quando io stampo un disco di un certo tipo chiedo a lui una mano. Siamo due realtà impostate in maniera diversa, lui sta molto di più sul pezzo, e poi siamo in zone diverse. Hellnation è più uno spazio anche di ritrovo… E poi io mi devo confrontare con un altro tipo di persone, ho addirittura avuto un blitz di gente di Casapound. Questo è un altro tipo di quartiere, diciamo che sto un po’ più sulla strada, ma non lo dico per vantarmi.

Abbiamo citato un altro importante negozio di dischi a Roma, quindi direi che è ora di parlare del Record Store Day. Se non ricordo male tu sei stato il primo a Roma a cominciare a celebrare questa “festa”, che oggi ha preso decisamente una piega un po’ più commerciale, con la corsa alle edizioni limitate…
Sì, il Record Store Day è nato nel 2007 negli Stati Uniti e in Inghilterra e io credo di essere stato il primo, l’anno successivo, a Roma. La dritta me la diedero Flavia e Francesco di Radiorock.To, una web radio che aveva lo studio nel soppalco del mio negozio. Sai, a me piace molto organizzare le cose qui dentro, quindi ho subito preso iniziativa. Il Record Store Day, quello della festa e non delle edizioni limitate che finiscono su Ebay, è molto vicino alla mia visione sia di negozio di dischi – con incontri, concerti, presentazioni di libri – sia della mia vita in generale… Il fatto di stare con i gruppi, quel tipo di socialità. Mi piaceva molto l’idea, quindi ho pensato: proviamo a fare questa festa qui dentro, a parte per i numeri e il ritorno economico, mi sembrava anche un modo divertente per far conoscere il posto e quello che fa – in generale non sono un esperto di marketing, mica sono un comunicatore pazzesco come Davide Caucci! Che poi all’inizio avevo intuito e seguito tutta la storia delle uscite esclusive per il Record Store Day, ma è un aspetto che poi negli anni è degenerato completamente, tanto che poi l’ho abbandonato facendo uscire io i miei dischi ad hoc per il RSD.
Cosa farai quest’anno?

Stamperò in cd la compilation Kick Off che raccoglie i cori da stadio, la cassetta dei 666 che rifanno cover degli 883 in chiave hardcore, regaleremo i poster di Daniela di Plutonium Baby, che farà anche una mostra di poster, intitolata, “Fake Paintings: Psychic powers” e poi ci sarà il live di Rock’n’roll Suicide. È un evento che faccio da tanti anni ormai, non è un evento di mero commercio, si lavora bene, certo, però cerco anche di creare una bella situazione. E poi, per l’occasione, ho anche ordinato apposta due pacchi della Soul Jazz!

Prima hai citato Davide Caucci di Bomba Dischi. C’è qualcosa, in particolare, che non sopporti delle scene indipendenti italiane?
Quello che mi dà più fastidio è l’accostamento di alcuni nomi del cantautorato italiano ad alcune sottoculture completamente diverse, ho sentito paragoni come «Il Bob Dylan dei Noantri»: lo trovo irriguardoso. Trovo assurdo anche il modo in cui è percepita la scena di Roma Est, vissuta dall’esterno come un evento culturale enorme, cosa che non è. Detto ciò, massimo rispetto per i locali e le persone di quella parte di Roma che lavorano molto bene. Quello che non mi piace sono certi accostamenti, i paragoni fuori luogo. Considerati i numeri, anche di alcuni exploit in ambito indie, giù il cappello a chi è riuscito a trasformare un prodotto di bassa qualità in oro. C’è sicuramente un discorso di comunicazione azzeccata, ma sono fenomeni che mi fanno quasi paura, credo che musicalmente ci sia un impoverimento spaventoso e letale, perché c’è un meccanismo di immedesimazione in qualcosa che trovo povera di contenuto. Capisco l’immedesimazione, le persone si stanno immedesimando nelle canzoni dei 666 che fanno le cover degli 883, ma per me si ferma lì, è uno scherzo. Io gli 883 non li avevo mai sentiti, non me ne frega un cazzo di Pezzali, ho iniziato ad apprezzarli perché loro ne hanno fatto le cover metal e hardcore.

A proposito delle sottoculture di cui sopra, tu hai un’altra passione con un forte attaccamento alla sua manifestazione più underground: il calcio.
Ho sempre giocato a pallone, fino a 26/27 anni. Ho iniziato a seguire il Castel di Sangro, la mia squadra del cuore, il giorno in cui mi sono lasciato con la mia ex, nel ’97: andai a vedere i play off e iniziai con una grande vittoria. Il legame era in primo luogo con le radici, il paese dei miei è a 10 chilometri da lì. Ho iniziato a seguire la squadra fino a diventare uno dei capi ultrà, un seguace fisso, ho fatto qualcosa come 50 trasferte da solo, e ho anche rilevato la società insieme ad altri ultrà: abbiamo fatto una forma di azionariato popolare, che è una delle cose che mi appassiona di più, tipo Atletico San Lorenzo. Siamo stati i primi a farlo – noi, Lebowski e Ardita San Paolo, con cui siamo gemellati. Il calcio ha sempre fatto parte della mia cultura, mi piacciono anche molto i cori – non è un caso che abbia pubblicato una compilation a tema, Kick Off, che ti menzionavo prima. Anche con la casa editrice, Hellnation Libri, mi occupo molto di sottoculture e calcio, calcio e politica, calcio e socialità. Mi sento vicino a 3 squadre: Castel di Sangro è quella del cuore, poi il Torino – scelta fatta perché mio padre era della Juve – per la serie A e infine l’Arsenal – per colpa di Nick Horby – per il calcio internazionale.

Il binomio calcio e musica è un po’ snobbato in Italia ma ha una lunga tradizione in Inghilterra, dove molte band o appassionati di musica non nascondono il proprio interesse per il pallone.
Sì, è un binomio molto inglese e lo legherei parecchio anche al mondo di Nick Hornby, quell’affinità che c’è in generale tra sottoculture e musica, se pensi anche tra cori e calcio. Ora sono di più le persone che si interessano di calcio, è anche esploso quello popolare, si tifa… Ma nel 1994, chi si occupava di sottoculture, politica e musica come noi e contemporaneamente tifava e seguiva il calcio era visto malissimo dai compagni. Ma è una cosa che io mi porto dietro dalla Francia, seguivo una squadra di operai, il Sochaux. Credo ci siano molte similitudini e, di recente, è stato fatto un grande lavoro di unione tra musica e calcio da Cass Pennant, mitico ultrà del West Ham. Ultimamente ha anche presentato al Sally Brown di San Lorenzo un documentario sullo ska.
Questa unione tra calcio, sottoculture e musica la stai attuando praticamente con la casa editrice. Ce ne parli?
La casa editrice è stata un po’ il risultato di un periodo di stagnazione musicale, risalente a qualche anno fa. La condivido con Cristiano Armati di Red Star Press, che ha inglobato Hellnation come casa editrice sussidiaria: lui sì che è un editore vero! Sono sempre stato un appassionato di libri, in negozio ce ne sono sempre stati tanti e io stesso sono un grande lettore, anche di giornali – pensa che oggi mi sono abbonato a Rivista 11 e sono pure abbonato a D’Abruzzo, sulle sottoculture abruzzesi tradizionali!

Prima che l’etichetta tornasse a essere più vivace c’è stato un periodo un po’ di stanca, e avevo voglia di ripubblicare dei titoli fondamentali di cultura skinhead che erano andati persi. I libri di Valerio Marchi in primis, e poi testi nuovi di giovani, anche che facevano delle tesi sulle sottoculture skin, come il libro di Ruggero Daleno, Essere Skinhead, e quello di Federica Paradiso, Le radici della rabbia, prima ragazza che si occupa della scena skin, notoriamente un po’ maschilista – quando abbiamo fatto quel libro l’idea era proprio pubblicare qualcosa con un punto di vista diverso. Abbiamo pubblicato un libro sugli ultras della Spal, poi Lontano da Highbury di Luca Frazzi, che parla di musica e di quest’annata incredibile dell’Arsenal, un testo di cui mi sono innamorato. Ho pubblicato Ragazzi di Strada, di Augusto Stigi detto “Il tedesco”, che racconta il periodo di Centocelle, un libro pazzesco pure dal punto di vista storico. Anche per la scelta dei libri deve scattare la scintilla, ma credo che su queste scene ci sia ancora molto da ricercare. Il mio sogno sarebbe pubblicare i testi di Philippe Garnier, il miglior critico rock francese. L’ho incontrato di persona al festival letterario di John Fante, quello che fa a Torricella Peligna, pure lui è originario dell’Abruzzo e il paese è a pochi chilometri da casa dei miei. Andai con una pila di libri da farmi autografare. Garnier è un grande giornalista, quella volta mi prese per pazzo ma sogno di pubblicarne i libri tradotti. Prima o poi.




