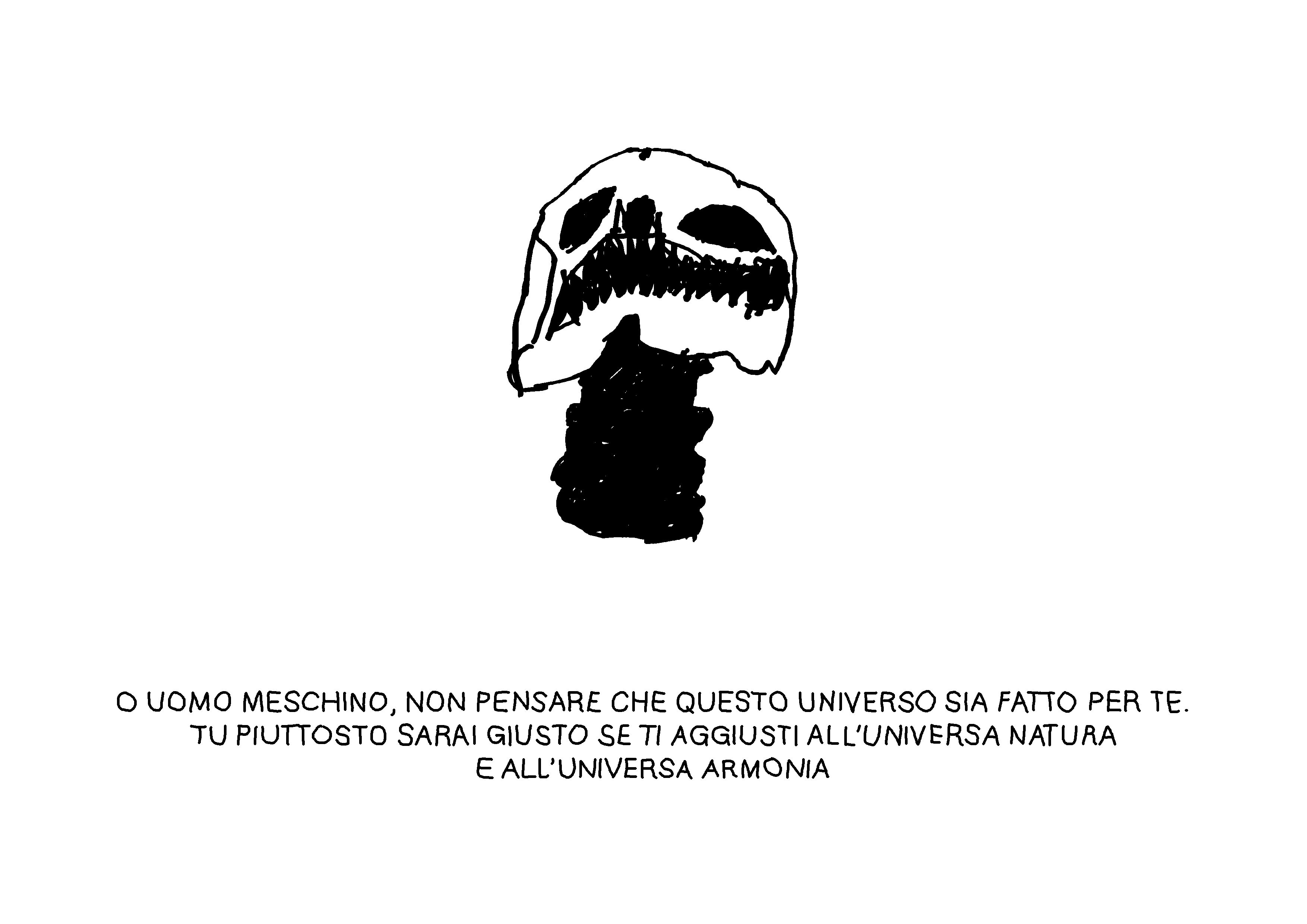BAMBINA
Sette di sera. Sento la figlia della vicina gridare, urlare di gioia. La sua voce arriva chiarissima, e mi sembra quella di sua madre quand’era bambina, che giocava con sua sorella nel giardino della loro casa, ed era per me il segnale che potevo andare a giocare con loro. Sono come sovrapposti i tempi storici in quarantena, come diluiti dentro a un liquido magico. Resto a guardare i pezzi del lastricato davanti alla casa di mia madre, lastre che hanno le forme delle regioni d’Italia, così come le ho imparate io, disegnate, colorate, isolate alla scuola elementare. Questa sembra l’Emilia Romagna, terza regione per numero di contagi, questa il Lazio, questa sembra la Sicilia. Ma sono messe tutte in un altro ordine, che non è quello geografico. Sono tutte appiccicate, le regioni, si toccano tra di loro, come se il mondo, finalmente, fosse di nuovo uno, e la tettonica a placche avesse compiuto il suo corso. Fisso la crosta terrestre ricompattata sul portico di mia madre, possiamo finalmente affrontare questa cosa del virus in maniera globale, possiamo essere uniti veramente, senza le ridicole bandiere, senza questo spirito medievale che ci fa comportare come piccoli feudatari. La voce della bambina dall’altro lato della strada mi risveglia, come fa la civetta di notte, torno in me e cerco il bambino per poterlo lavare, per convincerlo a darmi un bacio, trattarlo come un piccolo giocattolo che mi sono fabbricata per passare il tempo durante questa quarantena. Insegnargli a fare piccole smorfie, come fosse un pupazzo, una scimmia del circo. Gli dico: Felice! E lui sorride inclinando la testa da un lato. Triste! E lui fa il broncio. Tifoso! E lui alza le mani esultante. Scelgo nello spettro delle possibilità le più sceme. Lo uso, lo plasmo, lo porto dove dico io.
Sono una bambina cattiva in quarantena, lo vesto e lo svesto, gli metto addosso collane e cinte, magliette enormi e occhiali da sole, gli taglio i capelli, tutti storti.
Forse per questo a volte il bambino si confonde, chiama mia madre Mamma, e lei gli dice: Dimmi amore. Persino mia nonna risponde al bambino che la chiama Mamma. In questo tempo distorto, scrivono gli esperti, regrediamo tutti, e così fanno pure mia madre e mia nonna, che si godono un bambino piccolo che le chiama ancora una volta così. Così io, alla maniera dei bambini non so se posso offendermi o no, quindi prendo il bambino per mano, anzi per il braccio, e lo porto via, mostrando a mia madre la mia sofferenza costruita, la mia sofferenza costruita per fargliela vedere, così come i figli amano fare coi loro genitori. Io e il bambino ci allontaniamo, come la bambina del circo con la sua scimmia. Poi le voci della bambina della vicina non si sentono più. Ora di fare il bagnetto, poi ora di cena, e finita la cena ci mettiamo nel letto di mia madre, che spegne la luce e ripete a me e al bambino la sua storiella: Ora zitti tutti, perché ho visto che qui davanti sono tornati quei cinghiali molto cattivi. Vengono qui davanti alla finestra e vogliono entrare dentro, vogliono mangiarci. Vanno in giro tutta la notte a cercare qualcuno da mangiare. Andate via, cinghiali! Il bambino ride, poi ammutolisce, infine si addormenta.
Il mattino dopo
sul prato di brina
una testa di pecora.
CIVETTA
Si dorme male, nei giorni del virus, siamo tesi. Passato più di un mese dormiamo come accampati, dentro a letti che ci fanno da tana. Il bambino si gira e si rigira, punta i piedi sul lembo delle coperte, e ci scopre, come fanno i bambini. Si toglie i calzini, come fa suo padre. Io gli passo un lungo elenco nell’orecchio: il cane dorme, il gatto dorme, le galline dormono, i pesci dormono, la mucca dorme, i bambini dell’asilo dormono, Flaminia dorme, Giulia dorme, Samuele dorme. La mia voce si fa sempre più debole, il suo respiro più regolare.
Siamo talmente vicini che col labbro inferiore sento la cicatrice che ha sotto al mento.
Durante il virus si può arrivare in luoghi sconosciuti, percepirli dentro agli spazi minuscoli delle nostre esistenze. Intimità, sento il silenzio di tutte le cose presenti sulla terra. Poi una volta addormentato prendo il bambino e lo metto nel lettino da campeggio, che teniamo a casa di mia madre per i weekend in campagna, per le vacanze estive. Io mi ristendo, i miei muscoli come scomparsi dentro al mio corpo dopo tante lezioni di yoga pagate ma perdute. Il letto di mia madre è troppo molle, e affossato al centro, mi fa come rotolare verso l’interno. Dormo sul lato destro, il lato che ha sempre occupato mia madre prima che mio padre morisse. Cerco di non rotolare, resisto alla forza centrifuga degli eventi della mia famiglia. Chiudo gli occhi e ripeto il sutra dentro di me: il cane dorme, il gatto dorme, le galline dormono. E nonostante io lo reciti con devozione non riesco a tenerla lontana, perché canta la civetta, e sbarro gli occhi. È un verso come di lattex, allungato, elastico e cupo, di plastica inquinante. È un mostro cosciente di certi racconti popolari, che porta sempre male. Si apposta davanti alla finestra del disgraziato e canta di notte, annunciando la sventura imminente. Poi insieme a tutti gli altri animali pure la civetta si addormenta, o comunque tace, e io abbasso le palpebre nel mio giaciglio.
LA CUPA
La notizia della morte di Alfonso viene iniettata di cellulare in cellulare. Si è impiccato dentro casa sua, anche perché pur volendo non si poteva uscire. Mia nonna dice, come chiudendo un cerchio nell’aria, che il padre di Alfonso s’era impiccato al cancello del cimitero. Bonanima, sancì mia nonna. Alfonso invece si è impiccato in una casa che si era fatto costruire lui, una sorta di enorme chalet decontestualizzato, vicino alla chiesa di Sant’Antonino, di cui era devoto con quella devozione che hanno le persone che hanno accumulato una grande fortuna. Aveva pagato, come pegno di riconoscenza, la ristrutturazione della fonte del Santo; lì si dice che Antonino di Pamiers sia passato, e in quel punto abbia fatto sgorgare una piccola fonte, per abbeverare il paese in un momento di siccità, in un punto che si chiama La Cupa. Alfonso pagava le bollette di quella sorgente, di quella fontana, e se passando lì davanti con la sua Lamborghini gialla la trovava spenta telefonava al diacono e s’incazzava di brutto. Lo ha trovato la signora che faceva le pulizie a casa sua. Appeso a una di quelle bellissime travi, in legno chiaro, disposte su ogni piano, che si intravedono anche dalla strada, perché l’ultimo piano è vetrato; si può vedere l’esterno dall’interno, e viceversa. Alfonso era uno dei migliori amici di mio padre, e ora lo raggiungeva, nel paradiso degli sconfitti. Mia madre seduta sotto la veranda guarda il bambino giocare ma senza guardarlo, lo fissa soltanto con occhi di vuoto, in un tempo in cui non riesce bene a ricordare come si piange chi se ne va, pensando a qualcosa che mi è proibito. Un territorio fatto di feste nelle case, nelle case degli anni Settanta, nelle case degli Ottanta, vini in bottiglie di plastica, abiti con le spalline, ombretti celesti su tutta la palpebra fin sotto alle ciglia, capodanni, carnevali, e poi compleanni dei bambini, assembramenti. Alfonso se n’era andato per un virus che esisteva solo dentro di lui, e probabilmente se ne sarebbe andato così comunque. Non per il contagio, non per l’isolamento, nemmeno per la solitudine. Ma andarsene così, come dicevano gli amici di cellulare in cellulare, senza aver lasciato messaggi, senza poter avere qualcuno intorno, almeno da morto.
Persino le riflessioni che ci si scambiava rimanevano appese.
La signora delle pulizie aveva aperto la casa con le chiavi che lui le aveva dato, quindi era entrata, aveva aperto subito le finestre, perché c’era un odore terribile. Poi erano arrivati i carabinieri, Piero la guardia, poi la moglie da cui era separato a intermittenza come avevano fatto anche i miei per anni, e infine Minnone a vestire il morto. Lo avevano portato direttamente al cimitero, nella chiesetta di San Francesco, dove sarebbe rimasto prima di essere seppellito per un funerale a cui nessuno poteva partecipare. Mia madre restava silenziosa attraverso le stanze, piegava vestiti e li disponeva in piccole pile sul divano, poi li sistemava dentro ad ogni cassetto, a voler rimettere a posto le cose. Vagava insieme ai fantasmi di un’epoca che finiva piano piano, che diventava più vivida nella sua memoria solo se un altro amico se ne andava. E Alfonso se ne andava così, senza neanche lo stupore che la morte richiede.
The Virus Diaries: prima, seconda, terza, quarta, quinta parte.