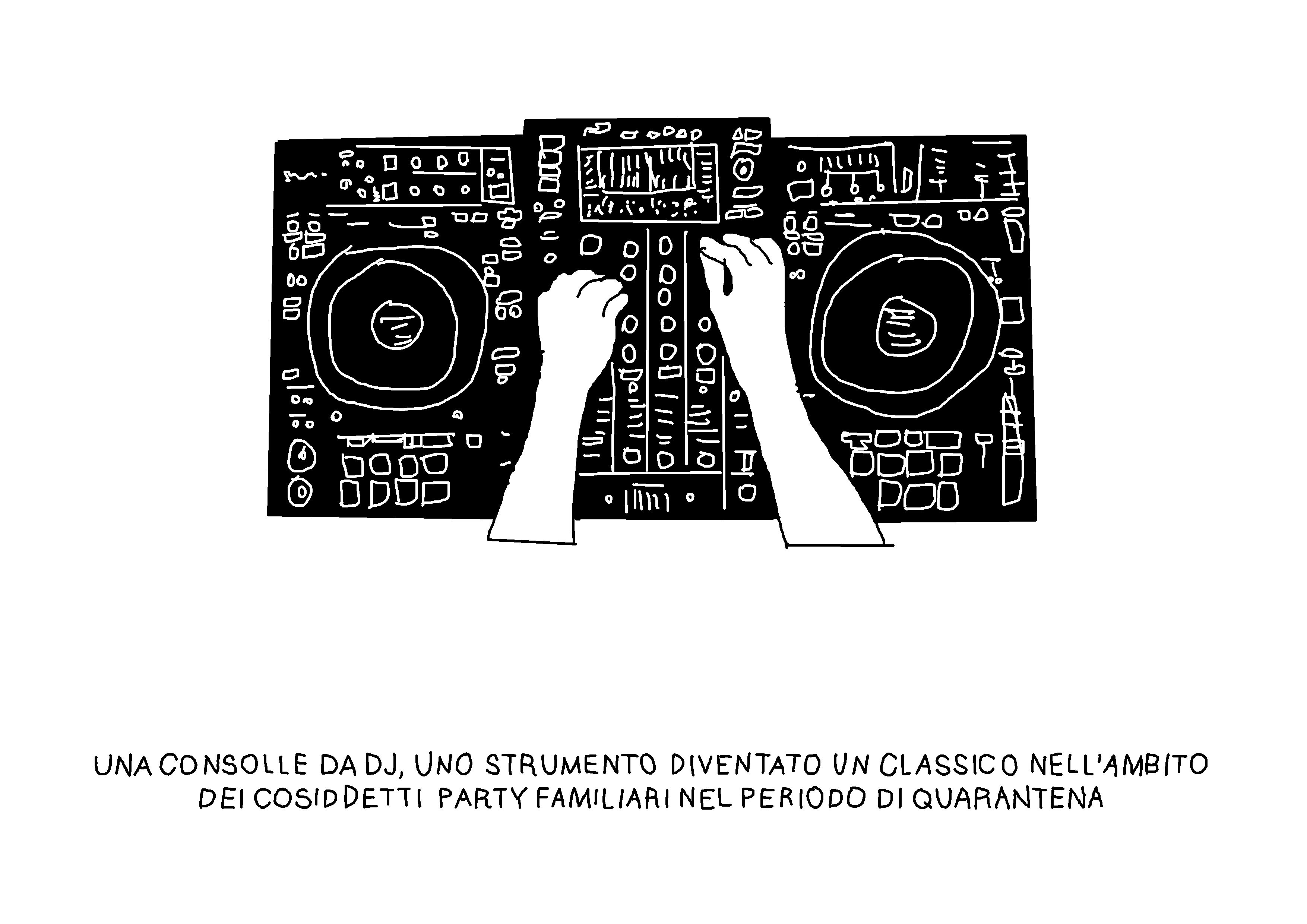ZUCCHERO
Una mattina Fratello 2 entrò in cucina dicendo Hello guys. E io non risposi. Con quello sancimmo che non ci saremmo più parlati. Questo succedeva dopo che lui aveva espresso dubbi sul far venire mio marito in campagna. Non avevo più voglia di parlare con lui, benché sapessi che in fondo i suoi dubbi fossero giusti, e pensassi francamente che quella non fosse una cattiveria, ma una forma di paura, legittima, che in quel periodo, soprattutto in quel primo periodo, tagliava gli angoli delle nostre coscienze, che poi a loro volta da quel taglio iniziavano a lacerarsi, ricordandomi mia nonna quando tagliava lenzuola per farne stracci. Fratello 2 amava mio marito, ma quel dire Io non voglio che venga mi faceva da un lato delineare in lui la rabbia per la lontananza tra me e mio marito, e dall’altro disegnare il mondo in cui viviamo, un mondo in cui la paura la fa da padrona gestendo come una locandiera gretta le entrate e le uscite, chi resta a dormire e chi parte, chi ha diritto a un piatto di minestra e chi perisce al freddo. Così io, con quella distanza calcolata, decisi di non parlar più a mio fratello, rivolgendomi a lui solo quando a tavola servivo la pasta, e con la sua scodella in una mano e il mestolo nell’altra gli dicevo: Basta? E lui rispondeva: Ancora un po’.
Lui invece, per parlare con me, mi mandava tracce a volumi consistenti, così, se mi ero messa i calzettoni di spugna sopra ai leggings, ascoltavamo per tutta la vallata la colonna sonora di Flashdance. Oppure se mi mettevo a lavare la macchina con l’idea di ripartire, tornare a Roma, infrangere la legge, sentivo alzarsi quella chitarretta riverberante con cui parte Manu Chau quando canta Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino, para burlar la ley.
Fratello 2 aveva organizzato durante la quarantena un live set a settimana, la domenica. La prima diretta l’aveva fatta dal giardino. Aveva sistemato blocchetti di cemento con sopra un tavolo, per avere la consolle all’altezza giusta. Aveva allungato prolunghe e fili vari, che a vederglieli tenere nella mano chiusa mi sembravano capelli di ragazza sgozzata.
Aveva sistemato la telecamera del pc in modo da inquadrare il paese arroccato, le fronde degli alberi, un pezzo di cielo, e lui stesso con la barba fatta, il cappello.
Le tracce che mandava erano quasi tutte di festa, una techno ribelle e cavalcante, niente bassi lugubri, niente casse insistenti, era tutto calibrato attorno a un pensiero vago e libero da pericoli, la sensazione che quella cosa sarebbe finita presto. Questa fu la prima diretta. La seconda la fece dentro, la telecamera puntata sui controller del mixer, dentro al peso di chi sta facendo una cosa spiacevole ma necessaria. La terza fu simile alla seconda, luci molto basse.
Poi nel weekend di Pasqua lo sentivo parlare in videochiamata coi suoi amici. I ragazzi si domandavano se non fosse meglio spostare la diretta al lunedì, il giorno di Pasquetta, quando ci sarebbe stata, almeno nell’immaginario, una sensazione di festa. Fratello 2, col suo schermo pieno di amici, erano al piano di sotto, al rustico, mentre io al piano di sopra leggevo La Cripta dei Cappuccini sul divano del salotto. Le loro voci mi arrivavano stanche, con lunghe pause tra un intervento e un altro, e io in quelle pause mi distraevo dal libro. Mio fratello aveva perso il suo lavoro e ora chiedeva se qualcuno avesse ancora 20 euro sulla Payapal, per comprare cinque o sei tracce. Bisognava unire le forze. Sentivo che fumavano tutti, a distanza, facevano lunghe tirate e lunghe sbuffate, e forse perché li conoscevo tutti e li conoscevo da quand’erano piccoli, e ricordavo le loro facce bambine, i loro caratteri che presenziavano già dentro ai corpi minuti degli uomini che sarebbero stati, ma io quel giorno più di tutto percepivo la stanchezza dei bambini che hanno ripetuto un gioco che gli era piaciuto, e che ora avrebbero voluto passare a un altra cosa, una qualsiasi, la sensazione di star lì a mangiare un dolce che a ogni cucchiaio diventa più stucchevole.
DIE KAPUZINERGRUFT
Venerdì santo apro un libro che avevo trovato nella villetta di mia nonna, tra vecchie sveglie e candele mai accese. Erano rimasti, uno sopra l’altro, sistemati da qualcuno che non aveva mai sistemato libri, cioè non in verticale ma in orizzontale, qualche vecchio volume di una collana che era uscita con la Repubblica negli anni Duemila, una collana di grandi romanzi del Novecento. Presi questo volumetto di Joseph Roth, che, in quella traduzione di Laura Terreni, iniziava così:
Il nostro nome è Trotta. La nostra casata è originaria di Sipolje, in Slovenia. Casata, dico; perché noi non siamo una famiglia. Sipolje non esiste più, da tempo ormai.
Trotta è un barone austriaco, è il 1938, l’impero Austro Ungarico, il solo mondo che egli conosca sta scomparendo davanti ai suoi occhi. Stanno arrivando i segnali di un tramonto, ancora lontano, ma lui non sembra volerli cogliere. È giovane, vive con sua madre, non ha bisogno di lavorare perché è una cosa abbastanza disdicevole per un nobile, e insieme ai suoi simili e pari vive una vita frivola, notturna, nei bar. Il capitolo V si apre così:
Ancora per un paio di giorni nella nostra gaia brigata si parlò di mio cugino Joseph Branco. Poi lo dimenticammo – ovvero: lo mettemmo in un certo senso temporaneamente da parte. C’erano da discutere e da apprezzare, le follie della nostra vita quotidiana. Il capitolo VI si apre così:
Prima di questo grande sfacelo…
Intanto Trotta si innamora, poi però ai muri viene affisso l’editto dell’imperatore, c’è la guerra. Trotta parte per il fronte, e la guerra non è quella cosa compatta e ordinata che si immaginava.
L’assillo per lui e per i suoi era di non avere tempo, il tempo di non poter godere lo spazio esiguo che ancora la vita ci lasciava, e nemmeno il tempo di aspettare la morte.
Il XIII capitolo inizia così:
Pensavo a Elisabeth. Avevo solo due pensieri in testa dacché avevo letto il proclama dell’imperatore: il pensiero della morte e il pensiero di Elisabeth. Ancora oggi non so quale fosse il più forte.
Benché leggendo – capitolo dopo capitolo, pagina dopo pagina, per tutta la giornata del venerdì santo – mi sentissi stanata, capivo che La Cripta dei Cappuccini non è un libro sulla guerra, e non è un libro sull’amore. È un libro su un mondo che se ne va, che si dissolve davanti agli occhi del protagonista.
Il XX inizia così:
Nei giorni seguenti, che ci stavano davanti enormi e gravidi di pericoli, tetri e solenni e misteriosi e sconosciuti, secondo le previsioni non c’erano da aspettarsi battaglie, ma solo ritirate.
Trotta sopravvive alle avventure, buffe e terribili, della guerra. Tornato a casa, a Vienna, trova un mondo diverso da quello che conosceva lui. Il XXIV capitolo inizia così:
Non avevo ancora nessun timore della nuova vita che mi aspettava. Come oggigiorno si dice, ancora non la “realizzavo”. Mi attaccavo invece a piccoli obblighi che di ora in ora mi erano imposti: e assomigliavo pressappoco a un uomo che, posto dinanzi a un’imponente scalinata che egli è costretto a salire, ritiene il primo gradino quello più pericoloso.
La prima notte la passerà nella casa di sua madre, il mattino dopo cerca Elisabeth. Ma Elisabeth stessa non è la ragazza che aveva lasciato, lui le manda dei fiori per annunciare il suo ritorno. “Tu mandi fiori. Perché non hai telefonato?” Gli chiede lei.
I borghesi si stanno prendendo gli spazi vuoti lasciati dall’aristocrazia, Hitler si sta accaparrando i territori di un’Europa vecchia e stanca.
Questo è l’incipit del XXVII capitolo:
L’inconsueto divenne per tutti noi la consuetudine. Era un precipitoso assuefarsi. Quasi senza saperlo ci adeguavamo con la più grande sollecitudine, anzi correvamo dietro a fenomeni che odiavamo e aborrivamo.
Cominciammo addirittura ad amare la nostra disperazione come si amano gli amici sinceri.
Anzi ci sprofondavamo dentro. Le eravamo grati perché inghiottiva i nostri piccoli affanni personali, lei, la loro sorella maggiore, la grande disperazione, che invero non cedeva a nessun conforto, ma nemmeno a nessuna delle nostre preoccupazioni quotidiane. Secondo me, si capirebbe e certo si perdonerebbe anche la spaventosa arrendevolezza delle odierne generazioni di fronte ai loro ancor più spaventosi asservitori, se si pensasse che è della natura umana preferire la grandiosa sciagura che tutto distrugge all’affanno particolare. L’immane sciagura inghiotte rapidamente la piccola disgrazia, la disdetta insomma. E perciò in quegli anni noi amavamo l’immane disperazione.
Trotta nell’ultimo capitolo è in un bar, anche per lui è venerdì. Avanza calzando stivali e speroni uno strano militare vestito in modo bizzarro. Dice che il governo è caduto, che ora esiste un governo popolare tedesco. Il barista spegne le luci, saluta Trotta con riverenza, e allungandogli una croce uncinata di piombo, gli dice: “Per ogni evenienza, signor Barone!” Trotta non sa che fare, esce, va verso la Cripta dei Cappuccini, che conserva le spoglie dei suoi imperatori.
Il XXXIV capitolo, l’ultimo, lo lessi mentre fuori dalla finestra il mio mondo scuriva, e si apre così:
Anche venerdì non vedevo l’ora che arrivasse la mia amata sera, nella quale soltanto mi sentivo a casa da quando non avevo più né casa né famiglia. Aspettavo dunque, come di consueto, di abbandonarmi alla sua protezione, che da noi a Vienna era più benevola del silenzio delle notti, dopo la chiusura dei caffé, non appena i lampioni intristivano, stanchi del loro vano risplendere.
The Virus Diaries: prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima, ottava, nona parte.